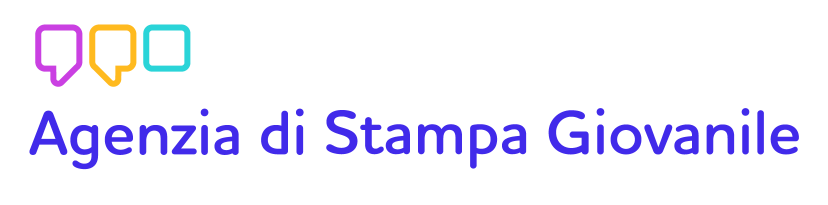COP28: Allevamenti intensivi e crisi climatica, quale relazione?
Vi siete mai chiesti quali siano i settori più energivori e impattanti per il pianeta Terra? Se tra le vostre idee c’è anche il settore zootecnico e agroalimentare siete già sulla buona strada. Per la quantità di emissioni rilasciate in atmosfera e per altri effetti sul degrado ambientale, queste attività rientrano a pieno titolo nella lista.
Di Federica Baldo
–
Come è giusto che sia, nei padiglioni della COP28 viene dedicato spazio anche alle discussioni intorno ad un grande tema: allevamenti e agricoltura intensivi.
La prospettiva di trattazione del problema che propongo in questo articolo riguarda le ripercussioni in termini di disastri climatici nel Sud Globale delle emissioni derivanti da questo tipo di attività.
Dunque, in che modo le emissioni prodotte dagli allevamenti intensivi aggravano gli squilibri ambientali e i disastri climatici nei paesi del Terzo Mondo? In un evento tenutosi alla COP28, sabato 2 dicembre, dal titolo “Unveiling industrial farming’s hidden climate destruction in the global south” sono stati forniti alcuni dati. Si è parlato di una stima di 8 miliardi di dollari di danni provocati nel continente asiatico, africano e in Sud America dal sistema di allevamento intensivo adottato nel nord del mondo.
Ingiustizia climatica e transnazionalità della crisi
Questo tipo di considerazioni rientrano nel più ampio e noto concetto di ingiustizia climatica. Questo paradosso ci descrive come le nazioni del Sud Globale, pur essendo coloro che contribuiscono di meno alle emissioni di gas serra, sono proprio quelle che subiscono per la maggiore gli effetti dei cambiamenti climatici dovuti ad esse. Sono i paesi impattati in maniera più grave ed intensa, condannati ad una ripresa faticosa e lenta, ma al contempo i meno responsabili e i peggio attrezzati ad affrontare la situazione, sia in termini di risorse economiche disponibili, sia in termini di infrastrutture e tecnologie. Come se non bastasse, gli stessi paesi hanno minore voce ai tavoli delle trattative internazionali.
La faccenda in questione non è annodata soltanto al sopracitato concetto di ingiustizia climatica ma anche a quello di transnazionalità della crisi climatica, vale a dire della scala globale su cui questo problema si estende, di fatto scavalcando i confini delle nazioni e non avendo limiti.
Ecco che fatte queste doverose premesse si riesce a comprendere meglio come pratiche climalteranti intraprese in determinate aree del globo finiscano per generare ripercussioni su altre zone.
Legame allevamenti intensivi-crisi climatica
Veniamo al dunque, l’agricoltura e la produzione alimentare sono associate a tutti e tre i grandi gas serra che conosciamo – la CO2, il metano e l’ossido di azoto – il cui ammontare, sempre stando a quanto riferito durante la conferenza, rappresenta il 20-30% delle emissioni globali annue. Ma non si tratta solo di emissioni, la produzione di cibo di origine animale contribuisce al degrado ambientale anche attraverso altre pratiche: la deforestazione (necessaria per fare spazio al foraggiamento del bestiame), lo sfruttamento di risorse naturali (per prima l’acqua) e la contaminazione di esse tramite il rilascio di sostanze di scarto.
È necessario che a questo legame sottostante il problema venga dedicato maggiore spazio all’interno della COP. Al di là di meccanismi come il Fondo per Perdite e Danni (sulla cui operativizzazione i leaders si sono pronunciati già giovedì 30 novembre) e che si basa sull’ottenere aiuto dal resto della comunità internazionale, l’Africa, per fare un esempio, dovrebbe essere messa nelle condizioni di poter utilizzare le risorse di cui dispone per sua natura per far fronte al problema. Purtroppo queste capacità e strumenti spesso lasciano il continente per spostarsi in altri paesi.
Africa
Nel contesto africano l’impatto che agricoltura e allevamenti intensivi del Nord Globale hanno sui proprietari agricoli indipendenti è considerevole. A differenza di quanto accade nei paesi più industrializzati del mondo che concentrano i propri metodi produttivi sulla massimizzazione dei profitti e sul dare risposta al consumo di massa, qui più dell’80% dei prodotti agricoli e animali è concepito tramite pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente. E ciò che risulta ancora più ingiusto è il fatto che siccità, alluvioni, eventi climatici estremi, malattie degli animali e delle piante, sempre più frequenti nel Sud come conseguenza delle attività a Nord, stiano mettendo in pericolo la sicurezza alimentare in queste zone, ovvero la garanzia di accesso ad acqua e cibo.
Riflessione sui possibili scenari futuri
Anziché esportare il modello del Nord Globale a sud è opportuno fare l’esatto opposto, interpellando anche il grande bagaglio di conoscenza indigena e di pratiche tradizionali che preservano l’armonia del tutt’uno tra uomo e natura. Certo è che il passaggio da un modello produttivo intensivo come quello attuale ad uno più lento ed estensivo è possibile solo se la domanda di prodotti di origine animale viene tagliata considerevolmente. Per fare ciò l’umanità dovrebbe indirizzare la propria dieta verso un consumo maggiore di plant-based food.
Purtroppo il trend attuale è ben lontano da questo scenario, il modello produttivo intensivo è in espansione in risposta ad una crescente urbanizzazione, alla popolazione mondiale in aumento e ad una sempre maggiore richiesta di carne. Ricordiamoci però che tutto ciò ha ripercussioni sulla salute pubblica, sulla perdita di biodiversità, sulla sicurezza alimentare e, non meno importante, anche sulla sofferenza animale.
È tempo che i leader globali riorientino il proprio supporto sui sistemi produttivi sostenibili attraverso strumenti che possono essere sussidi o limitazioni al vecchio modello.