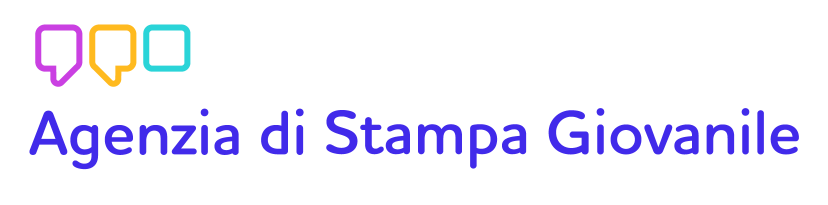Ambiente, natura, complessità: affrontare lo Zeitgest delle illusioni
Di Pina Piccolo, la macchina sognante
Foto di Teri Allen-Piccolo, Nuova Zelanda.
1) Pina Piccolo – Grazie per aver accettato di essere intervistata per La Macchina Sognante. Potresti presentarti per i nostri lettori?
Paola Rizzo – Ringrazio io La Macchina Sognante per quest’opportunità. Mi chiamo Paola, sono nata nel1997 e vivo in Sicilia, nella provincia di Messina. A Messina, frequento la facoltà di Lettere Moderne. Sono innamorata di ciò che studio e mi piacerebbe, dopo la laurea, insegnare materie umanistiche nelle scuole. Credo che approcciarsi con amore ai testi e tentare di far nascere quell’amore in animi giovani possa essere un buon punto di partenza per creare una rete di persone reciprocamente capaci di comprendersi. Avvicinarsi alla letteratura (magari mettendosi anche in cerca di scritture poco conosciute, senza fermarsi solo ai “classici”), significa uscire dal proprio egotismo, prestare attenzione ai sentimenti e scoprire che quei sentimenti appartengono anche a noi. Gioia, dolore, rabbia, speranza, rassegnazione, compassione…: ogni moto del nostro animo ha già trovato espressione nella scrittura di qualcun altro, possiamo metterci in contatto con quella scrittura e scoprire che nessun uomo è mai solo. Indipendentemente dalle nostre personali peculiarità, c’è una sorta di vastissimo e comune mondo interiore che tutti gli esseri umani condividono. In un tempo in cui si insiste proprio sulle discriminanti, sulle categorie, sulle gerarchie, esplorare quel mondo comune vuol dire stare tutti meglio: avere strumenti preziosi per conoscere se stessi e gli altri. Sarò un’insegnante entusiasta, lo prometto!
_
2) P.P. – Come è nato il tuo interesse per le tematiche ambientali? Che tipo di attivismo hai svolto negli anni? Sei stata coinvolta in lotte per la difesa dell’ambiente nel territorio in cui vivevi?
P.R. – La questione ambientale perseguita quelli della mia età, in modo martellante, praticamente da quando cominciano i nostri ricordi. Gli allarmi lanciati dagli scienziati, intensificatisi particolarmente in questi ultimi anni, non sono comunque una cosa nuova. Ininterrottamente dalle scuole elementari, alle medie, alle superiori ho sentito parlare di “emergenza ambientale”. Ecco un dato eloquente: l’anno in cui ho concluso le scuole medie – nel 2011 – qui in Italia si tenne il referendum sul nucleare. In quell’occasione, si parlò molto della questione energetica e prese forma un dibattito, devo dire molto sentito, sull’importanza e le grandi potenzialità delle rinnovabili: indimenticabili le lunghe serate trascorse a guardare “Annozero”, la trasmissione di Michele Santoro che aveva alimentato uno stimolante dibattito sul quesito referendario. In quello stato di cose, portai una “tesina” – per l’esame di terza media – che si collegava all’attualità e in cui esprimevo la mia assoluta contrarietà in merito al progetto di realizzazione di centrali nucleari in Italia. Nel 2016, il mio ultimo anno di scuole superiori, l’ambiente è stato – di nuovo – un tema caldo. Si andava a referendum per decidere intorno alle liceità delle trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa. Quel referendum fu vergognosamente boicottato dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. La cosa più importante è che quello fu il mio primo voto: un’esperienza in cui, da un originario entusiasmo, sono letteralmente sprofondata nell’amarezza. Avevo scritto post infiammati sui social e cercato di incoraggiare quante più persone possibili a votare “sì” (cioè a opporsi all’azione sacrilega delle trivelle in mare e, per di più, un’azione vicinissima alle zone costiere). La cosa che mi rese (e rende) orgogliosa è che – nella mia classe – tutti i ragazzi e le ragazze che, quell’anno, acquisivano il diritto di votare espressero un deciso “sì”; ma la delusione (che ancora oggi non dimentico) è che l’affluenza a quel referendum fu modesta, non si avvicinò neppure lontanamente al quorum. Una votazione importantissima, boicottata dal presidente del Consiglio e disertata dagli italiani. Insomma, il mio percorso scolastico è stato quasi scandito da due rilevanti momenti (dei quali il secondo è stato veramente traumatico) di dibattito nazionale intorno all’ambiente. Ma, andando ancora più indietro nel tempo, ricordo che – nel periodo della mia infanzia – uno straordinario lavoro di sensibilizzazione dei più piccoli rispetto all’istanza ecologista era svolto da una certa televisione “a misura di bambino” (guardate il commovente video di Dario Moccia su Youtube che ricorda quel tipo di intrattenimento intelligente) purtroppo, non più esistente (eh sì, si può rimpiangere un passato felice e, forse, migliore anche a ventidue anni!). Penso alla Melevisione che riusciva ad affrontare tante tematiche importanti tra cui anche quella ambientale con episodi dedicati al problema degli sprechi, dell’inquinamento, del rispetto degli spazi verdi. Insisteva sull’educazione ecologica anche un meraviglioso cartone animato intitolato “Pipsqueak”, incentrato sulle vicende di un ragazzino dai capelli verdi impegnato nella difesa della natura. Ho dei ricordi magici anche di un videogioco, indirizzato soprattutto a un pubblico di bambini (su cui, a volte, torno ancora oggi con rinnovata meraviglia) che riusciva (e riesce ancora a farlo, perché è modernissimo) a instillare nei ragazzini l’amore per la natura e per le sue creature: “Viva Piñata!”. Il videogiocatore deve occuparsi di uno spazio verde virtuale, curarne le piante e gli animali (che, in quel mondo di fantasia, sono dalle coloratissime piñatas “viventi”). L’incanto di questo videogioco meraviglioso è proprio quello di “muoversi” un ambiente che ospita una grande e caleidoscopica varietà di esseri diversi e di creare le condizioni di un ecosistema ricco ed eterogeneo. “Viva Piñata!”, insomma, educa alla biodiversità… provatelo e giocateci, ve ne innamorerete! Da piccola, ero affascinata proprio da questo tema: la biodiversità. Conservo gelosamente un bellissimo libro (“Global 200”) – pubblicato dal WWF e ricevuto, da bambina, come regalo di compleanno – che raccoglie foto mozzafiato relative alle aree della terra in cui si esprime, nelle sue forme più maestose, la biodiversità… ho letteralmente consumato quelle pagine. In questo interesse, mi incoraggiava molto la mia famiglia, in cui hanno sempre trovato spazio un’attenzione speciale per la varietà straordinaria di creature che abitano il pianeta. Ringrazierò all’infinito mia madre, in particolare, per avermi educata al rispetto e all’amore per gli animali: creature troppo spesso ridotte ad oggetti, sfruttate nella maniera più brutale e per i cui diritti ancora si deve fare moltissimo… del resto, neppure sul piano dei diritti umani siamo messi bene! (Consiglio ai lettori di LMS di recuperare, se non lo hanno ancora visto, il prezioso documentario “Earthlings”, un’ottima base di partenza per riflettere sull’antispecismo). Per un lungo periodo, alla domanda “Cosa vuoi fare da grande?”, la mia risposta è stata: “La veterinaria”. Purtroppo, però, lo studio delle materie scientifiche non è riuscito a conquistarmi mentre, invece, la mia passione le discipline umanistiche è rimasta e cresciuta nel tempo e quindi ho dovuto “cambiare i piani”. Negli anni, la mia casa ha accolto tanti animali sfortunati: attualmente, abbiamo due gattini, recuperati – in condizioni di estremo bisogno e sofferenza – dalla strada. Non ho svolto, finora, particolari forme di attivismo.
_
3) P.P. – Ci puoi parlare di Extinction Rebellion/ Fridays for Future facendoci un po’ il quadro dell’evoluzione del movimento, quali sono i suoi obiettivi e modalità d’azione? Potresti delineare le somiglianze e le differenze tra i due?
P.R. – Credo che per capire quali siano i punti di tangenza ma anche le non trascurabili differenze tra FFF e XR sia conveniente iniziare osservando proprio le modalità con cui nascono e si affermano sulla scena pubblica. Il movimento di “Extinction Rebellion” viene fondato nel maggio del 2018 ed emerge alla fine di ottobre dello stesso anno. Dopo aver ottenuto l’appoggio di un centinaio di accademici e scienziati alla sua prima azione di massa, XR fa il suo vero esordio il 31 ottobre del 2018. Quel giorno, a Londra, un gruppo di oltre mille persone si riunisce a Parliament Square, viene letta pubblicamente la “dichiarazione di ribellione” di XR e i manifestanti occupano la strada prospiciente il Parlamento britannico. Il movimento avanza 3 richieste rivolte non solo – nell’immediato – al governo britannico, ma di portata transnazionale: i governi sono tenuti a dire la verità ai cittadini intorno all’esistenza di un’emergenza ecologica e climatica e devono impegnarsi ad interrompere le politiche dannose per l’ambiente. Punto due: i governi devono adottare misure vincolanti per azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2025. Terzo: i governi devono affidare a un’assemblea nazionale di cittadini – coadiuvata da un’equipe di scienziati – le scelte politiche per fermare la perdita di biodiversità e contenere il riscaldamento globale. Le proteste di XR s’intensificano nel novembre 2018. I dimostranti bloccano letteralmente il traffico di Londra, occupano le vie principali della città e le loro manifestazioni mirano, fin da queste prime prove generali, ad avere un forte impatto emotivo: da Downing Street e Buckingham Palace – ad esempio – sfila una finta marcia funebre. Nell’ottobre del 2019, XR lancia una “ribellione internazionale” con lo scopo di portare oltre i confini del Regno Unito la protesta. Già prima di questa data, comunque, in diverse città del mondo (New York, Melbourne, Sydney, Berlino, Madrid, Vienna, Parigi…) sorgono manifestazioni collegate a XR. Quello che più colpisce di Extinction Rebellion è, intanto, l’estrema chiarezza programmatica che lo ha contraddistinto fin dai suoi esordi, il grande scrupolo con cui i 15 attivisti che hanno dato avvio al movimento si sono preoccupati – prima ancora di scendere nelle piazze – di guadagnarsi un esplicito sostegno da parte degli esperti impegnati nell’osservazione scientifica degli effetti dell’emergenza climatica. Il movimento ha immediatamente sostanziato la legittimità delle proprie istanze facendo appello alle prove fornite dalla scienza e questo – secondo me – è stato un merito grandissimo di XR: mettere subito sul tavolo delle trattative dei dati schiaccianti e, al contempo, sensibilizzare l’opinione pubblica intorno a un problema che spesso la scienza, da sola, fatica a comunicare ai non addetti ai lavori. Ma XR si caratterizza anche per un ulteriore motivo: non solo ha – in breve tempo – conquistato l’avallo di una consistente cerchia della comunità scientifica, ma le stesse dinamiche organizzative di XR sono frutto di un’indagine che ci si può azzardare a definire “scientifica”. Roger Hallam e Gail Bradbrook – due tra i più ferventi fondatori di XR – hanno una lunga esperienza di attivismo alle spalle e hanno tentato di strutturare un movimento capace non solo creare dibattito, ma di pervenire a un concreto raggiungimento dei suoi obiettivi. Hallam e Bradbrook, sia mettendo a frutto la loro esperienza di attivisti veterani, sia affidandosi a un personale percorso formativo (Hallam si è dedicato intensivamente allo studio della Sociologia) hanno sottoposto a una scrupolosa analisi i movimenti di protesta del Novecento cercando di individuare i fattori che ne hanno decretato il fallimento o il successo. Extinction Rebellion, nei suoi stessi principi ispiratori, è frutto proprio di queste analisi. La scelta della disobbedienza civile e della protesta non violenta – oltreché rispondere a un ideale che assume come fonti d’ispirazione Occupy, il movimento indipendentista di Gandhi, le suffragette, il movimento per i diritti civili di Martin Luther King… – poggia su un dato rilevato da Hallam/Bradbrook: storicamente, le proteste non violente avrebbero il 53% di possibilità in più di riuscita rispetto al 25% delle proteste violente. La dinamica stessa dell’arresto dei manifestanti – situazione che ricorre ad ogni sit-in di XR – viene caldeggiata perché diventa uno strumento di pressione. Nell’ottica di Roger Hallam le forze dell’ordine, quando il movimento avrà milioni di partecipanti nel mondo, non potranno più arrestare migliaia di attivisti, tra cui anche minorenni e anziani e la sfida è conquistare questa piattaforma di consenso (inoltre – rifacendosi a uno studio del 2011 – Hallam/Bradbrook accolgono la tesi secondo la quale, per rovesciare una dittatura, sarebbe sufficiente la rivolta del 3.5% della popolazione). Una situazione che costringerebbe i governi ad agire politicamente e a cercare strade diverse rispetto all’arresto dei manifestanti. Rispetto a queste imponenti (e affascinanti) impalcature su cui si sorregge XR, il movimento “Fridays for Future” lanciato Greta Thunberg usa un linguaggio e delle strategie più semplici ma proprio per questo – secondo me – più capaci di fare presa su un pubblico di giovani e giovanissimi che possono vedere meglio rispecchiate le proprie paure e speranze nell’impegno di una ragazza che ogni venerdì ha esposto davanti al Parlamento di svedese il suo cartello «Sciopero scolastico per il clima», chiedendo al governo la riduzione delle emissioni di C02. FFF – che nasce soprattutto come movimento “studentesco” – ha raccolto le istanze di quelle fasce della popolazione – i ragazzi – che meno, finora, hanno avuto voce in capitolo in un dibattito che paradossalmente li riguarda più di chiunque altro, perché la crisi climatica pende proprio su di loro e sono loro che concretamente dovranno farci i conti. A mio parere, quel bacino di giovani che FFF è riuscito a informare e sensibilizzare è la vera forza del movimento. Greta che parla con le lacrime agli occhi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite denunciando la colpevole inerzia dei potenti della Terra intorno all’emergenza climatica, rispecchia in maniera molto più fedele le angosce dei più giovani rispetto agli algoritmi e ai manifesti programmatici di XR. E, anche se riconosco a XR la capacità di costituire un gruppo di pressione che, nell’immediato, è forse più incisivo rispetto a FFF, penso che FFF abbia contribuito a gettare i semi di un futuro migliore che, nel lungo periodo, frutteranno. FFF ha obbligato i grandi ad ascoltare veramente le istanze dei ragazzi e a non usarli soltanto, quando è tempo di campagna elettorale, nella vuota retorica dei “giovani che sono il futuro”, ha cementificato una consapevolezza critica intorno al problema ecologico che si presta a diventare la vera discriminante delle nuove generazioni rispetto a quelle che le hanno precedute. In ogni caso, qualsiasi contributo è prezioso e uno stesso obiettivo può essere perseguito per vie diverse. XR e FFF sono due vie possibili e valide ( e i due movimenti, infatti, hanno avuto occasione di sostenersi reciprocamente), ma ad essi si aggiungono molti altri contributi in direzione di tutela dell’ambiente a cominciare all’azione dalle varie ONG (tra quelle ormai attive da anni e preziosissime, penso soprattutto a Greenpeace) per arrivare al singolo cittadino che fa correttamente la differenziata, evita sprechi d’acqua, rinuncia ai mezzi a motore per le brevi tratte, usa il trasporto pubblico, legge bene le etichette dei prodotti sforzandosi di privilegiare quelli a chilometro zero, cerca di consumare meno carne (prendendo in considerazione, magari, anche una dieta vegetariana su cui io stessa intendo lavorare) e di acquistare solo prodotti d’origine animale assolutamente non provenienti da allevamento intensivo.
_
4) P.P. – Come vedi la composizione generazionale di questi movimenti? Cosa ne pensi delle difficoltà che stanno avendo le generazioni più attempate ad accettare le vostre modalità ed analisi?
P.R. – XR può contare su una piattaforma di sostenitori più eterogenea – dal punto di vista generazionale – rispetto a FFF che, pur rivolgendosi a tutti, ha indubbiamente un target più mirato dato che cerca e trova appoggio soprattutto nei giovani e in quelli che, particolarmente, sono ancora impegnati nelle scuole: il movimento ha assunto subito le caratteristiche dello sciopero scolastico. Il dibattito sul tema ambientale ha fatto esplodere una dinamica di scontro generazionale di cui, in realtà, era possibile scorgere manifestazioni considerevolissime qualche tempo prima della nascita di XR e FFF soprattutto sul web. In un altro contributo per LMS ho cercato di mettere in rilievo e rintracciare, per quanto concerne la realtà dell’Italia (sarebbe interessante fare lavori simili in altri Paesi), in che modi – ormai da un po’ di anni (risalgono al 2013/2014 i primi “reperti” che ho raccolto) – si stia consumando in rete la contestazione delle giovani generazioni rispetto a quelle adulte; contestazione che mette in gioco modi di comunicare, schemi valoriali incompatibili, modi completamente diversi di analizzare il mondo. Ultimamente ha trovato una dilagante diffusione sui social il tormentone “Ok, boomer” che inizia a circolare nel 2018 per spopolare e raggiungere persino le sedi ufficiali del dibattito sulla questione ambientale proprio nel corso del 2019, quando la deputata neozelandese Chlöe Swarbrick risponde con queste parole lapidarie a un collega che prova a interromperla nel pieno di un discorso sull’emergenza climatica. “Ok, boomer” è sostanzialmente un’espressione usata da adolescenti e giovani per replicare (in tono a metà tra l’ironico e il piccato) a quelle che vengono percepite come tirate paternalistiche di una generazione che il termine “boomer” identifica soprattutto con quella dei baby boomers (i figli del boom economico, nati tra gli anni Quaranta e Sessanta). La parola, comunque, assume un valore molto più ampio (analogamente a quanto accade per l’uso speciale che si fa in Italia di “quarantenne”, presso i parlanti più giovani) e, più che designare una generazione, designa schemi di pensiero percepiti come maggiormente diffusi in una fascia della popolazione adulta (cinquantenni-sessantenni-settantenni) che non solo – attraverso i propri stili di vita e atteggiamenti – è vista come la principale artefice di diversi disastri contemporanei, ma si ostina a restare sorda di fronte a tematiche che i più giovani sentono il bisogno di affrontare (la crisi climatica, ma anche molte altre cose: il dibattito sull’identità di genere, etnica, sessuale; il problema dell’assenza di un sistema welfare; la necessità di garantire a tutti il diritto allo studio per cui si è battuto e alla fine ha compiuto un gesto disperato Anas K., studente dell’università di Lione, che ha accusato il gotha dell’EU di perseguire politiche deliberatamente volte a ostacolare la formazione culturale dei ragazzi). Perché c’è una difficoltà e diffidenza delle generazioni più adulte nei confronti delle discussioni intavolate dai più giovani? Io credo che a ciò concorrano vari fattori. Innanzitutto, il fatto che, dal secondo dopoguerra in poi, è iniziata per l’Occidente una fase di benessere economico pressoché ininterrotta, di sviluppo tecnologico, di generale miglioramento delle condizioni di vita, si è – insomma – venuto a creare uno “Zeitgeist” alimentatore di illusioni: sarebbe stata possibile una crescita illimitata verso un roseo futuro e, nonostante la scienza parlasse chiaro a proposito dei disastri che quella crescita senza freni avrebbe prodotto, non si è preso sul serio quel monito. È stato l’egoismo e la mancanza di progettualità, credo, la vera colpa di quelli che – per comodità – chiamo “boomers”: pensare a un eterno oggi in cui va tutto bene, non domandarsi da dove deriva quel benessere (dallo sfruttamento cieco delle risorse naturali e dalla riduzione di una parte “sommersa” dell’umanità a forza-lavoro priva di tutele). Oggi è difficile accettare che tanti giovani non credano più a quella favola e stanno rovinando la festa mettendo sul campo problemi che si è preferito ignorare. Inoltre, una delle cose che stizzisce di più – per quello che intuisco – molti “boomers” è la percezione di star perdendo una specie di autorità-autorevolezza derivante dall’età: una specie di “diritto del più grande” che può esercitare il proprio paternalismo verso i giovani-inesperti senza essere contraddetto. La reazione di Massimo Cacciari a FFF è eloquente: etichettare Greta come “una bambina” che si permette di dire cose già ribadite dagli scienziati (qua si interseca il rimprovero paternalistico dell’adulto verso l “ardire” di “una bambina” e lo sport, ahimè molto italiano, dell’intellettuale navigato che tuona contro chi “non ha i titoli”). Ma le reazioni di molti altri “grandi” contro FFF (il fenomeno, del resto, si ripete per qualunque manifestazione studentesca, indipendentemente dai motivi che la animano) hanno avuto esiti simili: ragazzi sfaticati, che vogliono saltare ore di lezione, che non sanno neppure i motivi per cui vanno a manifestare. Abbiamo a che fare, quindi, con un groviglio di ostacoli che creano un notevole gap generazionale: una sorta di insofferenza derivante dalla perdita del crisma dell’autorità legata dall’età; l’abitudine (nutrita, purtroppo, anche dai mass-media tradizionali) a vedere una realtà semplificata in cui o va tutto bene oppure quello che va male interessa solo gli scienziati; la convinzione che essere giovani e inesperti significhi non avere gli strumenti adatti per capire in che direzione va il mondo (e questi strumenti, per di più, sono largamente costituiti dalle famigerate nuove tecnologie e dalle vie di informazione, alternative a quelle offerte dalla televisione o dalle testate più note, che internet rende disponibili).
_
5) P.P. – Antropocene o Capitalocene? Come definiresti il dibattito legato all’uso di queste due terminologie per chi non è molto addentro al dibattito? Secondo te prevede anche la ricerca di una nuova estetica per chi fa lavoro artistico?
P.R. – È un dibattito che si è reso necessario in un momento storico in cui la crisi climatica non è più – come, per un lungo periodo, è stata percepita – una minaccia lontana e da relegare a qualche fumoso futuro: quel futuro è arrivato e occorre avere gli strumenti non solo per comprendere gli effetti del fenomeno, ma anche le sue cause più profonde. Il concetto di Antropocene, fermo restando che veicola una verità su cui la scienza (o, comunque, la netta maggioranza della comunità scientifica) non ha dubbi – l’attività degli esseri umani provoca mutamenti considerevoli delle condizioni ambientali – porta tuttavia con sé degli inconvenienti. Parlare di “Antropocene” significa vedere solo gli aspetti più evidenti di una realtà e, per di più, da una prospettiva potenzialmente deformante. Il termine “Antropocene” si è troppo spesso legato a un dibattito che ha stabilito una sorta di scissione insanabile uomo-natura quasi prospettando l’impossibilità di fondo di risolvere l’emergenza ambientale: il progresso del genere umano passa necessariamente attraverso un massiccio intervento e sfruttamento della natura e delle sue risorse. Oltre ad aprire, in nuce, la strada a queste visioni fatalistiche, l’uso di un termine come “Antropocene” ha anche offerto pericolose possibilità di deresponsabilizzazione: una generica “umanità” sarebbe artefice della crisi climatica, tutti indistintamente “colpevoli”. Il concetto di “Capitalocene” consente, invece, di addentrarsi nel problema facendo delle ulteriori precisazioni ed evitando quella genericità con cui esso è ancora affrontato nel dibattito pubblico e attraverso i mass-media. Dire che ci troviamo nel “Capitalocene” significa, intanto, fare un’affermazione politica e individuare precisi livelli di responsabilità. I mutamenti climatici non sono il prodotto di una generica “umanità” che, come un’entità esterna, agisce sull’alterità natura. Piuttosto, parliamo di un’umanità che agisce dentro la natura e che all’interno della natura ha definito specifici rapporti di produzione e consumo. Questi rapporti – secondo Jason W. Moore (che ha coniato il termine) – si sono sviluppati in un arco di tempo molto più diluito rispetto ai termini storici con cui si faceva cominciare l’Antropocene (di solito, la Rivoluzione industriale). Moore, infatti, fissa il preludio del “Capitalocene” più indietro, almeno a partire dalla massiccia colonizzazione delle Americhe da parte degli Europei che avrebbe costituito il vero esordio del sistema capitalistico (lo sfruttamento accanito del territorio, delle risorse ambientali, di esseri umani ridotti a manodopera a bassissimo costo). Il Capitalismo, insomma, ha il potere di ristrutturare l’ambiente e crea intorno a sé, esso stesso, una natura. Il cambiamento climatico è responsabilità di un’umanità (quella che detiene i mezzi di produzione e anche il potere di consumo) più che di un’altra e non tutti i Paesi della terra incidono nello stesso modo sul problema ambientale: sono le economie industrializzate e di consolidato sistema capitalistico le maggiori colpevoli. Oggi, anche se è un grande passo avanti che una parte sempre più larga dell’opinione pubblica arrivi a comprendere gli effetti dell’emergenza climatica, restano ancora troppo in ombra le radici del problema. Discutere di “Capitalocene” significa non solo capire la genesi del problema, ma anche riconoscere che il solo modo per affrontarlo è smantellare una struttura sociale-economica-culturale che ormai ha una storia plurisecolare. Occorrerebbe che i mezzi di informazione iniziassero a fare un uso più frequente della parola “Capitalocene”, sforzandosi di farla evadere dai contesti accademici o comunque specialistici in cui si è definita la querelle Antropocene vs Capitalocene. Superare il Capitalocene è la vera sfida e non è una sfida facile perché vuol dire rinunciare a delle cose su cui l’Occidente ha costruito il suo benessere (o malessere?): dismissione dei combustibili fossili; cultura del riutilizzo; rinunciare al massivo sfruttamento di aree del pianeta che costituiscono, al tempo stesso, miniere d’oro da spremere il più possibile e discariche in cui accumulare i rifiuti del bel mondo (per fare un solo esempio, sono innumerevoli le inchieste relative all’inquinamento dell’Africa dove l’Europa esporta modelli obsoleti di auto diesel non più in uso nell’Occidente a causa degli agenti altamente tossici che esse producono). Ovviamente, chi si dedica a un’arte impregnata di contemporaneità non può che sentire come urgentissima la questione ambientale e può lavorare nella codificazione di estetiche in grado di sviscerare il problema. Su questo punto, mi viene in mente il saggio di un autore che amo appartenente, purtroppo, a un nutrito gruppo di scrittori del secondo Novecento per nulla o solo di sfuggita affrontati nella scuole italiane a causa di programmi che ormai sono decisamente attempati e da ristrutturare (ma, l’urgenza, evidentemente, pare essere la scuola-lavoro!). Parlo di Italo Calvino che scriveva, nel 1962, un saggio dal titolo eloquente “La sfida al labirinto” il cui valore, credo, rimanga intatto (anzi, viene quasi potenziato) anche oggi. Calvino osservò con inquietudine il costituirsi in Italia e in Europa di una società industriale, i processi di trasformazione (e deturpamento) dell’ambiente, i nuovi stili di vita che iniziavano a sorgere in un contesto alienante e disumanizzante dominato dalle fabbriche. Prima di arrivare a “La sfida al labirinto”, Calvino si era già avvicinato alla tematica ecologica denunciando gli effetti dell’affarismo senza freni in un suo romanzo poco conosciuto “La speculazione edilizia” che faceva luce sullo scempio della riviera ligure, devastata dal cemento. Nel 1962, Calvino propone un’ipotesi di lavoro rivolta principalmente a chi fa letteratura (ma che possiamo tranquillamente estendere al campo più vasto degli artisti in genere): il mondo contemporaneo costituisce ormai un labirinto in cui è facile perdersi, nel groviglio di contraddizioni del tempo presente, uno scrittore (aggiungiamo: un artista) è chiamato a guardare in faccia la realtà e indagare a fondo la rete dei rapporti e delle sottili combinazioni su cui si fonda la società industriale. Per farlo, continuava Calvino, bisogna però rifiutare – in partenza – le interpretazioni semplicistiche e unilaterali, aprirsi specialmente ai linguaggi e alle risorse offerte dalla scienza (possiamo dire che rifiutare le semplificazioni dell’Antropocene, in un’arte che vuole parlare di ecologismo, può essere un inizio). Questo programma trova la sua maggiore concretizzazione, nell’arte di Calvino, nella descrizione della città di Leonia (ne “Le città invisibili”), quelle pagine sono di un’attualità sconcertante e recano in sé il concetto di Capitalocene, anche se ancora esso non esisteva. Leonia è la città che si “rifà” continuamente e che va fiera della sua ricchezza: ogni giorno, i suoi abitanti buttano via delle cose e ne accumulano di nuove, nessuno si chiede dove vada a finire l’immondizia: è sufficiente sapere che i netturbini gettano tutto al di fuori della città, dove si ergono cumuli e cumuli di spazzatura. Dato che tante altre città hanno adottato lo stile di Leonia, la terra si appresta a diventare un’immensa pattumiera che cresce vertiginosamente in altezza e che bisogna augurarsi non traballi mai, perché potrebbe franare e sommergere per sempre Leonia che tanto si era affannata a tenere la spazzatura lontana da sé. Leonia è la città del Capitalocene: si culla in un (presunto) benessere fondato su un frenetico ciclo di produzione-consumo che crea un determinato tipo di ambiente e determina un’emergenza di cui gli abitanti di Leonia non si accorgono perché, potremmo dire, la loro visione è quella dell’Antropocene: la natura è l’alterità che si trova al di fuori dalle mura cittadine e in cui vanno a finire i rifiuti (ed è necessario che Leonia produca rifiuti, perché altrimenti non sarebbe così ricca). Invece Leonia non è una cosa a parte rispetto alla natura, è dentro la natura e la definisce con le sue strutture economiche e, prima ancora, con la sua cultura (struttura e sovrastruttura, direbbe Marx). Tra gli artisti contemporanei che oggi “sfidano il labirinto”, uno di quelli che mi stupisce puntualmente è Artur Bordalo, un ragazzo portoghese che, attraverso materiali di scarto e quello che per altri è immondizia, realizza bellissime rappresentazioni di animali e lo fa opponendosi alla società dell’usa-e-getta, col preciso intento di incoraggiare il suo pubblico al riciclo. In diverse mostre artistiche, anche in Italia, impegnate a veicolare la sensibilità ecologista, si è avuta l’idea di esporre al pubblico i cosiddetti “plastiglomerati”, sassi in cui la plastica si è fusa completamente con il materiale roccioso. L’osservatore che non conosce l’esistenza di queste neo-formazioni, in cui la roccia è infestata dalla plastica, pensa che siano oggetti confezionati “ad arte” per la mostra, invece l’obiettivo è quello di fargli scoprire che i plastiglormerati sono diventati una preoccupante realtà “naturale”, nessun artista li ha realizzati. Uno dei lavori più geniali di Banksy è un murales – realizzato a Port Tablot, nel Galles – che sfrutta un gioco prospettico destabilizzante per denunciare l’inquinamento dell’ambiente: il disegno è distribuito su due facciate che si incontrano formando un angolo. Se l’osservatore guarda una sola delle due facciate, ha l’impressione di vedere un bambino che si stupisce per l’arrivo della neve, ma allargando la visuale e osservando anche l’altra parete, si scopre che quella che sembrava neve, invece, è la cenere sprigionata da un cassonetto della spazzatura che sta bruciando. È una strategia estetica di enorme impatto emotivo che – non so se per puro caso o per citazione voluta – tra l’altro, è stata utilizzata anche per costruire una scena di “Chernobyl” (serie straordinaria, uscita nell’anno appena trascorso, che non solo ricostruisce pagine terribili di storia passata, ma spinge anche a meditare sul pericolo che la cosiddetta “energia pulita” costituisce ancora oggi). La regia mostra – in una sequenza inquietante – dei bambini che giocano con la polvere, scaturita dall’esplosione del reattore nucleare, come se fosse della neve.
_
6) P.P. – Come ci si sposta da epistemologie antropocentriche a nuove epistemologie e paradigmi che incorporino concetti come ecosistema, cosmovisioni indigene, il transnazionale, l’intersezionalità, le nuove tecnologie, le nuove scoperte scientifiche su intelligenze e saperi in quella che tradizionalmente viene vista come “natura” inerte, le nuove scoperte della fisica sulla multidimensionalità dell’universo e della realtà?
P.R. – L’unica risposta che posso dare a questa domanda è che ci si sposta verso nuovi paradigmi valoriali, forse, nella maniera più banale: col passare del tempo. È necessario che progressivamente le “nuove leve” raggiungano posti di responsabilità in seno alla società perché si possa “cambiare aria”. Il passaggio da un clima culturale a un altro può avvenire solo quando una generazione, che si è formata in un determinato sistema di idee, rimpiazza le precedenti che – per il semplice fatto di invecchiare – prima o poi dovranno cedere il posto. Anche se una parte di me scorge un futuro estremamente incerto e pieno di insidie, io percepisco che il mio modo di approcciarmi alla realtà e quello dei miei coetanei è nutrito di un sostrato culturale che può essere alla base di una società più giusta. Insisterò sempre sull’importanza che ha avuto il web nel mettere in comunicazione realtà diverse e nel far circolare, nell’ambito di realtà diverse, comuni progetti e ideali. La possibilità di accedere a una quantità sconfinata di contenuti messi in rete da qualcun altro, “obbliga” qualsiasi internauta a confrontarsi continuamente con tante alterità, ad assorbire opinioni, modalità espressive variegate. Internet ha in sé un potenziale “educativo” enorme: abolisce le gerarchie, dà voce a tutti, annulla le distanze, fa discutere. Sono entusiasta ogni volta che parlo del web, mi consente di avere finestre aperte su tanti frammenti diversi di umanità e di conoscerli meglio: solo ciò che non si conosce e si ignora può fare paura. Pensiamo solo alle possibilità, che molti siti di informazione hanno offerto, di scoprire realtà umane poco conosciute e vulnerabili. Un esempio, cronologicamente molto vicino, ci è dato dalla grande mobilitazione online successiva agli incendi (dolosi) che hanno devastato la foresta amazzonica: una grande parte del web si è mobilitata con raccolte fondi o si è impegnata a far conoscere la lotta che i popoli indigeni della Foresta stanno dolorosamente sostenendo per la difesa della loro casa (LMS ha dedicato al tema un apposito inserto). La qualità stessa dell’intrattenimento disponibile online (che crea un contrasto davvero impietoso rispetto alla “qualità” dei contenuti offerti dalla tv generalista) contribuisce a creare una giovanissima comunità internazionale particolarmente disposta ad accogliere l’eterogeneità: quanto è stato prezioso che Netflix abbia, per esempio, investito su una serie come “BoJack Horseman”? Un capolavoro che ha reso i suoi spettatori persone migliori, stimolando i ragazzi a trattare con comprensione e gentilezza l’altro, chiunque egli sia e aprendo dinanzi a loro una riflessione su temi importanti: la conoscenza della malattia mentale e della depressione; il desiderio di evadere dalla prigione dell’incomunicabilità e di fidarsi degli altri; la sfida dell’essere donna in contesti fortemente patriarcali; l’imbarazzo di portare con sé un’identità sessuale percepita dai più come “strana”; lo sconforto di sentirsi sradicati e culturalmente lontani dalla propria terra d’origine; il disagio del sentirsi “diversi” in una società omologante, che soffoca l’eterogeneità ed è abituata a ragionare per etichette e categorie chiuse… Si è instaurata, tra i ragazzi di oggi, una sorta di koiné culturale che si incardina su priorità condivise e avvertite come urgenti indipendentemente dalla parte del mondo in cui ci si trova, problemi che riguardano tutti: la protezione dell’ambiente è uno di essi; ma anche la questione dei diritti umani e il bisogno che vengano garantiti specialmente alle fasce della popolazione che più spesso ne vengono private; ha fatto enormi progressi (ma ancora siamo ancora troppo indietro) anche l’importantissimo dibattito sulla dignità e sui diritti degli animali; il problema dell’accesso all’informazione (e, quindi, soprattutto al web) che dovrebbe essere alla portata di tutti. Davanti a una società complessa la mia impressione è che, per fortuna, si stanno formando delle menti capaci di pensare in modo complesso. Un cambiamento ci sarà necessariamente, lo stesso scorrere del tempo lo impone: io voglio pensare che più a fondo dell’abisso in cui si è tuffato l’Occidente sia quasi impossibile spingersi e credo che la caduta abbia prodotto una controspinta che ci farà risalire. Sul fondo resteranno solo i relitti.
_
7) P.P. – Quali pensi saranno i nodi fondamentali che si profilano per questi movimenti?
P.R. – Secondo me, la vera sfida per XF e FFF sarà far capire – prima ancora che ai governi – a tanta opinione pubblica, che tutelare l’ambiente significherà fare delle rinunce e questo, nell’immediato, avrà delle ricadute pesanti non tanto sul gotha (che i modi di “salvarsi” li trova sempre), ma soprattutto sul ceto operaio, popolare (con un termine marxista, “proletario”). Faccio un esempio: pensiamo all’ILVA. Un mostro ecologico del genere continua ad appestare l’aria di Taranto: parliamo di bambini con gravissime malformazioni, del proliferare di patologie a carico dell’apparato respiratorio, di tumori. Ogni evidenza deporrebbe – senza discutere – per la coatta chiusura della fabbrica, questo però avrebbe dei costi enormi: non solo perché l’ILVA è uno dei poli siderurgici più produttivi dell’Europa (e la sua chiusura – secondo stime dell’Agi – comporterebbe un decremento dell’1,4% del PIL nazionale), ma provocherebbe anche il licenziamento di circa 10mila persone. In Sicilia, la raffineria di Milazzo (nella provincia di Messina) è fonte di inquinamento ambientale e di un conseguente moltiplicarsi di patologie nelle zone limitrofe. Anche qui, chiudere l’impianto significa fare tanti licenziamenti. Il punto è proprio far capire alle persone comuni quali sono le priorità: è in gioco – volendo essere “egoisti” e volendo restringere lo sguardo al nostro piccolo mondo, per abbandonare le ampie prospettive – non solo la questione ambientale, ma – molto più prosaicamente – la nostra salute e specialmente quella della povera gente che, in contesti ammorbati, allo stesso tempo si ammala, ma ci lavora per poter campare. La storia drammatica di Fabian Tomasi (a cui hanno dato voce, in Italia, “Le Iene”) dovrebbe persuadere tutti dell’insostenibilità del “Capitalocene”. Fabian ha sviluppato una polineuropatia dopo aver trascorso anni a lavorare nei campi dell’Argentina e a respirare glifosato, un erbicida (che l’OMS ha identificato come probabilmente cancerogeno) capace di distruggere tutte le piante con cui entra in contatto e utilizzato solo sulle resistenti coltivazioni OGM. Fabian – prima di morire – mostrando agli altri il suo corpo sofferente, ha denunciato lo spietato giro d’affari che ruota intorno all’agricoltura industriale e ha lasciato un messaggio importante, che voglio citare, al giornalista Gaetano Pecoraro: “La mia non è solo una testimonianza, tutto questo deve servire. Non a noi, che ormai siamo perduti, ma agli altri, affinché capiscano che siamo stati ingannati e che la nostra vita è stata ceduta in cambio di denaro”. Fabian – nei suoi anni di lotta e di strazio fisico – ha più volte cercato di invitare i suoi ascoltatori a non accettare mai condizioni di lavoro come quelle disumane che, per anni, egli stesso ha sopportato e di non subordinare la salute al guadagno (e, come se non bastasse, un misero guadagno), ad aprire gli occhi e non diventare carne da macello per chi lucra sui bisognosi. Inoltre, si è anche espresso molto chiaramente sulla questione ambientale, sostenendo che la natura ci sta già facendo pagare il prezzo dello scempio cui continuiamo a sottoporla. La sfida di XR e FFF, prima ancora che contro i governi, sarà nello sforzo titanico di convincere ad andare via dai campi inquinati di veleni e dalle fabbriche che producono morte tanti Fabian. II mostri ecologici non dovrebbero più trovare personale che li alimenti! La risoluzione dell’emergenza climatica dovrà passare necessariamente attraverso punti di PIL in meno e licenziamenti, attraverso una radicale ristrutturazione delle economie occidentali. Come sarà possibile farlo? Forse cercando di rendere voci portanti nella protesta uomini e donne come Fabian, che hanno pagato con la loro salute l’inquinamento ambientale. Una delle critiche che più spesso viene mossa ad XR (FFF, su questo fronte, è ovviamente meno esposto perché la sua stessa anima si lega a contesti più specifici rispetto ad XR: particolarmente quelli studenteschi) è proprio quella di essere un movimento di estrazione borghese e di non riuscire ancora a fare presa proprio sulle componenti sociali proletarie (che non di rado hanno reagito con rabbia – per esempio – alle manifestazioni che hanno bloccato le strade e il passaggio dei trasporti pubblici). XR, inoltre, ha l’appoggio di una nutrita comunità di scienziati ed esperti che potrebbe lavorare – oltreché sul fronte della denuncia – proprio intorno alla “pars construens”: capire come attuare il passaggio dagli attuali sistemi produttivi, insostenibili per l’ambiente, a strutture economiche rispettose dell’ecosistema e, al contempo, capaci di creare occupazione e di offrire condizioni di lavoro salubri e umane. Concludo, a proposito di quel “capire quali sono le priorità”, facendo un riferimento a una discussione sorta proprio, nel corso dell’anno appena passato, sull’opportunità di organizzare grandi eventi in spazi naturali dal delicato ecosistema che potrebbe essere gravemente compromesso da un pesante intervento antropico quale può essere, ad esempio, l’organizzazione di un concerto. A livello nazionale, Jovanotti ha attirato le critiche di molti ambientalisti per aver deciso di tenere un tour di concerti in contesti naturali ricchi di biodiversità e particolarmente vulnerabili. Il grande alpinista Messner, per citare solo una delle voci contrarie, dopo l’annuncio entusiastico di un’esibizione del cantante sulle vette di Plan de Corones, ha sottolineato la necessità di “rispettare il silenzio delle montagne”. Io non posso che unirmi alle critiche rivolte a questi eventi “green” (che hanno ricevuto un sostegno, per me ingiustificabile, da parte del WWF). Credo che ci siano delle aree in cui cercare, ad ogni costo, di ridurre il paesaggio a una bella scenografia da riempire di gente festante significhi fare violenza alla natura. Inoltre, una situazione simile mi tocca da vicino perché – da qualche anno a questa parte – qui nel messinese si svolge un evento chiamato “L’Indiegeno”: una serie di concerti che copre alcune date calde (in tutti i sensi) della stagione estiva. Uno di questi concerti avviene nello spazio di in una riserva naturale: i Laghetti di Marinello, in cui si riversano puntualmente tantissime persone per ascoltare musica. Pensare al disturbo che un concerto così affollato reca alla flora e alla fauna (teoricamente “protette”) della riserva mi riempie di rabbia. E vado su tutte le furie non solo perché l’oasi dei Laghetti ha, nel corso degli anni, sopportato invasioni antropiche vergognose (pienamente “legali” e avallate dalle istituzioni) ad onta del rassicurante cartello “riserva naturale”, ma anche perché l’ulteriore invasione dell’ “Indiegeno” sembra essere accolta nei territori limitrofi con entusiasmo, senza un minimo di buon senso. L’evento viene pubblicizzato e atteso con l’acquolina in bocca da tutta una costellazione di locali che, dall’affluenza di così tanti turisti, ricava polposi guadagni. Che un tale ingorgo di gente possa stressare e recare danni non indifferenti a una riserva, già fortemente provata, non pare interessare. E qua io, con un imbarazzo immenso, devo annoverare tra gli insensibili che, ogni estate, chiedono l’ “Indiegeno” a Marinello molti ragazzi della mia età che magari si dichiarano sostenitori di Greta: questa è la dimostrazione che si può essere “quarantenni”/”boomers” anche a vent’anni! Uno scempio che dovrebbe essere disertato in massa. Il fatto che, al contrario, venga applaudito dalla massa testimonia che la strada da fare in direzione di una sensibilità ecologica è ancora lunga e che persistono schemi di pensiero smaccatamente antropocentrici. Ecco, direi che la sfida di XR e FFF e, più in generale, di qualunque serio ambientalista sarà far comprendere che di una certa forma mentis occorre sbarazzarsi. Il disastro ambientale che ci ritroviamo a dover gestire è frutto di una mentalità che ci ha portati a subordinare la protezione della natura a qualunque altro bisogno contingente: ghiotte occasioni di lucro e, persino – poveri noi! – la pretesa di sacrificare al puro divertimento la salute di un delicato ecosistema.
Grazie per aver contribuito con le tue risposte a portare avanti questo necessarissimo dibattito che stenta ad entrare nei canali tradizionali dei discorsi letterari e umanistici.