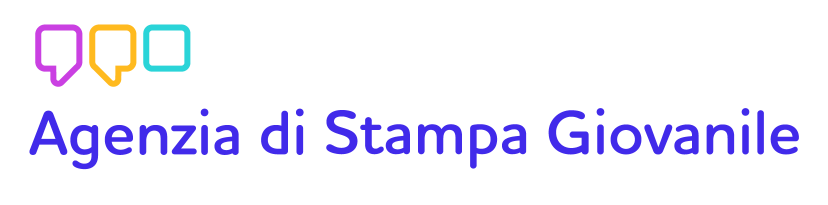Educare all’ampiezza
Una riflessione sulla modalità esclusiva e poco ampia dell’educazione.
di Chiara Camporese
Mentor: Angela Nardelli
–
Cinque.
Sei meno.
Non conosco il tempo esatto che si impiega ad essere associate a poco più che un numero scritto a penna rossa. Pensavo non fosse possibile, o almeno che la scuola non fosse lo spazio che lo rendeva possibile. E se mi colloco nel tempo in cui le valutazioni avevano una forma non numerica, allora io sicuramente esistevo tra quella linea che separava la parola quasi da quella sufficiente.
Quasi-sufficiente.
Io esistevo proprio lì.
Le parole possono raccontare sia l’inizio che la fine di una storia. Quelle parole, racchiuse in quel trattino poco visibile ma ben marcato, hanno delineato la fine della mia di storia.
Persone adulte, le quali avrebbero dovuto accompagnarmi nell’acquisto di strumenti per leggere e conoscere il mondo, avevano delineato una fine di linea ben marcata. Con una grande e pericolosa risolutezza, quelle persone decisero le linee che io avrei potuto tracciare, oltre le quali non sarei potuta andare. Come se oltre quelle linee, io avrei potuto smettere di esistere. Secondo quelle persone, che ricoprivano la figura da professorə, io avrei potuto fare solo il professionale. Non esistevano alternative, oltre a questo io non sarei potuta esistere.
A 13 anni è complesso vedersi oltre i 15 anni, se chi doveva indirizzarti non faceva altro che disegnarti come quella che sarebbe rimasta, per sempre, quel misero trattino.
Nel 2012 la conoscenza della dislessia nelle scuole di periferia stava a poco a poco emergendo.
Fu solo nell’ottobre del 2010 che la legge n.170 riconobbe la dislessia (assieme ad altri) come disturbo di apprendimento, riconoscendo i diritti alle persone che la presentavano.
Ricordo che dovetti fare tre fasi di test per “certificare” la mia dislessia (e altre culture associate).
Sono passati più di cinque anni dalla mia maturità e oltre ben dieci anni dalle scuole medie.
In questi anni però ho avuto la fortuna di attraversare comunque alcuni corridoi di diverse scuole. Le conoscenze riguardo le neurodivergenze
Il modello usato per insegnare non è per tutte le soggettività.
È esclusivamente per le persone che leggono il mondo nel modo in cui è stato deciso che deve essere spiegato. Conferire strumenti per spingere le persone a raggiungere le modalità con cui è deciso che bisogna imparare, riflettere ed esprimersi, significa respingere la loro persona in angolo. Implicitamente, le insegnamo che quello è il modo a cui dovrà adattarsi per stare al mondo. Organizzare per esempio le lezioni a “livelli” significa a sua volta costruire una gerarchia, dove il primo livello è per le persone “più sveglie”. Invece dovremmo cominciare a scoprire il modo in cui funzionano le loro menti e i loro corpi che divergono dalla norma sociale, creando anche una comunità con persone neurodivergenti.
È necessario anche modificare le parole che utilizziamo, le quali costruiscono un immaginario specifico. Spesso, è dall’immaginario che si strutturano le strategie.
La problematicità delle parole infatti la ritroviamo anche nelle leggi, che riproduco un certo e prepotente immaginario. Denominare la dislessia così come la discalculia, disturbi d’attenzione fa supporre che vi è un modo adeguato di prestare attenzione e tutti gli altri mo(n)di sono quasi-sufficienti o non. Presumendo che sia necessario adottare disposizioni che coprano questa “mancanza”.
Ma la dislessia così come la discalculia, l’autismo sono neurodivergenze, ovvero il cervello funziona in modo diverso da ciò che viene considerato “tipico”. Tipico non significa normalità, ma bensì il funzionamento della maggioranza delle persone che sono state studiate per costruire questo modello.
È fondamentale prestare attenzione anche ai processi attraverso i quali si giunge al riconoscimento di una neurodivergenza.
Il processo clinico, supportato da figure preparate e orientato verso la consapevolezza delle proprie neurodivergenze, occupa completamente la sfera individuale della persona, diventando l’unica forma di certificazione dell’esistenza neurodivergente. Questo approccio trascura la possibilità di un percorso di auto-riconoscimento della persona, venendo meno alla questione d’insieme. In aggiunta è inevitabile notare la carenza e la diffusa problematica dei centri in cui è possibile avviare un percorso diagnostico. Una valutazione superficiale della mappa e della distribuzione geografica di tali centri suggerisce una presenza significativa nelle grandi città.
Inoltre, suddividendo la vita delle persone con neurodivergenze in compartimenti isolati, si manifesta un problema sistemico che non è solo causato dalla mancanza di consapevolezza in Italia, ma anche dall’eccessiva enfasi posta sulla diagnosi, vista più dal punto di vista clinico che da quello dell’identità della persona. Ciò comporta una perdita dell’esperienza unica di ciascuna soggettività.
C’è tutta una grande parentesi che meriterebbe di essere aperta, in quanto gli indicatori definiti a riconoscere le neurodivergenze, sono per la maggior parte stati scritti per bambine e bambini. In questa newsletter Devon Price osserva molto bene la non neutralità e la riproduzione di dinamiche di potere all’interno delle descrizioni “diagnostiche”. Devon Prince riporta all’attenzione le caratteristiche sessiste e razziste presenti nei criteri utilizzati per riconoscere l’autismo.
L’urgenza è quella di rendere l’educazione ampia, evidenziare le forme multiple di apprendimento, conoscenza ed espressione delle persone. La diversità è un elemento naturale dell’esistenza.
Siamo a conoscenza dell’importanza della scuola e dell’educazione: allora dovremmo finalmente darla alle figure (e persone) che la compongono.
E forse perciò dovremmo ripensare alle persone che disegnano la scuola. Perché dietro a quelle parole c’è un percorso. Ri-disegnare un luogo dove le persone che insegnano sono anche, e soprattutto, persone educatrici; e dove le persone che la frequentano si sentano libere di esprimersi.
Per un’educazione ampia, per un’educazione condivisa.