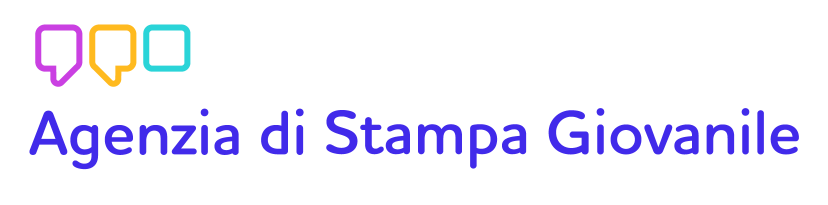Moda, etica e sostenibilità: quanto siamo pronti al cambiamento?
Abiti a basso costo spesso nascondono violenze contro ambiente, animali e persone. Ma anche l’alta moda è coinvolta. E allora, come si diventa consumatori responsabili?
Di Anna Pangrazzi, nucleo di Bolzano dell’Agenzia di Stampa Giovanile
Video commento di Federico Palisca
Chi ha a cuore questioni come il cambiamento climatico e l’etica avrà sicuramente sentito parlare di “Fast Fashion”. Esatto, la “moda veloce”, un metodo mirato alla produzione compulsiva di abiti di ultima tendenza a basso costo, affinché possano essere alla portata di tutti. Il termine venne utilizzato per la prima volta in un articolo del New York Times nel 1989 per descrivere il famoso brand Zara. E’, quindi, un fenomeno economico che dura ormai da un trentennio.
Nel 2015 esce un documentario rivelatore, intitolato “The True Cost”, che racconta la vera storia dietro gli abiti che vengono acquistati e indossati ogni giorno. Il dito viene puntato contro marche molto popolari quali Zara, H&M, Primark, Pull&Bear. Le scene più impattanti del film sono senz’altro quelle in cui si parla del Rana Plaza di Savar, in Bangladesh, una fabbrica di vestiti di otto piani, e del suo tragico crollo che provocò più di mille vittime e feriti.
Inoltre, si affronta il drastico impatto ambientale dei vestiti, dall’inquinamento provocato dalla lavorazione chimica dei tessuti alla crescita esponenziale di montagne di rifiuti tessili. Il film risulta molto efficace nel suo obiettivo: gli spettatori si ritrovano ad assistere, senza alcun filtro, alla violenza contro ambiente, animali e persone che si annoda nei fili dei tessuti che noi ammiriamo quotidianamente oltre le vetrine dei negozi. Quando compaiono i titoli di coda ci si trova di fronte alla consapevolezza disarmante che il lato più oscuro di un mondo che riguarda tutti da vicino è rimasto sorprendentemente taciuto per anni. Fortunatamente, oggi più che mai, si cerca di fare chiarezza sull’immoralità della moda, ma, più ci si addentra nella questione, più si scopre quanto essa sia ramificata e radicata.
Come soluzione si potrebbe pensare al mondo dell’alta moda, confidando ingenuamente che il prezzo dei prodotti sia direttamente proporzionale alla qualità della produzione. Eppure, si rimane scioccati quando si scopre che parte del “high fashion” è pienamente coinvolta in tale situazione. Basti pensare allo scandalo dell’industria Burberry, quando si scoprì che negli anni 2000, per evitare contraffazioni e vendite sottocosto, incenerì tutti gli avanzi di magazzino. Tale azione che oltre a far rabbrividire gli ambientalisti di tutto il mondo, fu uno spreco di manodopera, soldi e materiali.
Fashion Revolution
La situazione ora sembra decisamente migliorata. Si legge che molti stilisti stanno prendendo iniziative etiche e sostenibili, ma c’è ancora molto delle industrie che viene occultato. Noi, come consumatori, abbiamo il potere di cambiare il mondo stando attenti a cosa compriamo, tuttavia, risulta molto difficile trovare una marca che sia etica su tutti i suoi versanti, soprattutto quando informazioni essenziali vengono completamente omesse. La campagna internazionale Fashion Revolution, nata proprio nel 2013 dopo che si apprese della tragedia in Bangladesh, ritiene che il passo iniziale verso il cambiamento sia la trasparenza. Così nel 2019 pubblica il Fashion Transparency Index, una classifica dei più grandi marchi mondiali basata su quante informazioni divulgano sui loro rifornitori, sulle politiche e sull’impatto sociale e ambientale, dal migliore al peggiore. I primi cinque sono: Adidas, Rebook, Patagonia, Espirit e H&M. E invece troviamo tra gli ultimi brands: Chanel, Versace, Micheal Kors e Tom Ford (ultimo dell’intera lista).

Nonostante il grande vuoto informativo, sono nate molte iniziative con l’obiettivo di rendere le scelte del consumatore migliori e più consapevoli. Ad esempio, esiste l’app Good on You, una delle principali fonti di valutazione di moda, che assegna un “punteggio di etica e sostenibilità” a centinaia di marche, basandosi su schemi di certificazione come Fair Trade, OEKO-TEX e Global Organic Textile Standars (GOTS). Inoltre, offre, in alternativa, ditte che vendono prodotti simili, ma più etici. Il confronto così chiaro e immediato rende ancora più palese come il confine tra marche di alta e di “bassa” moda sia in realtà molto sfumato: a Zara, ad esempio, viene assegnata un punteggio medio (It’s a start), mentre Valentino viene valutata come “non abbastanza buona” (Not Good Enough).
Concludendo, la complessità della situazione è a dir poco vertiginosa e, se ci si fa prendere dal panico, può ripresentarsi quella sensazione di impotenza provata al termine del documentario. Come ci insegna l’attuale battaglia ambientale a favore del clima, la perseveranza nelle nostre piccole azioni è l’essenza del cambiamento. Indossiamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.