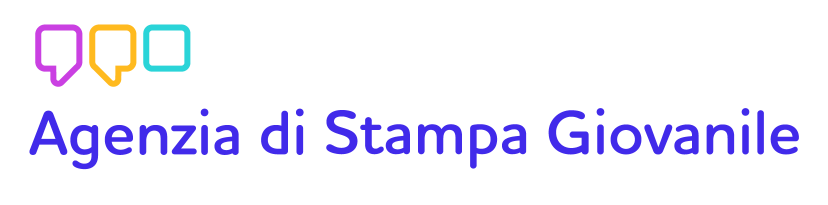Raffaele Crocco lo sa: la guerra è evitabile
Sabato mattina, Trento. Il bar risuona delle voci allegre dei clienti che salutano, ordinano, chiacchierano. Quelle delle cameriere fanno da controcanto: rispondono, chiedono, ripetono le comande. La macchina del caffè borbotta e i tappi delle bottiglie sbottano, mentre il lavabo aperto fruscia furiosamente. Gli stridii delle sedie che si spostano accompagnano il concerto di tonfi sordi e squittii vivaci dei bicchieri che, sbattendo tra loro, si appoggiano sui vassoi di legno. I cucchiaini tintinnano girando in tondo nelle tazzine. Tutto ride. Però ciò che mi riempie le orecchie non è felicità. Io sento scoppi e grida, fischi e pianti, rombi e sussurri. E in alto, sopra tutto il putiferio, percepisco il silenzio immobile dell’indifferenza. Ma per mia fortuna non sono al centro di una guerra dimenticata, di un conflitto scordato: è la voce di Raffaele Crocco che evoca scenari assai differenti da quello in cui ci troviamo, io e il giornalista RAI, in quel sabato mattina trentino. Ci siamo incontrati per un’intervista in occasione dell’ottava edizione dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, di cui Crocco è direttore responsabile. Sua è l’idea alla base del progetto, che è lo sforzo di analizzare le tensioni che percorrono la società umana da un nuovo punto di vista: quello della geografia, perché capire dove si trovano i problemi significa anche contestualizzarli nel giusto modo. Anche il modo di intendere la guerra (lo scontro armato) e il conflitto (le divergenze tra individui, gruppi, Stati che non si affrontano con le armi) è inedito: l’una e l’altro sono effetti di diversi fattori che determinano disuguaglianze nella distribuzione globale delle risorse. La lunga chiacchierata che sviscera questi ed altri temi comincia così:
Lei scrive e afferma sempre che la guerra è cambiata e che è una conseguenza. Ci può spiegare com’è mutata e quali sono le sue cause?
Sarebbe un discorso lunghissimo… Proviamo a riassumerlo. Dal punto di vista ufficiale, quello del mondo politico e militare, si parla di guerre simmetriche e guerre asimmetriche. La guerra simmetrica è quando c’è simmetria, equilibrio tra le forze in campo. Tecnicamente, la guerra tra due Stati è simmetrica. Le guerre asimmetriche sono invece quelle in cui le forze sono in qualche modo sbilanciate. Quella che definiamo “guerrilla”, “guerra civile” e “guerra rivoluzionaria” sono normalmente asimmetriche. Ma secondo me, dovremmo parlare anche di guerre simmetricamente asimmetriche. Faccio un esempio. La guerra nella Repubblica democratica del Congo, in corso da anni, è simmetrica e asimmetrica allo stesso tempo: il governo centrale si scontra con bande armate che vogliono controllare porzioni di territorio e bande armate si scontrano con altre bande armate per lo stesso motivo.
In Congo, così come in altre zone dell’Africa che vivono una situazione simile, è quindi in corso una guerra simmetricamente asimmetrica tra forze non regolari che si contendono gli spazi. È una confusione totale! Concretamente, ciò significa che è cambiato il modo di combattere. Le guerre simmetriche si combattevano tra eserciti per il controllo e la conquista di territori e si combattevano lungo le linee del fronte: le popolazioni civili lontane da questo fronte erano coinvolte solo dallo sforzo produttivo necessario per mantenere gli eserciti. La guerra era però concentrata, ripeto, sul fronte. Da quando l’obiettivo dei contendenti non è controllare il territorio, ma controllare l’economia e le forme economiche dei nemici, non c’è più una linea del fronte o i grandi eserciti: è scomparso il bisogno di controllare il territorio, sostituito dalla necessità di indebolire il nemico per costringerlo a fare le scelte economiche che si vuole. Nasce l’esigenza di nuovi strumenti per stremare il nemico. L’arma prescelta per tale scopo è, dagli anni 20 dello scorso secolo e per le guerre simmetriche, l’aviazione: essa colpisce il nemico da lontano e lontano, spaventando anche i civili. Si indebolisce così il fronte interno, che è molto importante – soprattutto nelle democrazie.
Simile sviluppo ha creato una nuova teoria della guerra: l’affermazione del terrore come strumento di guerra. E ciò ovviamente è andato molto al di là dell’uso dell’arma aerea. Il terrore è diventato la forma di combattimento per ogni tipo di guerra. Si terrorizzano le popolazioni per costringerle a cedere: lo stupro, le forme di decapitazione, i kamikaze… Il terrore generalizzato, usato da tutti, eserciti regolari e non regolari. Tutti questi cambiamenti sono avvenuti perché il mondo si è globalizzato: la perdita di una dimensione nazionale pura ha fatto perdere interesse (e qui facciamo un passo indietro) per la conquista del territorio e ha dato spazio a guerre in cui ci si contende il controllo delle risorse. Per cui oggi viviamo in un mondo sconvolto da conflitti multinazionali combattuti da forze armate che spesso sono multinazionali. Comprese le forze di guerrilla, spesso sovranazionali. I guerriglieri di Congo, Uganda, Camerun o Boko Haram sono esempi esplicativi della situazione… Il superamento dello stato nazionale ha cambiato profondamente la guerra.
Mi pare di capire che le cause della guerra, in fondo, non siano mai cambiate. Che si tratti di territorio o di economia, i conflitti si scatenano sempre per il controllo delle risorse. Corretto?Se tutto è cambiato, la sola cosa rimasta uguale è quella: l’obiettivo della guerra è sempre arrivare a controllare risorse.
Secondo lei, quali conflitti maggiormente coinvolgo le nuove generazioni? Da un punto di vista emotivo e concreto…
Nei fatti, qualunque conflitto. Come dicevo l’altra sera, una cosa che abbiamo imparato lavorando all’Atlante e che io ho imparato personalmente è che tutto ciò che è apparentemente lontano è in realtà vicinissimo. Facciamo un esempio prendendo in considerazione un conflitto sociale che, senza essere una guerra combattuta, è molto sentito. Il conflitto che si è voluto scatenare attorno al fenomeno dei migranti sta distruggendo il diritto al lavoro delle nuove generazioni perché indebolisce ogni possibilità di intervento contrattuale, normativo rispetto a quelli che abbiamo definito come diritti del lavoro. La dignità del lavoro, gli orari, la sicurezza del lavoro, la dignità del salario: tutto distrutto con la competizione creata tra chi arriva e chi rimane. Gli ultimi contro i penultimi.
Quindi, conflitti apparentemente lontani, che spingono le persone ad andarsene, riguardano direttamente i giovani. Il problema del land grabbing in Mali, che costringe le popolazioni a migrare, coinvolge tutti. Il problema dell’acqua in Siria, causato dalla costruzione di una diga che ha prosciugato e reso incoltivabili i territori circostanti, ha costretto 800.000 persone ad andarsene dal Paese già prima dell’attuale conflitto… Significa che ha immediati riscontri qui. Ogni conflitto in corso ha effetti tangibili sulla società, anche perché ha effetti economici immediati. Prendiamo il caso della pirateria… I pirati producono costi per la comunità internazionale equivalenti a una decina di miliardi di dollari l’anno: maggior benzina, assicurazioni, mercenari che difendono le navi. Questi sono tutti costi di trasporto pagati da chi compra la merce, da noi consumatori. Le conseguenze della guerra sono sempre molto dirette, quindi.
Viste le premesse, la conclusione di un conflitto è un bene per tutti. Vivere in armonia è un bene per la comunità internazionale. Come lei stesso ribadisce spesso, però, la fine della guerra non coincide con l’inizio della pace. Quando finisce l’una e soprattutto quando inizia l’altra?
Questa è una domanda fondamentale. Ritengo che la guerra finisca quando i meccanismi di riconciliazione si sono conclusi. Per “meccanismi di riconciliazione” intendo il fatto che tutti i protagonisti della guerra si sono presi le loro responsabilità: vittime e carnefici hanno chiarito le rispettive posizioni e hanno deciso di andare avanti. Da una simile prospettiva, un esempio di “fine guerra” efficace è il Sudafrica di Mandela che è uscito dalla tragedia dell’apartheid senza combattere, attraverso un lungo e dolorosissimo processo di riconciliazione pubblica. La Germania, così come altri paesi, hanno faticosamente fatto i conti con il loro passato.
Per l’Italia, invece, la strada è ancora lunga. Nel nostro paese, ci sono fenomeni di razzismo che riemergono, non emergono… Ma la società non vuole ammettere la recidiva. Il nostro paese non ha mai chiesto scusa alla comunità ebraica per le leggi razziali, che furono infinitamente più dure di quelle naziste – almeno all’inizio, perché bloccammo subito l’insegnamento dei professori ebrei, mentre la Germania nazista ci mise più tempo. Non ammettiamo di aver contribuito allo sterminio ebreo: avevamo un campo di sterminio in casa, perché la Risiera di San Sabba a Trieste era un campo di sterminio, non di concentramento. Non abbiamo mai chiesto scusa agli Africani per la Rivista della razza , su cui ha scritto quel Giorgio Almirante a cui volevano dedicare una via a Roma poche settimane fa. Come tutti gli altri, Almirante scriveva che la superiore razza bianca non poteva mischiarsi all’inferiore razza nera. Il divieto era così sentito che c’era un reato specifico: se un uomo italiano (all’epoca le questioni di genere erano molto più forti) andava con una donna nera era condannato al carcere. La Rivista giustificava la discriminazione, gli scienziati giravano l’Africa a misurare i crani degli indigeni per dimostrare che la razza bianca era superiore e la razza italica ancora di più.
Noi non abbiamo mai chiesto scusa, per niente, e non insegniamo nulla di tutto ciò. Vuol dire che cresciamo col mito degli italiani brava gente, mentre siamo stati i primi al mondo a usare armi chimiche contro popolazioni civili nel corso di una guerra. Ribadisco, non abbiamo mai chiesto scusa. Siamo ancora qui a giustificare il fascismo! Si può tranquillamente sostenere che l’Italia non sia mai uscita dalla Seconda guerra mondiale, dal momento che non si è mai riconciliata alla sua storia. E senza fenomeno di riconciliazione non c’è pacificazione: la pace comincia quando il fenomeno di riconciliazione che deve necessariamente seguire la guerra si compie. Ancora una volta, la nostra penisola ne è la prova: le dichiarazioni dei Ministri in questi giorni sono profondamente inquietanti. Ma pure in Bosnia c’è ancora la guerra, poiché le comunità non si sono mai rappacificate e anzi continuano ad alimentare l’odio reciproco. Stessa cosa in Croazia, Kosovo, Iraq, Afghanistan. Quel che è peggio è che noi continuiamo a pensare che vi sia un legame stretto tra guerra e pace: non è così, guerra e pace sono due cose completamente staccate.
Dobbiamo separare la pace dalla guerra. La pace deve essere un modo strutturale di vivere della società umana, che può essere interrotto dalla guerra oppure no. Va costruita in modo autonomo, attraverso strumenti che noi già possediamo. Sono gli stessi strumenti che ci permettono di evitare l’arrivo del conflitto. Perché la guerra è sempre evitabile, non è vero il contrario. Si pensa all’inevitabilità dei conflitti per giustificarli, ma la guerra è da ritenere ingiusitificabile sempre e comunque. Quando la vedremo così, allora cominceremo a costruire i modi per evitare le guerre nel mondo.
E stando a quanto è emerso durante la serata di presentazione del nuovo Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, uno dei modi per evitare la guerra è mostrarne la superfluità e la stupidità. L’Atlante stesso ha lo scopo di informare il suo pubblico delle cause dei conflitti e di suggerire direzioni per costruire di sistemi di pace. Come redazione, avete deciso di raccontare la guerra in modo partigiano – ossia assumendo il punto di vista delle vittime. Come ci si pone nei confronti dei combattenti da questa prospettiva?
Ah, sono tutti cattivi (ride)… No, sto scherzando ovviamente. Non si tratta di dire che i combattenti sono tutti cattivi. Dipende dai casi. Faccio un esempio banale: l’esercito italiano è impegnato in molte missioni all’estero, ma i 6.500 uomini e donne che combattono non hanno certamente una postura “da cattivi”. Sono persone preparate, che sanno cosa fare.
Come in tutte le guerre, è purtroppo ovvio che anche l’esercito italiano causi ingiustizie e morti che non dovrebbero esserci. È l’effetto collaterale di tutte le guerre. Definire i cattivi esige dunque immedesimarsi nelle situazioni specifiche… I Palestinesi sono vittime della storia e degli Israeliani, ma un Palestinese che si fa saltare in aria e ammazza cinque bambini è cattivo. Non ho e non avrò mai dubbi su questo. Calarsi dalla parte delle vittime significa rimanere accanto a chi subisce la guerra, pur capendo le ragioni di chi combatte. Chi sceglie le armi prende una decisione molto consapevole, rispetto alla quale i comportamenti diventano discriminanti, perché decidono la posizione di chi si arma. L’Atlante è stato molto attento a questo aspetto, soprattutto nell’utilizzo delle parole.
Ritornando all’esempio che ho fatto prima, un Palestinese che uccide cinque bambini è un “terrorista”: lo definisco così tenendo in considerazione che ha stabilito deliberatamente di colpire civili. Se quel Palestinese facesse saltare un carro armato israeliano, allora lo definirei un combattente. Questo discrimine è fondamentale. La ragione che muove le azioni e determina gli obiettivi diventa essenziale per capire chi davvero supera il limite. Attenzione, la scelta dell’obiettivo, non tanto la motivazione: questa può essere nobile (per esempio, voglio una migliore distribuzione dei diritti), ma la decisione dell’obiettivo modifica la situazione. Bisogna avere la pazienza di lavorare su queste distinzioni, per capire bene cosa sta succedendo. Sempre tenendo al centro le persone, raccontando la guerra dal loro punto di vista… Perché la guerra è orrenda. La guerra è brutta: sembra un’affermazione banale, ma non lo è. La guerra fa schifo: è esteticamente brutta, puzza, devasta gli esseri umani – ogni singolo uomo e donna, chi è stato in guerra non è più quello di prima. O lo si capisce in profondità o si continua a pensare alla guerra solo attraverso macro-concetti. Sono sicuramente utili e giusti, ma a conti fatti la guerra riguarda gli uomini e le donne violentati, i bambini che perdono i genitori, chi deve abbandonare tutto e fuggire da casa, chi ha avuto morti intorno. La guerra è questo.
Vorrei riprendere un attimo il tema del racconto. Proprio perché la guerra è un’esperienza tanto tragica, immagino che lo sforzo per trovare e definire un lessico appropriato per descriverla sia notevole. Nell’Atlante, però, ci siete riusciti. Avete anche creato un glossario all’interno della pubblicazione, per spiegare l’interpretazione delle parole che usate. Come si crea un vocabolario della guerra? Quali sono le parole giuste per rappresentare i conflitti?L’Atlante si è dato regole che hanno una base filosofica, psicologica, spirituale molto forte. Premetto che sono un laico integrale e integralista e quindi fatico a divinizzare le cose… a parte Maradona (ride)… Non ho divinizzato la Dichiarazione dei diritti della persona, ma ritengo che sia essenziale e soprattutto che sia il testo più bello che abbiamo scritto sul tema. La ritengo il vero architrave su cui fondare un mondo diverso, perché è il luogo nel quale tutti (al di là delle ideologie) hanno concordato su dei fondamentali. È l’occasione che permette a tutti di attestarsi su punti comuni – la loro gestione sarà poi sede delle differenze. Questa carta ci ha fornito gli strumenti per definire le parole e lavorarle.
Io credo quindi che si debba partire da essa per definire cosa sono guerra, terrorismo, libertà… Perché le parole devono essere definite a partire da idee, posizioni che tutti hanno accettato e condiviso. Riallacciandomi a quanto detto prima, distinguere tra terrorista e combattente è un’operazione possibile grazie alla Dichiarazione, nella quale si legge che ogni cittadino e popolo ha diritto all’autodeterminazione, alla scelta della propria forma di governo, alla libertà di pensiero ed espressione: basandoci su tale principio, capiamo quando un individuo ha motivo di reagire a un potere dal quale si sente oppresso. In altre parole, sappiamo che un Tibetano che decide di ribellarsi alla Cina ha ragioni valide. Come si ribella crea il discrimine.
Abbiamo quindi strumenti validi per definire le parole. E dobbiamo farlo, in quanto la parola è ciò che ci consente di capire fino in fondo, di evitare la confusione. Non esiste una verità assoluta nell’informazione, i punti di vista sui fatti sono tanti, ma esiste la verità delle parole. Sono sempre affascinato dall’atto creativo di Dio, che non è stato fare le cose ma dare loro un nome. Dio non ha creato il mondo, tecnicamente lo ha nominato: ha detto “quello è leone, albero, fiume…”. Ha dato un nome. Se una cosa non ha un nome non esiste. Le parole sono fondamentali perché creano. Se sbagliamo parole, creiamo idee sbagliate. Non a caso, in questo paese, dove stiamo usando da anni parole sbagliate, abbiamo creato idee sbagliate.
Incapace di essere sincera rispetto al proprio passato e di usare il lessico adeguato alla sua condizione, guidata da ministri che sostengono tesi disturbanti: il quadro del Paese che lei traccia non è dei migliori. Rincaro la dose: i partiti che ci governano innalzano la chiusura verso l’Altro (sia esso l’Europa o l’immigrato) a uno dei valori fondamentali della nostra democrazia e sembrano accarezzare l’idea di un governo forte alla Macron (premier francese). Viene da chiedersi quanto l’Italia è in guerra con sé stessa.L’Italia è in guerra con sé stessa da sempre. Siamo un paese molto strano. Ripeto, siamo un paese che non ha mai fatto i conti con sé stesso, che non si racconta mai onestamente. Sono molto duro rispetto a questo e l’ho scritto anche in un mio recente editoriale, quando il candidato leghista per la presidenza della Regione Lombardia disse che è necessario difendere i valori dei bianchi dall’arrivo dei migranti. Questo ribadisce che, come ho già detto prima, noi siamo un Paese razzista che non ha mai fatto i conti col proprio razzismo, perché non l’ha mai voluto ammettere.
Siamo un Paese per costituzione anti-fascista, ma oggi pare una vergogna essere anti-fascisti. Negare la realtà dei fatti è un problema gravissimo. Siamo il Paese che ha inventato il fascismo. Nell’ultima sua intervista rilasciata al Corriere nel 1945, Mussolini se ne uscì con una frase molto significativa per capire chi siamo noi italiani. Il giornalista gli disse che poteva essere soddisfatto, che sarebbe passato alla storia come l’uomo che aveva inventato il fascismo, ma Mussolini gli rispose di non aver inventato il fascismo, di averlo semplicemente tratto dalla pancia degli italiani. Ci deve fare riflettere…
I nostri comportamenti dimostrano che in tutti questi anni nessuno ha mai fatto lo sforzo di creare una diversa cultura della democrazia e dell’appartenenza. Come cittadini abbiamo delegato troppo. Nei momenti di maggiore prosperità dell’informazione, si vendevano 6 milioni di copie di quotidiano su 60 milioni di abitanti: solo un cittadino su dieci comprava il giornale. Non ci informavano, andavamo per schemi preconfezionati. Restavamo all’oscuro della nostra storia.Così, la spaccatura tra Nord e Sud e tra Est e Ovest si è allargata nell’incoscienza di tutti. Tutti si sono dimenticati dell’occupazione militare dei bersaglieri in Lucania tra 1861 e 1866, quando le leggi marziali consentivano di fucilare uomini, donne e bambini perché ritenuti affiliati alla briganteria: una guerra costata migliaia di morti di cui però noi non parliamo. Così come tacciamo sul destino dei paesi siciliani bombardati dall’esercito italiano nel 1946, perché la Sicilia con il suo movimento indipendendista voleva staccarsi dall’Italia. Nei libri parliamo a ragione della Prima guerra mondiale come la Quarta guerra d’indipendenza, ma non parliamo di cosa trentini e triestini pensavano di quella situazione. Non riportiamo l’obbligo forzato dei triestini a italianizzare il proprio cognome per poter lavorare. E questo prima del fascismo, prima del ’20.
Questi episodi, li sappiamo perché qualcuno li racconta, ma la storia ufficiale e il nostro atteggiamento come popolo e cittadini è e rimane dimenticarsene, non sapere. Sono carenze che stanno diventando strutturali nel nostro essere cittadini e che ci portano a essere in guerra con e fra di noi, a non capirci. A non capire il mondo che ci sta attorno.
Siamo uno dei Paesi fondatori dell’Unione Europea, una grande idea. Non questa Unione, che va rifondata… L’UE con la sua libertà di circolazione è fantastica. Per quelli della mia generazione, che avevano bisogno del passaporto per andare in Austria, andare oggi da Palermo a Copenaghen senza ostacoli è meraviglioso! Non devo cambiare i soldi, se so l’inglese vado dappertutto… Diamo per scontato questa enorme possibilità. Settant’anni fa l’Europa ha scatenato sul suo territorio una guerra da 200 milioni di profughi e 70 milioni di morti. Trent’anni anni prima ha scatenato un’altra guerra, perché Tedeschi e Francesi non andavano d’accordo e perché gli Italiani volevamo l’Istria! Ora è finita, la storia ha sepolto le divisioni e le tensioni. È grandioso. Dopodiché, non è grandioso che siano le banche a governare l’Europa, dovremmo essere noi cittadini. Ma se noi cittadini non andiamo dai nostri rappresentanti a pretendere che in Europa si vada con idee sull’Unione e sui suoi temi; se non siamo i primi a sottolineare che l’UE non è il cimitero degli elefanti dei politici che hanno fallito in Italia, un cambiamento non può avvenire.
Questo è diretta conseguenza del fatto che non ci assumiamo la responsabilità di cittadinanza, presupposto della democrazia: ognuno deve fare un po’ di fatica, deve metterci un po’ di impegno personale per fondare la democrazia. Che è faticosa poiché innaturale e per questo fantastica, dal momento che è la decisione presa all’unisono da tutti di accettare regole che normino la comunità. È proprio la fatica, però, che ci differenzia dal resto.
Lo sforzo di informarsi, di capire davvero ciò che ci accade attorno, di pretendere che i politici agiscano in modo coerente e consapevole rispetto al contesto nel quale si trovano sono gli obiettivi che Raffaele Crocco propone ai suoi lettori. L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo è sicuramente uno strumento utile al loro raggiungimento. Sfogliarlo, leggerlo, studiarlo è il primo passo per assumersi la responsabilità di essere cittadini nel e del mondo.