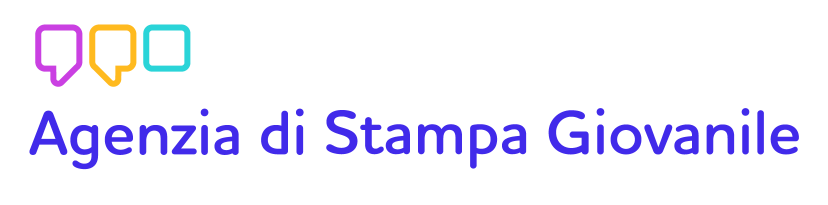Black Mirror: lo specchio che riflette l’umanità intera e su cui vale la pena riflettere
di Paola Rizzo da La macchina sognante
Costanti e variabili- “Black Mirror” porta con sé il presente nel suo stesso nome: “specchio nero”. Siamo circondati da specchi tenebrosi; ovunque possiamo vedere la nostra immagine riflessa su una superficie opaca: quella del nostro smartphone, del nostro tablet, del nostro PC, della televisione. Ma cosa vediamo su quelle superfici? Vediamo un’immagine che può sembrarci eccessiva solo a un primo sguardo: se osserviamo con più attenzione, scopriamo che quell’immagine ha contorni simili, persino sovrapponibili, alla realtà che ci circonda. Può sembrarci che “Black Mirror” racconti dell’era digitale, dei pericoli che si insinuano nel progresso illimitato delle tecnologie, ma sbaglieremmo: sceglieremmo di vedere solo l’immagine più epidermica prodotta dallo specchio. Lo specchio ci mostra che la tecnologia, di per se stessa, è solo uno strumento e siamo noi ad esserne attivi fruitori. Quanto più quello strumento si perfeziona, tanto più noi corriamo il rischio di un ribaltamento dei rapporti: lo strumento potrebbe diventare entità attiva e noi potremmo scoprire di essere diventati soggetti passivi, subordinati a qualcosa su cui ci illudevamo di poter esercitare il nostro controllo. I nuclei pulsanti di “Black Mirror” sono sempre gli esseri umani, indagati nei loro comportamenti perenni, nel groviglio delle loro debolezze, istinti, aspirazioni. Sono sofisticatissime (ma, non troppo lontane da quelle che già utilizziamo) le tecnologie intorno alle quali lavora “Black Mirror”; ma riconducibili a una sorta di substrato atavico, i comportamenti, i pensieri, i sentimenti dei personaggi che si servono di quelle tecnologie. Cambia il mondo intorno agli esseri umani, ma gli esseri umani conservano delle costanti immodificabili. Gli esseri umani sono egoisti; chiusi nel recinto delle loro piccole miserie; sono involontariamente ridicoli; sono incapaci di provare empatia; ma sono anche capaci, in alcuni casi (finora pochi, in “Black Mirror”, ma comunque significativi), di scatti di autenticità, gentilezza, amore. “Black Mirror” racconta la fenomenologia dell’umano rapportandola ai mezzi moderni e ultramoderni attraverso cui quella fenomenologia potrebbe manifestarsi.
Oltrepassare un cartello su cui c’è scritto: “Divieto d’accesso”– Fin dal suo esordio, “Black Mirror” rivela il suo programma. Già, perché “National Anthem” non è tanto (o non è solo) una riflessione intorno alla pervasività dei mass-media; è una riflessione intorno al pubblico che la rende possibile. Al pubblico non interessa cosa ne sarà della principessa Susannah rapita da un misterioso sequestratore; al pubblico interessa cosa farà il Primo Ministro ricattato da quel sequestratore. Agli esseri umani interessa assistere a un’umiliazione che si consumerà sui teleschermi di tutto il mondo e – ancor prima di assistervi – già la pregustano: “It’a already happening in their heads. In their heads, that’s what you’re doing!” E anche a noi spettatori importa poco della principessa: fin dall’inizio, abbiamo sperato che il Primo Ministro cedesse a quel ricatto. Magari abbiamo mostrato la nostra indignazione ma – in realtà – ci entusiasmavamo all’idea che quello scandalo sarebbe passato di bocca in bocca, di giornale in giornale, di televisione in televisione, di link in link, di social in social. Non solo la vita del Primo Ministro può essere compromessa dall’intrusione di un grande occhio collettivo. Anche vite più ordinarie possono essere esposte al pericolo che uno sguardo indiscreto frughi in uno spazio che non solo dovrebbe restare privato, ma segreto. Vari episodi di “Black Mirror” si incardinano sul tema della privacy violata. Anche se quella violazione è mossa dal un genuino (o morboso?) istinto protettivo di un “Arkangel”, i suoi effetti possono essere distruttivi. Una madre che, attraverso un microchip e un tablet, può spiare ciò che accade nel cervello della figlia e censurare possibili fonti esterne di stress e traumi, non sta semplicemente violando un’interiorità. Quell’ingerenza, che dovrebbe tutelare e tenere lontano il pericolo, è il pericolo: il pericolo di una protezione che diventa soffocamento. La profanazione della sfera privata ha sempre conseguenze nefaste e lo specchio mostra l’ampia gamma di quelle conseguenze. Cosa accadrebbe se, per esempio, lo spazio segretissimo del ricordo potesse essere riprodotto su uno schermo? Cosa accadrebbe se ogni secondo del nostro vissuto potesse essere registrato e rivisto? Tutto questo ci renderebbe sempre più diffidenti nei confronti degli altri; avremmo bisogno di ritornare a un passato che è lì, pronto ad essere esaminato e riesaminato. Poter rivedere nei suoi contorni esatti il passato non ci consentirebbe di andare avanti. “The Entire History of You” è un dramma familiare che esplode quando dei ricordi tornano a galla e caricano il presente di ossessioni e paranoie. Il peso di un passato che doveva restare nascosto nella memoria e che la tecnologia disseppellisce è anche il tema di “Crocodile”. Mia è in trappola: un evento oscuro del passato potrebbe travolgerla e un congegno che setaccia i ricordi fa riemergere quell’evento. “Private stuff is private stuff” ripete Shazia, la sfortunata agente assicurativa che incrocia Mia sul proprio cammino. Quella “Private stuff” può essere un zavorra che ci piomba addosso e – insieme a noi – schiaccia delle vite che si sono avvicinate troppo al punto dell’impatto. Mia impara a ragionare con la mente fredda di un rettile: ogni umana pietà passa in secondo piano, dinnanzi alla minaccia di una reputazione inquinata.
La cultura della vergogna- La “cultura della vergogna” che Dodds rintracciava nella civiltà omerica continua ad essere la radice del nostro mondo ipertecnologico. Siamo sempre più esposti all’occhio giudicante degli altri. Il nostro bisogno di essere accettati, oggi, trova soprattutto nei social uno spazio di sfogo. La nostra vita – così come vogliamo che venga vista dai nostri followers – è sempre più sfolgorante di quella che affrontiamo quotidianamente. Lacie, che vuole incrementare il punteggio di gradimento pendente sulla sua testa, è ciascuno di noi. Le mille simulazioni messe in atto da Lacie, sono le stesse che ciascuno di noi compie per sentirsi parte di una comunità. La storia di Lacie, però, non è solo la storia di chi tenta di volare alto accumulando punti di gradimento: è anche la storia di chi sperimenta l’ebbrezza della caduta libera (della “Nosedive”) e della fuga. La libertà ha il suono di un viscerale “fuck you” lanciato al di là delle sbarre sorrisi plastificati, delle frasi di circostanza. Lacie, con la sua ribellione, riesce a scrollarsi di dosso il peso di un sistema che, a lungo, l’ha obbligata a sacrificare ogni autenticità. Al contrario, “15 Millions Merits” è la storia di una ribellione fagocitata da un sistema fondato sulle apparenze, sulla ricerca spasmodica della fama, sull’umiliazione di chi non riesce a uniformarsi. “Nel futuro, ognuno sarà famoso per 15 minuti”, diceva Andy Wahrol. Per quei 15 minuti di fama, tu cosa saresti disposto a fare? In un futuro non troppo lontano, forse saresti persino disposto a sostituire la tua identità con quella di un avatar; saresti disposto a collezionare punti per accedere a un talent in cui ciò che vali dipende da una giuria che, armata di pulsantoni rossi, attende la tua esibizione. In quel futuro, Bing Madsen si aggrappa a una voce diversa dalle altre: “I look around here, I just want something real to happen. Just once”. Tuttavia, il sistema brutto e abbruttente che Bing tenta di redimere col tuo sogno, abbruttisce il suo sogno e lo distrugge. E – poco a poco – Bing capisce che non può combattere il sistema, può solo farne parte. Bing vive in una società in cui ogni uomo è una merce e deve sapersi vendere perché, altrimenti, potrebbe fare la fine del ciccione attaccato a un palo che viene schernito, potrebbe diventare un risibile escluso.La “cultura della vergogna” – attraverso la tecnologia – può agire anche in contesti che non si limitano ad essere vicini, ma che replicano fedelmente la realtà che già stiamo vivendo. Ogni volta che utilizziamo i social, che facciamo una ricerca in rete, noi accettiamo di correre un rischio: di poter essere privati della facciata rispettabile che frapponiamo tra noi e il mondo esterno. L’hacking, il pericolo che qualcuno scopra delle parti di noi inaccettabili, il groviglio di paure che si innescano quando quel qualcuno minaccia di rivelare al mondo una perversione ignominiosa è il fulcro tematico su cui si incardina “Shut Up and Dance”: un thriller psicologico che si svolge tutto nello spazio di un’interiorità che – dopo avere a lungo nascosto un segreto inconfessabile – scopre di non avere scampo: la reazione dell’opinione pubblica sarà spietata.
L’insostenibile leggerezza dell’odio- “Black Mirror”, ci mostra anche questo: il volto di una comunità che, nello stesso momento in cui denuncia la disumanità, è disumana e che ha bisogno di vedere l’orrore (e persino di renderlo un’attrazione collettiva) in qualcun altro per poter dimenticare l’orrore che si annida al suo interno. “White Bear”è lo specchio su cui si riflette il compiacimento del pubblico che applaude dinnanzi al colpevole condannato a una punizione implacabile: la giustizia diventa spettacolarizzazione della pena, vendetta, rituale catartico che consente a un’intera società di poter riversare su una vittima sacrificale l’espiazione dei propri peccati. Il trasgressore va ostracizzato dal mondo degli uomini per bene. E ci sentiamo tutti più al sicuro, quando il colpevole viene rimosso con un semplice blocco, con la stessa facilità con cui ci sbarazziamo di un contatto che ci tempesta di messaggi indesiderati. Del colpevole rimane una sagoma rossa, privata della parola e privata di un volto. Solo allora, possiamo celebrare il nostro “White Christmas” nella sicurezza di una pace non più intaccabile e la nostra coscienza non avverte alcun peso, perché la nostra coscienza sta lì, all’interno di un piccolo cookie che contiene le nostre emozioni, i nostri ricordi, le nostre abitudini ma al di fuori di noi, nei confini di un’asettica stanza virtuale. A Natale, tutti ci sentiamo indulgenti nei confronti del prossimo, ma solo se quel prossimo non è una sagoma di colore rosso. La nostra rabbia va sempre in cerca di bersagli su cui sfogarsi. Ma lo specchio ci mette in guardia: la bruttura è endogena, abita le strutture stesse della comunità di cui facciamo parte. La bruttura non è quella dei mutanti, dei “parassiti” che minacciano le nostre solide strutture civili. La bruttura è nelle nostre strutture civili che – per essere solide, per occultare l’incendio che le sta incenerendo – hanno bisogno di catalizzare la paura e l’odio verso l’esterno. Con delle comode maschere, possiamo dare inizio allo spettacolo: possiamo credere che, quando avremo eliminato i “parassiti”, l’incendio avrà fine; “Men Against Fire” potrebbe recare come sottotitolo “Men Against Fire that prefer to ignore the real cause of the Fire”.Quell’incendio e la deriva irrazionale che lo alimenta possono, però, assumere altre forme; la forma, ad esempio, di una democrazia che degenera in oclocrazia. Quando il coltello dei mass-media affonda in delle ferite già suppurate, è la fine: potrebbe persino accadere che il “Fuck them all!” gridato da orsetto digitale dal colore blu diventi un linguaggio politico, amplificato dalle televisioni, da internet, dalle views su YouTube. Waldo è il prodotto di una società che si è illusa che il problema fosse esterno: politici corrotti e incompetenti; senza capire che rappresentanti privi di etica e di valori civili sono il riflesso di un elettorato privo di etica e di valori civili. “The Waldo Moment”non è fantapolitica: quel momento affiora costantemente nelle nostre democrazie. E non è il caso di fornire esempi di seguaci di Waldo che, al di fuori di “Black Mirror, hanno conquistato il potere.La tecnologia può, dunque, esacerbare un malessere che tutti si ostinano prima a negare, poi a indicare con nomi rassicuranti, poi ancora a ricondurre a un comodo responsabile. L’odio che ci divora prima lo neghiamo, poi lo esprimiamo in forme tollerate, poi andiamo in cerca di un responsabile che ci ha portati a nutrire quell’odio. L’”Odio universale” (il titolo italiano è molto più efficace di “Hated in the Nation”) che divora le coscienze ci appare non così tanto grave se, per esempio, quell’odio ha la forma delle quattro sbarrette di un hashtag. Con il ritmo di un racconto giallo, “Hated in the Nation” conduce un’inchiesta intorno a un malessere diffuso che esplode quando la miccia di un hashtag viene accesa. Il reticolato vastissimo dei #DeathTo ci fornisce la mappatura di una società che applica la pena di morte a colpi di campagne virali di odio. E sono tantissimi i casi in cui – nella vita reale – ci è parso di poter passare oltre un hashtag velenoso, un post sguaiato, un insulto letto su una chat. Ci è parso che la violenza confinata nello spazio di una piazza virtuale fosse meno grave di quella che di manifesta in uno spazio concreto. Eppure, durante la visione di “USS Callister”, noi non riusciamo ad essere dello stesso avviso; proviamo ribrezzo nei confronti della violenza che vediamo. Proviamo compassione per degli avatar costretti da un crudele programmatore-videogiocatore a subire continue torture. Quella violenza – anche se si consuma in un mondo digitale – la percepiamo in tutta la sua concretezza e, per questo, la condanniamo. “Black Mirror” è anche questo: esseri umani che magari restano indifferenti quando un utente di Facebook viene bersagliato di insulti; ma che riescono ad essere empatici nei confronti degli abitanti di videogioco. Nei contesti virtuali, quindi – ancora di più che nella realtà fisica – possono rivelarsi le nostre contraddizioni: la nostra bassezza, ma anche i nostri moti più solidali. Il mondo virtuale, in questi casi, diventa più reale del reale.
La sottile linea rossa tra reale e non-reale- Sulla sovrapposizione tra reale e non-reale e sugli effetti che questo connubio può produrre, “Black Mirror” riflette in alcuni episodi che raccontano di storie intime e di personaggi fragili. “Be right back”affronta un tema insidioso: l’elaborazione del lutto. Martha perde il suo compagno Ash in un incidente stradale. L’utilizzo di un software consente a Martha di avere l’illusione di poter continuare a scambiare messaggi con Ash, di poter parlare con lui al telefono come se nulla fosse accaduto, fino al salto di qualità: un clone sintetico di Ash in casa. La tecnologia consente a Martha bypassare la realtà: è più facile credere che le persone che amiamo e che abbiamo perso siano ancora con noi, piuttosto che dover fare i conti con la loro assenza. Ma un clone sintetico non potrà mai essere Ash e Martha lo sa; non ha però la forza sbarazzarsi di un surrogato che porta comunque con sé l’identità di una persona amata. Uccidere la copia di Ash significherebbe uccidere, una seconda volta, Ash. Realtà della perdita e incapacità di accettare la perdita rimarranno i due estremi con i quali Martha dovrà fare i conti per il resto della vita. Anche la realtà aumentata, miraggio inseguito dal mercato video-ludico, può costituire un pericolo: la realtà che viviamo quotidianamente – già di per sé – può essere mostruosa e dovremmo cercare di non rendere quella mostruosità ancora più acutamente percepibile, anche solo entro i confini di un videogioco. Cooper smarrisce – man mano che il chip installato dietro al suo collo trasforma in immagini le sue paure – la capacità di distinguere il reale dal virtuale. E smarrisce quella capacità perché ha sottovalutato i rischi tanto del reale quanto del virtuale. Cooper non si pone delle domande intorno al “Playtest”cui si sta sottoponendo, ha l’illusione di poter affrontare le dinamiche di quel videogioco. Invece, la casa infestata in cui è catapultato assume contorni sempre più reali e questo perché le paure che prendono forma in quella casa sono reali. Come accade negli horror più canonici, il personaggio incauto e sicuro di poter affrontare i mostri, finisce nelle grinfie dei mostri. Quando sottovalutiamo i rischi di una tecnologia, ci esponiamo al rischio di essere sopraffatti da quella tecnologia. L’incapacità di distinguere il reale dal virtuale è un’esperienza che vive – in prima persona – lo spettatore di “Black Mirror” durante la visione di “Hang the Dj”, un episodio tutto giocato su un finale imprevedibile. Ci pare di avere a che fare con una distopia in cui le relazioni amorose sono dettate dai risultati di un congegno chiamato “Coach”. Frank ed Amy, conosciutisi attraverso il Coach, decidono di evadere dalla distopia ma, proprio mentre i due sono in fuga, gli spettatori scoprono che quello che sembrava reale era virtuale. I Frank e Amy che abbiamo conosciuto fanno parte dell’algoritmo di un’app per incontri. Quell’app ha stimato che, su 1000 simulazioni, i Frank e Amy virtuali si sono congiunti e ribellati in 998 casi, il 99,8% delle volte. I Frank e Amy in carne ed ossa li conosciamo sul finire dell’episodio – con i loro smartphones alla mano – intenti a leggere i risultati della loro app. Un lieto fine, dunque, che tuttavia conserva zone d’ombra. Ci piacerebbe davvero intrecciare le nostre relazioni sulla base del punteggio ricavato da un’app? Le delusioni che accumuliamo, quando ci leghiamo agli altri, contribuiscono a fondare la nostra identità. Vogliamo davvero rinunciare al nostro diritto di cadere e rialzarci perché un’app ci ha indicato – con un’esattezza del 99,8% – quale sarà la nostra anima gemella?
Attraverso lo Specchio Nero e la luce che Alice vi trovò- A volte, la luce che riusciamo a vedere attraversando specchio, invece, riesce a redimere l’ombra. Quello di “Metalhead”potrebbe sembrare uno scenario dominato da ombre pesantissime e incombenti su una realtà priva di qualsiasi possibilità di salvezza. Invece, “Metalhead” dimostra che la luce esiste, continuamente minacciata dalla tenebra, spesso sconfitta, ma esiste. “Metalhead” ci dimostra che accanto a un’umanità che ferisce, esiste un’umanità che cura quelle ferite. In un futuro apocalittico in cui gli uomini hanno progettato cani robotici che braccano e uccidono; esiste un’umanità che rinuncia a qualsiasi egoistica spinta auto-conservativa, solo per poter conquistare il più delicato dei tesori. Quella scatola che rivela il suo contenuto, proietta una luce accecante su tutto ciò abbiamo visto fino a quel momento. “Metalhead” non è la storia della tenebra che vince la luce, ma della luce che continua a resistere anche quando sul mondo cala il buio. Gli uomini sono capaci anche di questo: di atti d’amore grandiosi; sono capaci rendere il pianeta Terra un posto migliore anzi, potrebbero persino costruire sulla terra il Paradiso: “Heaven is a place on Heart”. La tecnologia, in “San Junipero”,è il mezzo attraverso cui gli uomini compiono un atto dolcissimo gli uni nei confronti degli altri: proteggersi reciprocamente dalla caducità. “San Junipero” è una storia di egoismi che vengono messi da parte in favore dell’altro, di una tecnologia che consente all’amore di valicare il confine della morte. L’immortalità dell’anima è un dono che l’umanità fa a se stessa. “San Junipero” ci dimostra che il paradiso può avere tante forme: la forma di una località balneare immersa negli anni ’80; la forma di un cimitero ipertecnologico che, al posto dei loculi, ha dei piccoli drive di memoria e che – invece di essere abitato dai fantasmi dei morti – è abitato da coscienze vive che si cercano, si rincorrono, hanno bisogno le une delle altre per essere felici.
Meta-narrazioni: imparare a guardarsi allo specchio- Alcuni frammenti dello specchio, nell’economia di “Black Mirror”, costituiscono dei manifesti programmatici, tentativi di comunicare l’idea che sta alla base della serie. Nella forma mini-antologia in un’antologia, “Black Museum”sviluppa una riflessione incentrata sull’esperienza dello spettatore. Quando guardiamo “Black Mirror”, noi ci aggiriamo nelle stanze di un museo in cui ogni oggetto racconta una storia non di tecnologie, ma di esseri umani. Il museo di Rolo Haynes esibisce cimeli che portano con sé delle vicende oscure e che noi conosciamo bene. Esattamente come per i sadici visitatori del museo, anche a noi è piaciuto ascoltare quelle storie. Siamo parte di un’umanità che non riuscirà mai a mettere totalmente da parte il gusto della contemplazione del dolore altrui. Anche se sappiamo che è sbagliato figgere su quel dolore le nostre pupille, non riusciamo a chiudere gli occhi. E quindi, anche se ci sconcerta la catabasi dottor Peter Dawson che – in un crescendo di violenze – soddisfa la brama irrefrenabile dell’infliggersi e dell’infliggere dolore, non possiamo fare a meno che assistere a quella caduta. Anche se proviamo pena per una coscienza che sopravvive a un corpo diventato prigione solo per trovarsi in una prigione ancora più angusta e umiliante, osserviamo incuriositi il peluche in cui è intrappolata – senza possibilità di esprimersi – la sofferenza di una madre. Anche se restiamo raccapricciati dinnanzi all’ologramma senziente di un uomo sottoposto a un strazio che si ripete senza sosta, non riusciamo a distogliere gli occhi da quello strazio. Come un filo rosso che lega tutti gli episodi che lo precedono, “Black Museum” rivela il senso dell’esperienza che abbiamo vissuto attraverso “Black Mirror”: conoscerci e conoscere l’oscurità che giace al fondo della nostra coscienza e che potrebbe sovrastarci, facendoci perdere la nostra umanità. “Bandersnatch”, invece, ci sfida molto più sfacciatamente e ci obbliga a dover fare i conti con un’umanità che perdiamo quando accettiamo una proposta: la possibilità di spiare e controllare qualcun altro attraverso lo schermo di Netflix. E noi – quando accettiamo quell’offerta – crediamo essere esterni a “Black Mirror” e, in realtà, ci siamo dentro. Ogni scelta che prendiamo al posto di Stefan ci qualifica per quello che siamo. Potevamo rifiutarci di interferire in un vissuto che non ci appartiene ma non lo abbiamo fatto. Nel corso della visione – mentre controllavamo le azioni di un ragazzo ridotto a marionetta – non ci ha sfiorati l’idea che stessimo facendo qualcosa di sbagliato. Solo quando lo schermo si spegne, riusciamo a comprendere il messaggio dello specchio, il messaggio più grande e importante di “Black Mirror”: “Tu puoi perderti nell’oscurità dello specchio, ma puoi anche rischiararla: a te la scelta”
Link originale: http://www.lamacchinasognante.com/black-mirror-lo-specchio-che-riflette-lumanita-intera-e-su-cui-vale-la-pena-riflettere-paola-rizzo/