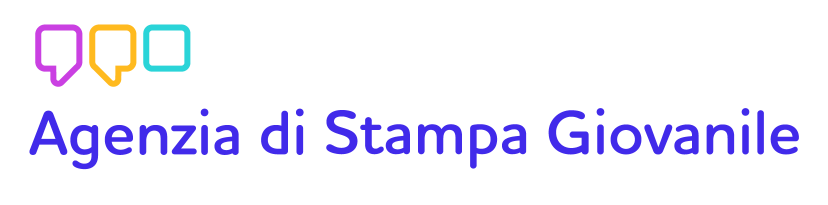La banalità del male in Terra Santa
In un momento così incerto, di frazionamento, di prospettive inevitabilmente ego centrate anche mentre chiediamo solidarietà, anche mentre ci ricordiamo di restare umani, la Palestina è qualcosa che abbiamo dimenticato, è un sassolino nella scarpa diventato troppo controversa per i salotti di dibattito, troppo poco di notizia per le prime pagine.
Di Giulia Fiamengo, articolista di Agenzia di Stampa Giovanile
_
L’impressione è che questo pandemico freeze abbia fatto emergere con più evidenza ciò che doveva essere chiaro già prima. Il dramma della povertà nell’era del virus acquista in dignità, diventa un problema di tutti perché un solo malato che non ha accesso alle cure è un potenziale pericolo per un’intera élite ricca, o per un’intera parte di mondo ricca. Il virus fa da lente di ingrandimento ai grandi temi del clima, dell’accesso sperequato alle risorse, dell’iniquità del sistema in cui viviamo.
Ma in qualche modo Gaza resta esclusa anche in questo, zona rossa dal 2007, i suoi abitanti non rappresentano un pericolo per l’esterno, il dramma al più si consuma dentro i confini del blocco. Anche quando la tragedia diventa violenta e le immagini di piccoli corpi ammassati e senza vita fanno il giro del mondo – o almeno fanno il giro delle reti indipendenti – la narrativa per la terra di Palestina si fa cauta, le parole sono neutrali. Ci districhiamo usando termini come scontri, conflitto, risposta ad attacchi, quando le parole da utilizzare sono ingerenza, pulizia etnica e aparthied.
Cerchiamo di fare la Svizzera condannando la guerra sempre, fingendo di non vedere l’asimmetria di potere per paura di offendere qualcuno. Ma Giustizia non è qualcosa che possiamo rispolverare solo quando ci fa comodo, solo quando i tempi sono maturi e i temi socialmente accettati, non possiamo inorridire davanti all’omicidio di Floyd, firmare la petizione per il ddl Zan e poi usare la retorica della responsabilità condivisa quando si tratta delle vite palestinesi. Perché i palestinesi non respirano dal 1948.

Mi sono svegliata con le notizie di una Gaza bombardata per un’intera notte e con una narrazione così cauta che finisce per falsare la realtà. E’ così che ho pensato a quello di cui mi stavo occupando prima del freeze, per guardarlo con questa nuova lente di ingrandimento, per uscire dal – necessario – eurocentrico monotema della fase numero boh dei vaccini. Prima mi stavo occupando di una storia che nasce a Gaza, dove oggi la preoccupazione per la potenziale bomba a orologeria dei contagi, che si è riuscita posporre, non è più prima nella lista perché oggi la domanda è chi resterà vivo a fine giornata per potersi ammalare di covid domani.
Prima della pandemia i maldestri tentativi di celare nuove annessioni sotto il nome dell’esportazione della pace in Medio Oriente, con la consueta pratica occidentale che cala dall’alto grandi concessioni aspettandosi ringraziamenti, lasciavano quanto mai perplessi. Dopo la sospensione dei finanziamenti all’UNRWA, il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, l’appoggio alle politiche espansive di Netanyahu, Trump si sedeva alla tavola rotonda di altri per sostenere la pace e 50 miliardi di aiuti in cambio del riconoscimento della sovranità di Israele sulla Valle del Giordano e del sostanziale isolamento di quel che resta della Palestina.
Oggi il grande disegno di pace vacilla nei reparti degli ospedali che non accettano gli arabi israeliani ma che mettono i medici arabi a lavorare comunque a pieno regime, vacilla mentre Netanyahu e le autorità di Hamas giocano a braccio di ferro con la vita dei rifugiati palestinesi per chi concede cosa in cambio di aiuti medici, per chi riesce a rimandare le elezioni più a lungo, per chi riesce a restare al potere abbastanza a lungo da sventare le accuse di corruzione.
Quello nella terra di Palestina è un conflitto protratto da 70 anni, da logoramento, anche se in campo non ci sono eserciti ma qualche dozzina di militari appostati ai check point o addirittura nelle colonie questa nuova formula della sicurezza privata, ovviamente armata e con licenza di uccidere. Questa nuova formula della sicurezza privata é ovviamente armata e con licenza di uccidere. È un conflitto appunto e questo ci esime dal ricordarci qualche punto della Convenzione di Ginevra perché non rientra nella definizione canonica di guerra, cioè tra due Stati e qui ne vediamo uno solo, nonché nell’idea stessa che abbiamo della guerra ossia quella tradizionale che si combatte sul campo, tra due eserciti.
In Palestina c’è l’esercito di uno Stato sovrano e poi c’è il flagello fantasma di Hamas che solletica la contro missilistica israeliana con qualche razzo. Ma il vero conflitto è quello di tutti i giorni tra i soldati armati e i civili che attraversano i check point ogni mattina e ogni sera, tra i cecchini e i disperati di Gaza che lanciano sassi al confine. Qui il Keynesismo di guerra comodo ad entrambe le parti, che da tempo ha superato le logiche di mercato per adattarsi bene alle logiche della politica di propaganda ha ben compreso che il disinvestimento sociale sventa il pericolo dell’affrancamento per gli uni e della democrazia per gli altri.
Chi paga il prezzo di queste logiche sono i nuovi soldati di oggi, quelli armati della sola disperazione. La storia di cui mi stavo occupando è la storia di Alaa Aldali, è quella di un soldato di Gaza armato della sua bici alla prima Marcia per il ritorno dell’ultimo venerdì di marzo 2018. E’ la storia di uno qualsiasi dei ragazzi nelle strade della West Bank o della Gerusalemme occupata di questi giorni. Non è storia nuova.
Da quel giorno nelle manifestazioni del venerdì si combatte a pietre contro proiettili. I ragazzi di Gaza scendono in massa verso il confine presidiato e con le bandiere palestinesi chiedono di poter tornare a casa. L’ordine è di restare a 300 metri dal reticolato o i cecchini israeliani ti sparano. E non importa se hai la maglietta con su scritto Press o sei un infermiere, se passi i trecento metri ti sparano alle gambe o alla schiena.
In un venerdì di marzo Alaa L.A. Aldali decide di scendere verso il confine. Alaa non è né un militante né un attivista, è un ciclista, ma questa volta ha un motivo per manifestare. Si è qualificato per i Giochi Asiatici ma non potrà gareggiare, non potrà portare la bandiera della sua terra. Gli hanno detto che non lo lasceranno uscire da Gaza.

Foto di Nicola Zolin
Alaa si allena tutti i giorni in un percorso improvvisato avanti e indietro a Gaza, che fa 40 km di lunghezza per 5, 12 nel suo massimo, con una bici di fortuna, perché a Gaza non entrano i macchinari medici figuriamoci le bici. Lo fa con la determinazione di un sogno, quello di correre in bici. E quando gli dicono che non avrà nessun visto di uscita gli impartiscono un’importante lezione: tutto è politica ed essere il miglior ciclista non basta se vivi in una prigione.
È un venerdì di marzo e Alaa prende la sua bici. Vestito da ciclista, in un corpo da bambinone cresciuto, scende con gli altri verso il confine in quello che è un atteso ma, inaspettatamente per Israele, pacifico venerdì di protesta.
Da allora ogni venerdì i feriti non mancano, ma si dice siano i più avventati che si avvicinano troppo per sfida lanciando pietre con tutta la forza della disperazione, della collera, sperando che arrivi al mondo, in un eco la loro richiesta di aiuto.
Ogni venerdì questi arditi finiscono nelle tende mediche attrezzate per il primo soccorso, in questi primi centri di stabilizzazione del trauma, installati direttamente sul confine per tentare di organizzare il flusso di feriti. Dopo la battaglia di Musul in Iraq le ritroviamo a Gaza. Viene da chiedersi se 360km quadrati di terra arida e inquinata valgano postazioni d’assedio, droni notte-giorno, armi di ultima generazione.
A 300 metri dal confine Alaa sta in piedi nella sua tuta da ciclista con la sua bici, sta a distanza perché non è un ardito, è un ciclista e quel giorno è lì perché ha capito che non importa chi sei se vivi a Gaza.
E infatti non importava che avesse la bici, la divisa da ciclista, che si tenesse a debita distanza e che non avesse pietre da lanciare, solo un sogno negato da rivendicare. Non importava perché veniva ferito lo stesso, una ferita che gli è costata la gamba e il sogno dei Giochi per sempre.
Era la tipica ferita da proiettile sul confine, con un piccolo foro d’entrata e un enorme foro d’uscita con danni gravi ai tessuti molli, ai muscoli e a tutto il sistema neurovascolare. Li chiamano proiettili farfalla, penetrano nei tessuti ad alta velocità polverizzando intere parti di arto.
Dopo il rifiuto di farlo uscire da Gaza per l’operazione e dopo giorni di tentativi per salvargli la gamba, nell’ospedale di Gaza sfornito di palliativi per il dolore e di strumentazioni adeguate, la scelta per Alaa è tra la morte e l’amputazione. Non è una scelta facile, le sue gambe sono la sua narrazione diversa, ciò che lo distingue dagli altri disgraziati di Gaza.

Foto di Nicola Zolin
Non è una scelta facile per i ragazzi dei venerdì di Gaza, quella tra la morte e una vita di emarginazione. Solo nel 2019 i feriti al confine sono stati 28000 su una popolazione di 1 milione e 800 mila persone circa. Secondo i report dell’OMS, 6500 sono i feriti gravi da arma da fuoco. Ci sono le basi perché si crei una generazione di disabili a Gaza. D’altronde quando si sparano proiettili che esplodono al contatto con l’osso le conseguenze sono preventivate e accettate.
I ragazzi amputati di Gaza sono i reietti della società, giudicati per la loro avventatezza, lasciati soli perché non più in grado di sostenere la famiglia. Vivono nel tabù della malattia mentale, nella mancanza di sostegno psicologico adeguato e sono le prime vittime della dipendenza da oppiacei.
L’immersione in una realtà di prigionia protratta ha trasformato l’utopia di libertà in distopia patologica. Di fronte al rischio del rifugio nel palliativo, come rimedio alla depressione diffusa, l’autorità di Hamas ha risposto con misure restrittive all’entrata di palliativi in Gaza. In questo modo si è cercato di ovviare al problema di una generazione di farmaco dipendenti ma manca una risposta ai bisogni clinici di altri pazienti, dei feriti d’arma da fuoco per esempio. Questi, gli emarginati appunto, finiscono suicidi o ai margini di una società in tracollo.
Alaa però è uno sportivo e poco dopo l’amputazione inizia la riabilitazione. In quello Il giro d’Italia passa per Israele e il campione di Palestina resta a guardare, ma “se non ha portato la bandiera di Palestina su due gambe, ora la porterà con una”, racconta Flavia Cappellini che ha girato il corto Tour de Gaza sulla storia di Alaa. “Tutti gli sport sono politici ma il ciclismo ha un elemento in più che è quello territoriale. Laddove il controllo militare non può arrivare, il ciclismo è utilizzato per normalizzare i paesi.”
Alaa è un antieroe risoluto, non è l’impavido, l’idealista. È un ragazzo di Gaza che vuole solo correre in bici, poteva essere uno tra i 56 morti nella notte del 12 maggio, e forse potrà infine uscire da quella prigione a cielo aperto e partecipare alle paralimpiadi, grazie alle pressioni della società civile, dei media, ma quale destino per gli altri disgraziati di Gaza? Quale futuro per Gaza? Una Nakba – catastrofe – mai cessata.
Gli ultimi eventi, che si sommano ad un anno di covid, rischiano di essere l’estrema unzione per una popolazione già stremata, che fatica a garantire alle famiglie due pasti al giorno, che anche in questa fase di emergenza resta soggetta ai blocchi sulle importazioni e cerca di autoprodurre i dispositivi di sicurezza come il sapone e le mascherine.
In un momento così incerto, di frazionamento, di prospettive inevitabilmente ego centrate anche mentre chiediamo solidarietà, anche mentre ci ricordiamo di restare umani, la Palestina è qualcosa che abbiamo dimenticato, è un sassolino nella scarpa diventato troppo controversa per i salotti di dibattito, troppo poco di notizia per le prime pagine.
Un ghetto e una prigione insieme, Gaza è sovraffollata, inquinata, disumanizzata, bombardata. È una città di martiri che non hanno avuto scelta, è un’oasi di illusione e tracollo. Per chi ci vive è un’oasi di prigionia, è l’ultimo baluardo di resistenza di uno Stato che non vedrà mai nascita, è la vana speranza. Per chi la guarda è l’omertà, è il paradosso, è il ricorso storico che non ha memoria. È la banalità del male, è l’economia della guerra.