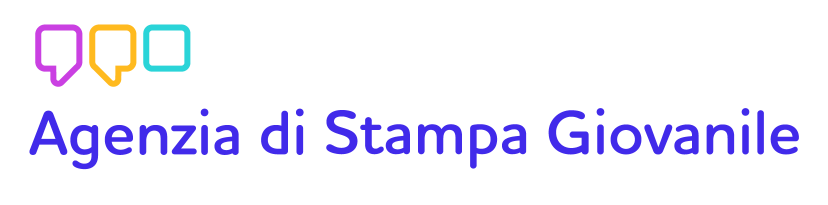Immersi nel Novecento: un dialogo sulla guerra in Ucraina
Dialogo attorno alla guerra in Ucraina fra Michele Nardelli e Francesco Prezzi: una sua ultima testimonianza sulle cose del mondo. Francesco ha vissuto questa ennesima tragedia dal letto di un ospedale e fino all’ultimo non ha mai smesso di ragionare sulla società, sul senso della Storia e sul valore del pensiero politico. Poi ha preso il volo.
di Michele Nardelli (articolo tratto dal blog michelenardelli.it)
–
Immersi nel Novecento. Questo siamo.
Lo sferragliare dei carri armati e il rumore sordo dei bombardamenti. I vecchi palazzoni sovietici sventrati e anneriti dal fuoco. Gli occhi impietriti di un’umanità costretta ad abbandonare le proprie case, a rifugiarsi negli spazi sotterranei delle metropolitane o ad ingrossare le fila del libro dell’esodo. I miliziani nazionalisti, sempre più protagonisti delle nuove guerre, padroni delle strade e delle macerie. A prescindere dalle loro bandiere e da come andrà a finire, saranno loro a vincere.
E ancora. L’aria e l’acqua avvelenate, il sudiciume di ogni guerra. Le palizzate di eternit prese a calci, come ad essere senza futuro. La paranoia dei signori della guerra, sempre uguale. L’ipocrisia dei potenti che non hanno mai smesso di produrre e vendere armi. Sullo sfondo il riecheggiare del moto latino “vis pacem, para bellum”, che ha armato il pianeta tanto da poterlo distruggere.
Infine l’incubo nucleare, che da quelle parti conoscono bene e con il quale – malgrado la tragedia di Chernobyl – hanno continuato a convivere, quello delle centrali mai dismesse e in questi giorni sfiorate dalle cannonate, e quello delle testate atomiche allertate in una follia che vorrebbe reclutarci e che militarizza anche il confronto politico.
Immersi nel Novecento. Lo è la Russia nelle mani di un gangster, figlio di uno dei più spietati apparati di potere che la storia abbia mai conosciuto, ossessionato e delirante. Che ancora pensa alla Grande Russia quando dovremmo guardare tutti – per usare l’immagine di Edgar Morin – alla Terra Patria. Lo è l’Alleanza Atlantica, che avrebbe dovuto sciogliersi già all’indomani della caduta del muro di Berlino e che invece ha continuato a fare proseliti a dispetto del progetto europeo. E di un sistema di difesa europeo che avrebbe finalmente rottamato gli eserciti nazionali. Lo è la popolazione ucraina aggredita, la cui unica vera forza avrebbe dovuto essere la resistenza nonviolenta, ovvero la capacità di proporre un diverso terreno di confronto di fronte ad uno degli eserciti più potenti del mondo. Quest’ultimo avrebbe anche potuto rivelarsi più fragile di fronte ad un popolo capace di guardare negli occhi i propri fratelli. Quella forza nonviolenta che evitò il bagno di sangue in quel tragico agosto 1968 e che avrebbe liberato Praga vent’anni dopo con la rivoluzione di velluto.
Immersi nel Novecento. Lo siamo noi europei, scettici verso l’unica strada – l’Europa politica – che avrebbe potuto generare uno scenario diverso. Più che consegnare armamenti nelle mani dei professionisti delle guerre moderne, possibili detonatori del “tanto peggio tanto meglio”. Immersi e reclutati, indifferenti al fatto che invasori e difensori siano armati fra gli altri da un’industria bellica come quella italiana, le cui azioni crescono di valore a dispetto del dolore che provocano, come abbiamo visto in questi giorni nel caso della “Leonardo”, fiore all’occhiello dell’export di questo paese e il cui presidente è un certo Marco Minniti.
Immersa nel Novecento è anche l’informazione embedded, da sempre al seguito degli eserciti per raccontare quel che si vuol trasmettere a degli ascoltatori senza memoria. Ma forse qualcuno si ricorderà dell’intervento dell’Occidente in Iraq in nome dello scontro di civiltà, dove quasi tutto era falso e costruito ad arte per non mettere in discussione il nostro stile di vita. Qualcuno di quei giornalisti ha fatto carriera ed è ancora lì, a raccontarci dell’Ucraina con lo stesso cinismo. La complessità non fa audience, meglio reclutarsi.
Disertare la guerra sarebbe la cosa più saggia, ma è anche la più difficile. Meglio agitare bandiere… Dovremmo essere “pronti alla morte” perché ci educhiamo alla cultura del limite, non per ridicoli patriottismi costati nella storia milioni di vite. Consapevoli, per dirla tutta, che la pace non nasce nel territorio della guerra.
Non lo nascondo. Il mio sentire oscilla fra l’indignazione e la depressione. E mi interrogo sul senso dell’agire umano, laddove la memoria appare così labile per cui non s’impara mai nulla dal passato, anche quello più prossimo. Dovremmo riflettere su come si sia arrivati sin qui e magari come cercare di uscirne, ma per farlo occorre cambiare il terreno di gioco, elaborare il passato (e il secolo degli assassini in particolare) e, a proposito di Dostoevskij, indagare la natura umana.
No, caro Michele. Non è il caso di lasciarsi prendere dalla depressione. Si devono mettere in circolo idee e persone che in questi anni non hanno rinunciato a sostenere le culture alte, nutrite di giustizia e libertà. Le forze ci sono. Sono solo disperse.
U krajna, sul confine
E’ sufficiente partire da qui, dall’etimologia delle parole, per cominciare a capire. La geografia spiega molte cose, consapevoli che si tratta di una materia viva, che i confini sono mutevoli e molteplici e che – nell’interdipendenza – sempre meno corrispondono a quelli statuali. Già oggi le “nuove geografie” ci raccontano di un tempo oltre i paradigmi novecenteschi, ma noi siamo immersi nel passato. Anche la conoscenza della storia ci aiuta oltremodo a comprendere il presente e la sua complessità. Non per cercare arcaiche identità ma per elaborare i conflitti e riflettere attorno alla condizione umana.
Ucraina significa letteralmente sul confine. Non si tratta del confine orientale dell’Europa, identificabile grosso modo nella linea che unisce i Monti Urali e il Mar Caspio e pertanto almeno duemila chilometri più a oriente di questo paese. Il confine che ha dato il nome all’Ucraina è interno all’Europa, riconducibile alla faglia irregolare che storicamente l’ha divisa fra l’influenza dell’oriente e dell’occidente. Quella faglia – ci ricorda Francesco – attraversa le terre dei Rus’, nome con il quale venivano identificati gli uomini che remano (di origine scandinava) insediatisi nell’Alto Medioevo nei territori oggi riconducibili alla Bielorussia, all’Ucraina e alla Russia europea (investendo seppure in misura minore anche la Slovacchia e la Polonia), già abitati da popolazioni slave. Valga per tutte la considerazione che fin dall’inizio del X secolo i trattati con i bizantini si concludevano a nome di “tutta la terra di Russia” e “tutti i Rus’”.
Conquiste e migrazioni, pogrom e incontri di civiltà, hanno fatto sì che i caratteri delle popolazioni europee producessero grandi ibridazioni. In particolare lungo questo limes, città ed intere regioni hanno assunto nel corso della storia bandiere e vessilli diversi. La Transilvania con Brasov (la vecchia Kronstadt), Sibiu (Hermanstadt) e Cluj Napoca (Klausenburg), la Galizia con Cracovia e Leopoli (L’vov, L’wiw o Lemberg), la Rutenia con Uzhorod (Ungstadt), la Bucovina con Suceava, che come noi facevano parte dell’Impero Asburgico fino al suo dissolvimento, hanno più volte cambiato bandiera grazie a trattati e conferenze internazionali che spostavano i confini in base ai rapporti di forza e alle convenienze dei potenti. In questo modo ogni forzatura identitaria è arbitraria e da attribuire prevalentemente alla volontà dei vincitori di fornire una loro narrazione in senso nazionalistico. Nazionalismi senza nazioni, verrebbe da dire.
Ad esempio, con la Conferenza di Yalta e la divisione in sfere di influenza, la zona di Leopoli abitata da cristiani cattolici e da ortodossi uniati, è stata assegnata all’Ucraina: una ridefinizione di confini entro uno Stato “nazionale” che poco corrispondeva a un sentire di tanta parte della popolazione di Leopoli che semmai pensava se stessa come appartenente alla Mitteleuropa asburgica. Un legame che riguarda da vicino la storia di sofferenza e dolore dei nostri nonni, spediti a morire su quel fronte durante la prima guerra mondiale e di cui sono memoria le canzoni di guerra come Sui monti Scarpazi.
Un’ibridazione che ritroveremo nelle arti e nella cultura. Un esempio per tutti è quello di Nikolaj Vasil’evi Gogol’, forse il più grande scrittore russo, di origine ucraina.
Con questo non si intende negare l’identità di nessuno. Ma solo dire che le identità sono sempre in divenire. Quando non lo sono è perché sono morte e producono disastri. E soprattutto che per uscire dall’ingorgo del Novecento è necessario cambiare i nostri riferimenti precedenti, gli strumenti interpretativi, i paradigmi.
Uscire dal Novecento
Fra guerre mondiali e deliri nazionalistici, fascismi e regimi dispotici, deterrenza e sfere di influenza, post comunismo e insane nostalgie, mafie e turbocapitalismi… l’onda lunga del Novecento ha continuato ad accompagnarci. E ad incombere sul presente.
A cominciare dalla seconda guerra mondiale. Quando nel 1942 l’operazione “Barbarossa” portò allo sfondamento dei territori di cui stiamo parlando, una parte della popolazione si schierò con il nazismo, come peraltro avvenne in buona parte dell’Europa occupata (ma chissà perché questo non si deve dire). La rimozione di queste responsabilità senza riappacificazione ha mantenuto una frattura fatta di tragedie famigliari e vecchi rancori. Non dimentichiamo che Stalingrado (oggi Volgograd) – la cui battaglia lasciò sul campo i cadaveri di oltre 700.000 persone, fermando così l’onda nera e rilanciando l’offensiva fino ad arrivare alla liberazione di Auschwitz – dista dal Donbass poco più di un’ora di automobile.
Come già nei Balcani negli anni ’90, soffiare sul fuoco di conflitti mai elaborati, rappresenta una tecnica ben sperimentata da parte dei poteri criminali che hanno come unico interesse quello dei propri affari. Ed è proprio questa l’altra faccia del Donbass, mafie spregiudicate che si colorano di bandiere nazionali e/o di identità religiose. Così, ancora una volta, le parti agitano il diritto dell’autodeterminazione o quello alla sovranità nazionale, principi sovraordinati di un diritto internazionale ormai obsoleto. E l’ingorgo è fatto.
Qui si pongono due temi sempre più cruciali nel guardare alle cose del mondo.
Il primo è quello dell’elaborazione dei conflitti. La consapevolezza che per uscire da una situazione più o meno acuta di conflitto è indispensabile venirne a capo, sviscerarne le cause, comprenderne il contesto, individuarne le responsabilità, cercare non dico una narrazione condivisa ma almeno dei significativi punti d’incontro. Non per ottenerne vendetta, ma per stabilire come sono andate le cose (una verità almeno accettata) e al tempo stesso riconoscere il dolore degli altri. Solo questo può portare alla riconciliazione e ad una pace durevole. Ma è quello che, tranne qualche rara eccezione come quella Sudafricana della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, non si fa. Perché oltre alla colpa criminale c’è anche la colpa politica e morale (che investe responsabilità diffuse) e perché si pensa che il tempo lenisca le ferite, quando invece le infetta. Sotto lo sguardo opaco della banalità del bene e degli eserciti della salvezza, come se la guerra fosse un incidente della storia. Anche il processo di costruzione dell’Europa politica nasce dalla necessità di ricomporre l’infranto, ma questa strada è ancora lastricata da troppi nazionalismi.
Il secondo tema è quello del cambiamento dei vecchi paradigmi. Se rimaniamo prigionieri dello schema precedente, ad esempio quello degli stati-nazione (sovranità vs autodeterminazione), le istanze dei contendenti rimarranno inconciliabili. Per uscirne è necessario indicare scenari diversi, come lo fu nel secondo dopoguerra l’accordo Degasperi – Gruber sulla questione sudtirolese introducendo il concetto di “ancoraggio internazionale” prima inesistente. Oppure la proposta che avanzammo come Osservatorio Balcani Caucaso nel 2006 nell’immaginare per il Kosovo uno status inedito, quello di “regione europea”. Solo per la cronaca, sul piano del diritto internazionale il Kosovo non esiste, la situazione è ancora irrisolta e foriera di nuovi conflitti.
La necessità di sparigliare diviene dunque un imperativo per mettere in discussione strade arrivate al capolinea. Ce lo chiede uno scenario radicalmente cambiato nella dislocazione dei poteri (che cosa sono la post-modernità e la post-politica?). Ce lo chiede con urgenza quel che sta accadendo in Ucraina. Ce lo chiede un secolo che fatica a mettere le ali.
Post-modernità
Contrariamente alle apparenze, Vladimir Putin è a suo modo un interprete della post-modernità. La Russia post comunista è stata un laboratorio tutt’altro che banale nel rappresentare certamente la nostalgia del passato imperiale (la potremmo definire, riprendendo il titolo di un libro straordinario di Samir Kassir, l’infelicità russa) o nell’accattivarsi i vertici della Chiesa ortodossa che – in quanto autocefala – lega in maniera perversa potere temporale e spirituale, ma soprattutto nel costruire un nuovo blocco di interessi (e di potere) militar-industriali, nel dar vita ad uno stato paternalistico-mafioso con il sostegno delle oligarchie arricchitesi con le privatizzazioni, e infine nel dar corpo ad un assetto di potere di natura neo-zarista, plebiscitario e populista, nel quale le istituzioni democratiche sono orpelli del passato.
Approfittando delle scie nazionalistiche, ereditate da un Novecento lungo la faglia u-krajna ancor meno elaborato che altrove e dell’improvvido espansionismo della NATO nei paesi del vecchio Patto di Varsavia, Putin ha creduto di ridestare i sogni imperiali della Grande Russia. Lo ha fatto in questi anni coltivando ambiti di influenza nella regione. Ha ragione Francesco.
Pensiamo al rapporto con il dittatore bielorusso Lukašnka, al sostegno verso la Serbia del leader nazionalista Aleksandar Vuić; all’offensiva secessionista della Republika Srpska di Milorad Dodik in Bosnia Erzegovina (che può portare di nuovo i Balcani nel caos); pensiamo alla Transnistria in Moldavia, dal 1992 sotto il controllo di ciò che rimane della XIV armata “sovietica”; pensiamo alle autoproclamate repubbliche di Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Pensiamo al sostegno delle mafie e delle loro milizie mercenarie per assicurarsi il controllo della Cecenia o delle sue relazioni criminali con la mafia serba e montenegrina. Oppure ancora facendo leva sulle materie prime (gas in primo luogo), riconquistando un ruolo niente affatto trascurabile sui corridoi internazionali e sul mercato globale. Lo ha fatto (o ha creduto di farlo) anche con il Donbass, prima sostenendo una guerra “a bassa intensità” che ha comunque lasciato sul campo 14 mila morti, poi con il colpo di mano militare sulla Crimea, annessa alla Federazione Russa nel 2014, infine mettendosi in proprio con il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e con la missione di “peacekeeping” che ha dato il via all’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio scorso.
Si dice che ora la guerra è di nuovo in Europa. Veramente c’è da trent’anni e non l’abbiamo saputa o voluta vedere. Cos’è stata “la guerra dei dieci anni” che devastò quella che un tempo era la Jugoslavia e della quale si è compreso poco o nulla?
Allo stesso modo non abbiamo voluto sapere di un paese offshore come la Transnistria, sorto armi alla mano nel momento dell’indipendenza della Moldavia (1992) ad est del fiume Nistru come protettorato “sovietico” e per tutto questo tempo cuore di traffici criminali. Cosa sono state le guerre divampate fra il Mar Nero e il Mar Caspio sui diversi fronti del Caucaso settentrionale e meridionale? Nomi come Cecenia, Daghestan, Ingucezia, Abkhazia, Ossezia del Sud, Nagorno – Karabakh, Agiaria sono entrati nelle cronache e rapidamente rimossi, guerre latenti ma archiviate nell’immaginazione dell’Europa come trascurabili. Ed ora l’Ucraina.
Vie d’uscita
Una riflessione sulla Storia ci avrebbe aiutati a comprendere quel che stava accadendo, anche se probabilmente questo non avrebbe inciso sulla scelta della Russia di invadere l’Ucraina. Forse avremmo potuto evitare che un’alleanza militare ormai priva di senso come la NATO iniziasse quel proselitismo che, con la fine della guerra fredda, l’allora presidente Michail Gorbaciov aveva cercato di scongiurare.
E’ andata così. Occorre essere vicini al dolore di chi sta soffrendo, nelle forme dell’accoglienza, degli aiuti umanitari, della cooperazione. E della riflessione.
Ora l’Europa trema. Non solo per l’onda dei profughi, questa volta bianchi e cristiani, che è già arrivata e che – se le armi non si fermano – è destinata a diventare uno tsunami. La tragedia di Chernobyl del 1986 ci ha già fatto comprendere cosa significa interdipendenza. In più, questa volta, ci mettiamo anche del nostro, in nome di un atlantismo che, dopo la caduta del muro di Berlino, ha fatto solo disastri, dall’Afghanistan, all’Iraq, alla Libia. Non possiamo stare a guardare, si dice. Ma un intervento maldestro può causare conseguenze ancora peggiori.
Che fare, allora? Non è facile intervenire quando la situazione è degenerata. Di certo, dobbiamo interrogarci, per capire e per venirne a capo.
E’ necessario in primo luogo fermare l’escalation dei combattimenti. Il dialogo diplomatico sembra appeso a un filo, ma è necessario crederci e trovare soluzioni che possano permettere alle parti di uscirne non annichilite. Specie se fra le parti c’è un dottor Stranamore che può far saltare tutto o, più semplicemente, c’è un semplice miliziano psicopatico che con un missile può trovarsi a dire “muoia Sansone e tutti i filistei”.
Per far tacere le armi può essere conveniente alzare le mani unilateralmente. Sento già qualcuno indignarsi dicendo che in questa maniera avremmo regalato l’Europa al nazismo. Si dimentica che in quel tempo il nucleare era ancora in nuce e che l’uso su Hiroshima e Nagasaki (di cui l’Occidente non può andare fiero) non innescò una reazione di analoga portata. Se fosse stato così, non saremo qui a parlarne. Oggi la situazione è completamente diversa.
Questo significa accettare il sopruso? Niente affatto. Significa che per rompere la spirale di una guerra che può diventare nucleare, occorre avere il coraggio di disinnescare la portata del conflitto. La forza della nonviolenza, che fatica a trovare cittadinanza politica, abita qui. E la chiave per una soluzione politica (qual è se non questo il senso della politica?) si chiama ancora una volta Europa. Quella di immaginare uno status inedito e vantaggioso per l’Ucraina e una rassicurazione, per la Russia e per tutti, rispetto alla non belligeranza, a partire dalla dislocazione degli arsenali nucleari e magari dalla loro progressiva distruzione.
Quella armata non è una soluzione, è il problema. Questo non significa non intraprendere atti anche molto forti sul piano delle relazioni economiche. Ma le strade sin qui intraprese non sembrano efficaci. Gli embarghi sono aggirabili, specie quando hai mezzo mondo che non le applica. Occorre piuttosto riaprire dialoghi irresponsabilmente interrotti. Uno per tutti quello con l’Iran, un paese strategico con il quale l’Unione Europea aveva saputo realizzare un accordo per la non proliferazione nucleare che da solo potrebbe rappresentare – oltre alla fine dell’embargo verso questo paese – un’alternativa alle fonti energetiche in mano a Putin e ai suoi oligarchi. Quell’accordo venne fatto saltare dagli Stati Uniti di Trump e da Israele, allo scopo di indebolire non solo il regime iraniano ma anche l’Europa politica. Francesco insisteva spesso su questo, parlando al telefono: «l’Iran – diceva – è la vera risposta a Putin».
Un’ultima considerazione
In questi due anni abbiamo acquisito un nuovo concetto che non c’è nei vocabolari. E’ quello di sindemia. Ovvero l’intreccio delle crisi sanitaria, climatica, ambientale, demografica, migratoria, alimentare, economica, finanziaria e … militare. Se vogliamo, anche istituzionale, politica e morale. “Un’enorme policrisi” l’ha descritta Edgar Morin. Per affrontare la sindemia occorre un approccio sistemico, la cultura della complessità. «Un imperativo di sopravvivenza», perché tutto è connesso, tutto è in relazione.
Ma in queste ore sembra invece prevalere il paradigma della semplificazione, come se la pandemia fosse alle nostre spalle (quando sappiamo che non è affatto così) e come se la crisi climatica fosse uno sfizio dei ricchi e delle anime belle. E così tutto il resto, mentre ci si arruola all’Occidente, uno fra i punti cardinali che la Terra-Patria ha spazzato via.
Per fermare questa guerra, occorre uscire dal Novecento.