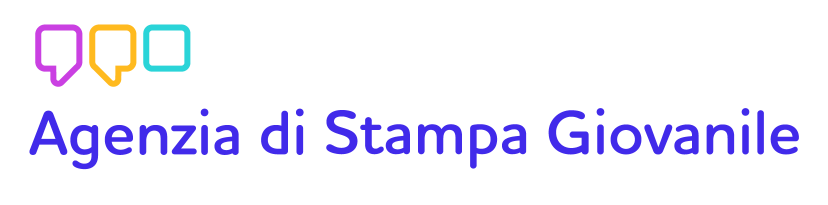Il giornalismo di Sara Lucaroni: un sogno, una missione, un atto di bene
“Dai viaggi che ho fatto ho imparato questo: non avere paura dell’altro. Perché io sono l’altro.” Sara Lucaroni ci parla del suo lavoro di giornalista, del suo amore per i diritti e del suo impegno a raccontare ciò che pochi prendono in considerazione.
Di Angela Nardelli, articolista dell’Agenzia di Stampa Giovanile
_

Giornalista freelance, laureata in Filosofia morale a Firenze, Sara Lucaroni ha firmato inchieste e reportage per Avvenire, L’Espresso, Speciale TG1 e SkyTG24. Nel 2018 la sua inchiesta sul traffico di organi che vede come vittime i profughi – pubblicata su L’Espresso – ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Mediterraneo e diritti negati” del Festival Giornalisti del Mediterraneo. Basandosi su questo lavoro pluripremiato si sta attualmente occupando della stesura di un libro. Esperta di medio-oriente – in particolare Siria e Iraq – e di immigrazione, si sta battendo per raccontare ciò che accade a popolazioni spesso dimenticate dai media occidentali, come la minoranza yazida, vittima di un genocidio da parte dello Stato Islamico.
Abbiamo voluto intervistarla, curiosi del suo coraggio e della sua dedizione verso una professione che in Italia spesso viene attaccata e delegittimata.
Com’è nata la tua passione per il giornalismo?
Fin da piccola ho sempre sognato di fare il giornalista o il magistrato, cose che alla fine si sono intrecciate. A vent’anni ho cominciato a scrivere in piccoli giornali locali, mi sono iscritta all’Ordine e ho preso il tesserino prima di concludere gli studi in Filosofia. Ho poi collaborato anche con un telegiornale per servizi televisivi. Sono quindi nata dalla tv e dalla stampa locali. Questa è stata una grande palestra. Iniziare così infatti insegna tanto: se riesci a muoverti nel giornalismo locale sei in grado di realizzare anche inchieste internazionali. Il consiglio che do agli studenti che vogliono diventare giornalisti è quello di iniziare a scrivere il più possibile, senza pensare di fare subito lo scoop o la grande inchiesta.
Qual è il reportage che più ti è rimasto nel cuore?
Quello in Iraq, a Sinjar nel 2015. Erano anni in cui iniziava a farsi strada il fenomeno dell’Isis, fuori controllo e di cui nessuno coglieva ancora la portata. Il reportage che ho prodotto nasce in modo curioso: a ottobre 2014 ho ricevuto una telefonata da un numero straniero. Parlava un ragazzo che si trovava in quel momento su una montanga a Sinjar, al confine tra Iraq e Siria. Si esprimeva in un italiano misto a inglese e tirava un forte vento. Sono riuscita a capire che il numero gli era stato dato da un contatto dell’Ambasciata irachena a Roma. Questo ragazzo chiedeva aiuto: l’Isis stava attaccando e sulla montagna di Sinjar si erano rifugiati uomini, donne e bambini, scappati ad agosto 2014. Era ottobre, il freddo li tormentava e gli aiuti lanciati da aerei spesso cadevano verso la Siria, sul lato dell’Isis. Da lì grazie ad Avvenire ho avviato una corrispondenza su quello che stava succedendo. Questa fonte diretta ci raccontava gli attacchi, i bombardamenti, la crisi. Era un combattente, uno sceicco di una famiglia di yazidi – minoranza curda – storicamente insediati in quel territorio, attaccati dall’Isis perché considerati eretici, “adoratori del diavolo”. Appena ci sono state le condizioni di sicurezza, sono riuscita a partire e sono rimasta venti giorni in quella zona. È stata un’esperienza incredibile che ancora porto addosso. Da quel momento ogni anno sono tornata per continuare a raccontare quello che è un genocidio ancora in corso. L’Isis, nonostante non sia più presente territorialmente, esiste ed è attivo.
Che rapporto hai con la paura?
Per me la paura è avere paura. Quando sono in Iraq o in Siria, ma anche quando devo fare un’intervista o spostarmi in Italia, cerco di dare il massimo e alla paura penso dopo. Quando sono tornata dalla Siria nel 2018, ho realizzato solo sul volo di ritorno la grande paura che avevo avuto. Solo in quel momento si è sciolta la tensione, quando ormai avevo alle spalle ciò che avevo passato.
Perché secondo te il giornalismo italiano dà poco spazio alle minoranze?
In Italia le pagine di esteri non sono in testa ai quotidiani o nella home page delle testate online, a meno che non ci sia un fatto di cronaca. La nostra stampa è abbastanza provinciale. I social poi hanno drogato maggiormente il meccanismo della preferenza al pezzo frammentato: le persone vogliono leggere notizie brevi e si informano spesso sui social. L’approfondimento non paga e si preferisce la brevità e l’immediatezza. Purtroppo in queste pieghe trovano spazio anche il tema degli esteri e i destini di tante minoranze. Ad esempio, riportando la mia esperienza con la minoranza yazida, posso dire che in Italia non ne parla nessuno, a pochi interessa. C’è anche un altro problema: le grandi inchieste non vengono tradotte in inglese, quindi anche in questo senso la stampa del nostro paese si può dire provinciale. Al giornalismo italiano manca la dimensione internazionale e ciò incide sul non avere interesse per una minoranza e per un popolo.
Spesso si sente dire che il giornalismo è morto. Cosa ne pensi tu e che consiglio ti senti di dare ai giovani che vogliono intraprendere questa strada?
Il giornalismo non è morto. Anzi, c’è bisogno di giornalismo fatto bene. Questo mestiere è studio, entrare nelle cose con i propri occhi e con il proprio punto di vista, che deve essere il più pulito possibile. Il giornalismo è una lotta continua al cinismo. È una dimostrazione di empatia. Mai come oggi il lavoro del giornalista è fondamentale, perché è quello che serve per sviluppare un senso critico. Le persone sono intelligenti e vogliono sapere, hanno bisogno di conoscenza. Per questo bisogna dare al lettore tutti gli strumenti critici per interpretare un fatto. L’importante è che si abbia questa forza, specialmente in un momento in cui imperano le fake news e i tentativi di manipolazione da parte della politica. È fondamentale che ci siano dei punti di riferimento in un’epoca come la nostra. Il giornalista, forte della sua deontologia, è un albero le cui radici tengono insieme una frana.
Che ricchezza hai acquisito grazie al tuo lavoro?
Spesso si ha paura di aprirsi, di far entrare nel proprio mondo qualcos’altro. Il giornalista che viaggia, scrive e intervista, deve essere aperto e non aver paura. Si arriva spesso in un posto nuovo con una serie di pregiudizi, convinzioni, certezze. È importante metterle da parte. Dai viaggi che ho fatto ho imparato questo: non avere paura dell’altro. Perché io sono l’altro. Con l’esperienza ho imparato che è la chiave fondamentale per i racconti e per coinvolgere i miei lettori. Il mio obiettivo è quello di farli sentire vicino a me e con me. Mi accorgo di arrivare al mio scopo quando lettori sconosciuti mi dicono: “grazie, perché eravamo lì con te”.