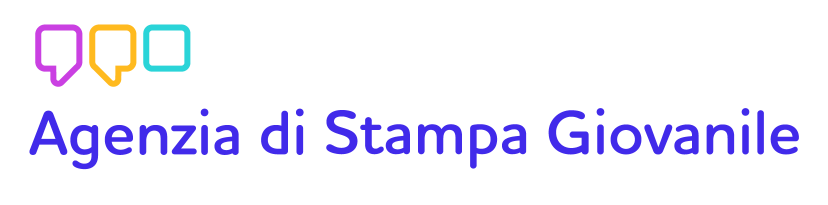Perché il caso Floyd è solo la punta dell’iceberg
Come il razzismo sistemico negli USA compromette non solo il diritto alla vita, ma anche la distribuzione delle risorse.
Di Valeria Balestra, articolista dell’Agenzia di Stampa Giovanile
_
Quando assistiamo al brutale omicidio di George Floyd e lo sentiamo più volte dire “I can’t breath” sotto al ginocchio di un agente di polizia, la reazione emotiva non concede spazio al dubbio, è immediata, è umana. Quando ci si pone la stessa domanda che il fratello Philonise ha posto al Congresso, “Quanto vale la vita di un uomo nero? 20 dollari?”, si comincia ad intuire che l’omicidio di Floyd forse rappresenta soltanto la causa tremendamente evidente di una discriminazione molto più radicata nella società americana. Ovvero l’affilata punta di un iceberg che, sciogliendosi, rischia di travolgere la compattezza apparente del tessuto sociale americano. Sommersa, nel ventre di questo colosso di ghiaccio la cui punta risente dell’azione degli animi riscaldati dei manifestanti uniti nel Blacklivesmatter, si trova proprio inglobata, quasi congelata da anni, la giustizia ambientale.

La questione della giustizia ambientale fu per la prima volta portata alla luce nel 1979, quando Robert Bullard condusse una ricerca in occasione della causa civile presentata dalla moglie Linda McKeever Bullard contro lo Stato per la costruzione di una discarica a Houston, in Texas (la causa si chiamava “Bean v. Southwestern Waste Management, Inc.”). La reazione emotiva ai risultati del lavoro di Bullard, di nuovo, è immediata: dal 1930 al 1978, infatti l’83% dei rifiuti prodotti a Houston veniva scaricato nei quartieri neri.
Diveniva così evidente come anche la questione della salvaguardia ambientale non si risolvesse solo nella richiesta di una maggiore tutela dell’ambiente, ma di una tutela dell’ambiente maggiore e uguale per tutti. L’altra evidenza che emerse dallo studio, forse più sconcertante, fu che proprio lo Stato, nella distribuzione di risorse come nel collocamento di industrie tossiche, si rendeva complice della discriminazione razziale. Nel 1979 la causa venne persa, ma oggi, nel 2020, si potrebbe forse pensare di averla vinta, pur senza un tribunale?
Nel 2019, uno studio svolto dal Natural Resources Defense Council in collaborazione con l’Environmental Protection Agency ha dimostrato che esiste una correlazione tra la violazione del Safe Drinking Water Act, che prevede un equo accesso all’acqua potabile negli USA, e la composizione etnica delle comunità. Nel 2013, invece, una ricerca pubblicata sull’Environmental Health Perspectives dimostrò che gli afroamericani avevano il 52% di probabilità in più rispetto agli ispanoamericani e agli americani di vivere in un’isola di calore, risultando più soggetti al rischio di un’ondata di caldo.
Per riprendere la domanda (che ho posto prima di esporre i risultati dei due studi, se si è vinta la causa senza tribunale), i dati sembrano suggerire che in questi ultimi quarant’anni, il razzismo sistemico, rappresentato metaforicamente dall’iceberg, sia ancora il triste vincitore, in maniera più o meno velata, nella società americana. Esso arriva a compromettere sia un equo accesso alle risorse, sia un equo e naturale diritto alla vita. Che siano i cambiamenti climatici in atto o le buone ragioni dei manifestanti uniti in tutto il mondo ad abbatterlo, si può solo sperare che non si sciolga solo la punta di questo colosso di ghiaccio, lasciando la questione della giustizia ambientale, ancora una volta, sommersa.