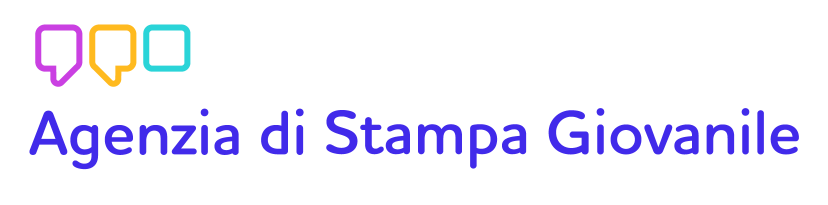L’inverno liquido di Michele Nardelli
L’impatto della crisi climatica sulle terre alte è al centro di “Inverno Liquido”, il libro di Michele Nardelli e Maurizio Dematteis che verrà presentato in anteprima martedì 13 dicembre presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Abbiamo intervistato Nardelli per farci raccontare qualcosa in più sull’opera e sulle tematiche trattate.
Di Ilaria Bionda
–
Un reportage realizzato lungo tutto l’arco alpino e la dorsale appenninica, con l’obiettivo di raccontare l’impatto della crisi climatica sulle terre alte e sui fragili ecosistemi che le compongono, soprattutto laddove l’industria dello sci è preponderante. Questo è Inverno Liquido – La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa, il libro di Michele Nardelli e Maurizio Dematteis (casa editrice Derive&Approdi) che uscirà nelle librerie a gennaio 2023 e verrà presentato in anteprima in alcune tappe prima del termine del 2022, tra cui quella di martedì 13 dicembre alle ore 17.30 presso il MUSE – Museo delle scienze di Trento. Abbiamo avuto l’occasione di porre qualche domanda a Michele Nardelli, uno dei due autori del libro.
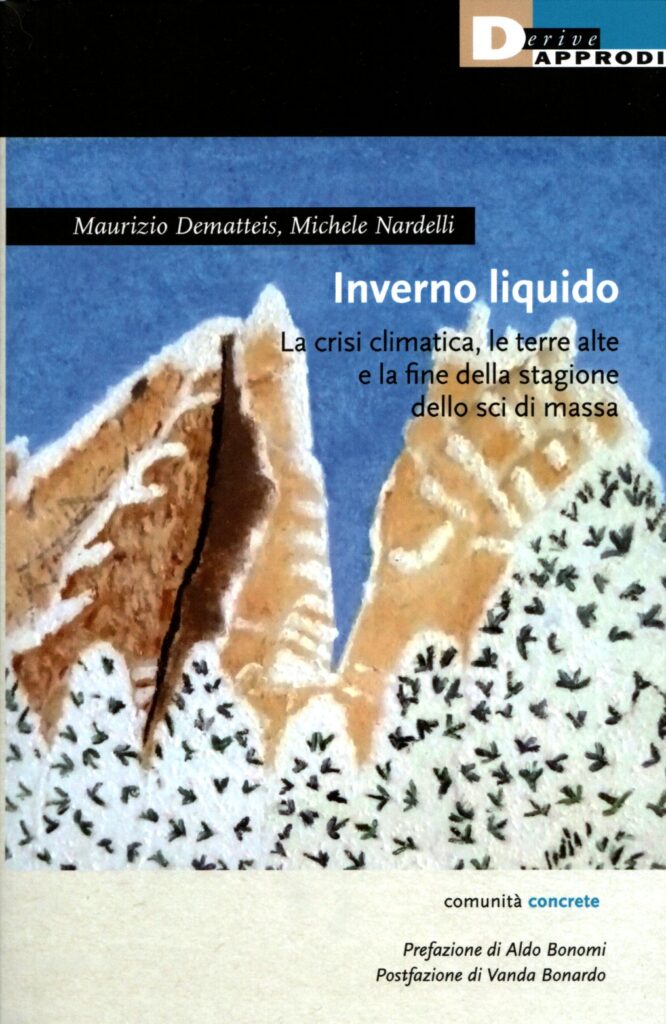
Michele, ci può raccontare qualcosa sulla genesi del libro?
Si tratta di un libro a più mani nato da un lavoro già iniziato da Maurizio Dematteis, incentrato sulle Alpi Occidentali, e poi ampliato per comprendere tutto l’arco alpino e la dorsale appenninica. L’obiettivo è stato quello di fornire una fotografia di quanto le comunità e le amministrazioni locali si stiano interrogando sugli effetti che avrà la crisi climatica in zone montane che, finora, hanno basato la propria economia sull’industria dello sci. Abbiamo dunque compiuto questo viaggio attraverso le terre alte, cercando di ragionare sia sugli elementi evidenti di criticità, sia sulle esperienze che stanno cominciando a delineare un’alternativa al vecchio modello di sviluppo, fondato sullo sci di massa. Siamo andati a cercare zona per zona gli elementi che rafforzano l’idea di una stagione finita (quella dello sci di massa, ndr), ma anche i tentativi che si stanno realizzando per immaginare uno scenario diverso. Per fare questo lavoro di inchiesta in tutte le regioni italiane ci siamo avvalsi di relazioni costruite nel tempo e, in questo modo, è nata di fatto una sorta di comunità di persone che ragionavano su quest’ordine di problemi. Per questo motivo, si è sviluppata l’ispirazione di dar vita non solo a un libro, ma a una collana che affrontasse sistemicamente il tema dell’impatto della crisi climatica sulle terre alte e sulle aree interne; con la proposta alla casa editrice è nata quindi l’idea di un collettivo di narrazione, con lo scopo di mettere al lavoro una comunità di pensiero su questi temi interessanti e urgenti.
Da cosa deriva il titolo “Inverno liquido”?
Veniamo dall’anno in cui le temperature registrate sono le più alte da quando si hanno i dati, l’anno della tragedia della Marmolada, l’anno in cui la fusione dei nostri ghiacciai è stata più forte: in questo senso gli inverni che ci aspettano saranno sempre più liquidi. Dentro alla liquidità intesa nel titolo, inoltre, si può ritrovare un’opportunità, quella di immaginare scenari diversi per il futuro. Tali scenari possono essere inquietanti se affrontati con l’approccio avuto finora, ma possono, al contrario, diventare un modo diverso di approcciare la montagna, se la consideriamo non solo un divertimentificio, ma come un luogo con cui entrare in relazione.
Il reportage è incentrato sia sulle Alpi, sia sugli Appennini, ecosistemi diversi ma uniti da un destino comune. Quali sono le principali similitudini e differenze tra le due catene montuose, anche in termini di impatto della crisi climatica?
Il modello che gli Appennini hanno conosciuto dal secondo dopoguerra in poi è sostanzialmente analogo a quello delle Alpi. Si tratta di un modello di sviluppo che in qualche modo tendeva a replicare quello di Sestriere e delle altre grandi stazioni sciistiche del nord Italia, così si sono costruiti dei mostri che purtroppo non si possono nemmeno abbattere. Per quanto riguarda l’arco appenninico, ciò che registra in maggiore misura rispetto alle Alpi è il fenomeno dell’abbandono della montagna. In più, con le opportunità offerte dal recente PNRR si sono tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che erano stati messi da parte per la loro insostenibilità, come il rilancio di impianti di risalita e l’innevamento artificiale, che con l’innalzamento della quota neve si dimostreranno oltremodo insostenibili. Gli Appennini sono comunque degli ecosistemi molto interessanti. Per fare un esempio, la nostra inchiesta si è conclusa in Sicilia, sull’Etna e nelle Madonie. Le tipiche granite siciliane venivano lì realizzate tramite le neviere, luoghi in cui sui monti si conservava la neve proprio per motivi agroalimentari e dolciari. Questo solo per dire quanto è importante riscoprire il valore delle terre alte e delle aree interne, che rappresentano un patrimonio di biodiversità – anche per l’effetto dell’incontro tra il clima continentale e quello mediterraneo – da salvaguardare e riprendere.
Sport invernali e turismo sono attività centrali nelle nostre montagne. C’è un modo di fare un passo indietro e renderle sostenibili o abbiamo raggiunto il punto di non ritorno?
Dobbiamo cambiare rapidamente. Dove è arrivata l’industria sciistica, tendenzialmente si sono annullate le altre forme di economia del territorio. Tutto ruota intorno allo sci e questo ha portato alla creazione della “monocoltura del turismo” che non va bene. È necessario ricostruire un equilibrio tra le attività, immaginando che la montagna non è solo sci e mesi invernali, ma è un luogo che va valorizzato dodici mesi l’anno, che va considerato per le popolazioni che vi abitano e che ne hanno forgiato, nel corso dei secoli, le caratteristiche, con attività di tipo economico e relazionale. Se ogni luogo diventa uguale a sé stesso tendenzialmente si banalizza e la banalizzazione a lungo andare non porta benefici, né alla comunità né a chi viene ospite sul territorio. In più di un capitolo del libro abbiamo parlato di turismo relazionale, ossia un turismo che si fonda sull’entrare in contatto con le persone, mettendo in atto un approccio diverso che significa valorizzare il cibo, i mestieri, la storia e le culture di ogni territorio, riconsiderando il valore dell’unicità delle proposte avanzate. Questa non è solo dimensione di nicchia, è qualcosa in più che riqualifica territori: se una persona va in un posto e trova le stesse offerte di altrove, non vi torna più. Io credo che le nostre montagne abbiano molto altro da dire e non siano solo dei divertimentifici.
A questi concetti si aggiungono poi gli effetti della crisi climatica. In primis, l’innalzamento della quota neve porterà le piste oggi sostenibili (di cui comunque già il 90% ricorre all’innevamento artificiale) a non esserlo più; poi c’è la questione dell’acqua come bene sempre più prezioso e raro, poiché i ghiacciai sono generatori di equilibrio – grazie alla funzione essenziale di rifornimento di acqua durante tutto il corso dell’anno – e stanno scomparendo; infine, la crisi energetica che innalza i costi. In sintesi, dobbiamo arrivare a una riconsiderazione di fondo del nostro rapporto con l’industria dello sci, con l’industria turistica, con la montagna.

In questo settore, come possiamo adattarci alla crisi climatica?
Dobbiamo sì avere capacità di resilienza per l’adattamento ma, soprattutto, dobbiamo comprendere la necessità di cambiamento: non possiamo semplicemente stare a guardare e adattarci alla situazione, poiché essa non è causata dal fato, ma determinata dalla nostra insostenibilità. Se non mettiamo mano a questo modello di sviluppo, non ne verremo a capo. Allora il tema diventa davvero di fondo, richiede non solo di adattarci, ma di cambiare. Al cambiamento, attualmente, ci sono molte resistenze, poiché ci troviamo di fronte a un modello che ha finora funzionato. Il Pianeta, però, consuma 1,7 volte quello che gli ecosistemi sono in grado di produrre ogni anno e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, a dare un contributo affinché questa situazione rientri nella sostenibilità e ciò significa ridurre progressivamente l’impronta ecologica.
Le resistenze al cambiamento derivano da una mancanza di strumenti o si tratta di un problema legato alla mentalità?
Si tratta di un insieme di elementi, soprattutto di tipo culturale: dobbiamo tornare a far nostra la cultura del limite perché ci siamo abituati a non averla più. Tutto va sotto il cliché del no limits ma dovremmo invece riprendere questo concetto fondamentale, perché ha a che fare con la nostra natura, è scritto nelle nostre esistenze. Se a questo aggiungiamo il fatto che noi consumiamo più di quanto gli ecosistemi sono in grado di produrre, significa che consumiamo risorse che dovremmo garantire al prossimo. Se vogliamo essere responsabili dobbiamo rientrare nella sostenibilità. Parola, quest’ultima, che ha quasi smarrito il suo significato ma che ha a che fare con il riuscire a consegnare alle generazioni future il Pianeta almeno come lo abbiamo trovato. L’obiettivo è lavorare per una distribuzione egualitaria delle risorse, ma anche attorno alla considerazione che se continuiamo a questo passo metteremo in discussione le condizioni che hanno reso possibile la vita sulla Terra: questo significa fare propria la cultura del limite, parola che ancora non ha cittadinanza pubblica.