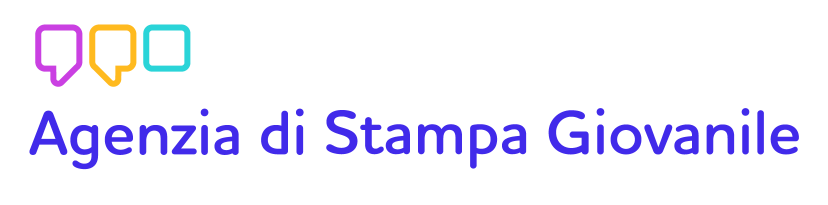Il futuro della moda: è possibile una transizione sostenibile?
Partendo dall’analisi dello studio “Just Fashion Transition 2023”, l’articolo sviluppa una breve riflessione sui costi umani e ambientali che la pratica del fast fashion comporta. L’obiettivo primario è la sensibilizzazione di aziende e, soprattutto, consumatori nelle scelte apportate in tal ambito, sperando che queste diventino sempre più improntate alla preservazione ambientale.
di Gloria Malerba
Mentor: Ilaria Bionda
–
Lo scorso ottobre, in occasione del Venice Sustainable Fashion Forum, è stato presentato lo studio “Just Fashion Transition 2023”, promosso da Carlo Cici, responsabile dell’Area Sustainability di The European House of Ambrosetti, uno dei primi studi di consulenza aziendale fondati in Italia.
Prendendo come riferimento 2800 aziende italiane ed europee nel campo della moda e del tessile, lo studio si pone l’obiettivo di analizzare le sfide presenti nell’ambito della transizione sostenibile nel settore della moda e, pertanto, di proporre dei cambiamenti volti ad accelerare il processo.
Problemi
Sono varie le problematiche messe in evidenza. In primo luogo, vi sono dei dubbi sull’efficacia della pressione normativa esercitata dall’Unione Europea.
Se da un lato, l’impegno dell’Unione si può chiaramente riscontrare nello sviluppo dell’ “EU Textile Strategy”, un’iniziativa promossa nel 2022 proprio per regolamentare la transizione. D’altra parte, il processo presenta forti ritardi, dovuti soprattutto alle posizioni discordanti assunte durante gli incontri e all’influenza esercitata dai vari gruppi di interesse.
Oltre ai problemi in ambito legislativo, vi sono delle difficoltà anche a livello tecnico. Ad esempio, il costo di produzione di un capo sostenibile ammonta al doppio rispetto ad uno tradizionale ed esso può essere rivenduto ad un prezzo fino a quattro volte superiore al costo di produzione iniziale.
Inoltre, spesso, le fibre naturali tendono ad essere percepite come più rispettose dell’ambiente, eppure, in alcuni casi, possono avere un impatto ambientale maggiore rispetto alle fibre sintetiche o artificiali.
A ciò bisogna aggiungere l’atteggiamento dei consumatori, superficiale e orientato maggiormente a scelte poco sostenibili.
Opportunità
Lo studio, però, illustra anche le opportunità presenti. Riciclo e riuso sono le parole chiave del futuro.
L’industria europea del riciclo di materiali tessili è in grado di gestire il 32% di rifiuti generati in questo ambito nel continente ogni anno. Così come, il riuso consente di evitare fino al 97% di emissioni di anidride carbonica e di ridurre del 99% il consumo di acqua rispetto al riciclo chimico.
Un altro fattore fondamentale è rappresentato dall’impegno delle aziende. Si è pensato di far in modo che sempre più imprese tessili debbano obbligatoriamente rendicontare, in maniera trasparente, il proprio percorso di sostenibilità. In tal senso, solo tra il 2021 e il 2022 il numero di aziende europee della moda impegnate nell’ambito della garanzia della sostenibilità è aumentato del 17%.
Sta funzionando?
Eppure, questi sforzi non devono trarre in inganno. È ingente il numero di aziende che davanti ad una maggiore richiesta di prodotti sostenibili, sceglie non di introdurre cambiamenti nella produzione, che richiederebbero l’uso di grandi somme di denaro, ma semplicemente di far passare i propri prodotti per green e sostenibili, implementando il cosiddetto greenwashing.
Allo stesso modo, i consumatori tendono, più o meno inconsapevolmente, a cadere in queste trappole, finendo con il sostenere il crescente mercato del fast fashion. Si sceglie di acquistare abbigliamento economico, di scarsa qualità e non duraturo, ma che appare alla moda e che è prodotto, realizzato e spedito in fretta. Il successo di tale pratica è dato dai prezzi bassi e dall’ampia offerta disponibile, costantemente aggiornata alle ultime novità.
Chi subisce?
Le ricadute si riscontrano principalmente sui lavoratori e sull’ambiente.
Mantenere i prezzi bassi si traduce in uno sfruttamento dei lavoratori, che sono obbligati ad accettare paghe basse e a lavorare in condizioni precarie, in assenza di garanzie di sicurezza, con turni troppo lunghi, senza pause o ferie, e spesso in nero. I luoghi di fabbricazione, infatti, sono principalmente paesi nei quali la regolamentazione è meno rigida. Ad esempio, attualmente, i primi tre esportatori di vestiti verso l’Unione Europea sono Cina, Bangladesh e Turchia.
Inoltre, al fine di poter offrire un prezzo finale basso si decide di rinunciare ad una serie di attenzioni che dovrebbero essere attuate per diminuire l’impatto ambientale. Utilizzare materie prime economiche, le cosiddette microplastiche, quali poliestere, nylon ed elastane, ha un impatto che si estende non solo dopo, ma anche durante l’utilizzo, poiché una piccola quantità di esse viene rilasciata nell’ambiente, mentre indossiamo o laviamo i vestiti.
Quanto inquinano i nostri vestiti?
Secondo l’UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) la produzione annuale di capi di abbigliamento richiede il consumo di 93 miliardi di metri cubi d’acqua ed è responsabile del 20% dell’inquinamento acquifero.
In media, compriamo più del necessario e, secondo quanto stimato dalla Commissione Europea, questa tendenza continuerà ad aumentare. Ci si aspetta, infatti, che il consumo di capi d’abbigliamento passi da 62 a 102 milioni di tonnellate entro il 2030.
Dunque, bisogna controllare in maniera più stringente l’operato delle aziende, ma, allo stesso tempo, non si deve sottovalutare la differenza apportata dai consumatori che, scegliendo con più consapevolezza, hanno la possibilità di ostacolare il successo di tali realtà e di impedire l’incremento di queste pratiche. Bisogna puntare sulla qualità, piuttosto che sulla quantità. Sul riuso e sul riciclo, piuttosto che sullo spreco.
Ricordiamolo anche in vista delle feste natalizie, momento in cui gli acquisti e i consumi aumentano fortemente. Acquistiamo di meno e meglio, tenendo a mente che ogni piccola azione individuale può fare la differenza.
Per approfondire: