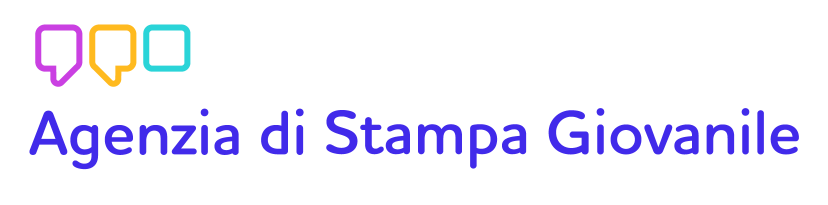Dietro le vetrine: un mondo consumato
Avete presente quei film di fantascienza dove oltre al pianeta Terra ne viene mostrato un altro allo stesso modo abitato da esseri viventi, dove la vita scorre ma in maniera diversa?
E se questo “secondo mondo”, questa “realtà parallela” esistesse veramente? Ma non in un altro pianeta, non in un’ altra parte dell’universo, bensì proprio a pochi chilometri da noi. Un’ altra realtà, così distante dai nostri occhi, dalle nostre orecchie e specialmente dal nostro modo di vivere e pensare, da risultare estranea, inventata, quasi impossibile…ma ahimè, davvero impossibile non lo è! Anche se non la vediamo, se ignoriamo l’esistenza e gli effetti che questa produce, essi si riversano sulla nostra stessa vita. La realtà di cui sto parlando prende il nome di “fast fashion” e davanti a essa e alle sue conseguenze noi consumatori occidentali non possiamo più permetterci di rimanere ignari.
La fast fashion è un fenomeno recente, formatosi negli ultimi 20 anni, che ha trovato terreno fertile per nascere e svilupparsi nella società occidentale dove dagli anni ’50 ha preso vita un sempre più esteso ed ampio sviluppo economico, specialmente nel settore tessile. Il termine indica quel meccanismo economico su cui si basano i marchi d’abbigliamento low cost: la riproduzione di una versione simile ai “trend” visti sulle passerelle ma venduta a prezzi accessibili, arrivando a produrre non più 2 o 4 collezioni all’anno, ma fino a ben 52! Introducendo nuovi capi ogni settimana! Quando scegliamo, quindi, siamo influenzati dal principio che il fast fashion ha generato: ci saranno tantissime altre cose da comprare e non avremo più bisogno del capo vecchio. In questo modo, capi d’abbigliamento nuovi vengono acquistati anche quando quelli vecchi sono ancora indossabili e utilizzabili. Negli ultimi anni, il ciclo della moda è diminuito costantemente mentre i rivenditori della fast fashion vendono vestiti pensati per essere gettati dopo essere stati indossati solo poche volte. Uno studio (citato in un articolo del The Guardian¹) ha osservato che rispetto a 20 anni fa siamo arrivati a comprare ben il 400% di vestiti in più!
In un recente articolo l’Huffington Post² ha sottolineato che per rendere conveniente questa tendenza di rinnovamento continuo, i prodotti della fast-fashion hanno, in genere, un prezzo molto più basso rispetto alla concorrenza, operando su un modello di business basato su bassa qualità e quantità elevate. Le merci di bassa qualità incrementano il consumo eccessivo perchè hanno una durata di vita più breve e devono quindi essere sostituite molto più spesso. Di conseguenza negli ultimi il volume dei vestiti da smaltire o riciclare è aumentato notevolmente. Il problema è che i beni di scarsa qualità possono solo finire come rifiuti poiché sono difficilmente riciclabili. La maggior parte dei capi buttati via (11 miliardi di abiti all’anno solo per gli americani secondo il documentario The true cost³) non è degradabile perché è fatta con tessuti sintetici, con fibre a base di petrolati. Questi sono pertanto destinati alle discariche dove possono rimanere per 200 anni o più, rilasciando nell’aria gas nocivi. Inoltre un capo a 10 euro o meno cela un mondo di ingiustizie che, nel contesto luccicante dello shopping, si fa fatica a immaginare. Il calo netto dei prezzi e la domanda in continua crescita celano un mondo fatto di continui sfruttamenti naturali e umani privi di ogni principio morale ed etico.
Questo processo di “democratizzazione della moda” è figlio di un modo di produrre che si occupa solo degli interessi delle grandi imprese. Tagliare i costi e non considerare conseguenze ambientali e di sicurezza sul lavoro è diventata una strategia completamente accettata per fare successo. Al giorno d’oggi il 97% della produzione tessile è delocalizzato nei paesi in via di sviluppo, dove India e Bangladesh, vicino alla Cina, detengono il maggior numero di fabbriche e lavoratori al mondo. In questi paesi gli operai sono costretti a dei turni lavorativi massacranti (fino a 16 ore al giorno) e la loro paga è talmente bassa (circa 3 $ al giorno)³ da costringere le madri a non tenere con sé i propri figli, ma lasciarli ai parenti nel proprio villaggio d’appartenenza e vederli solo poche volte l’anno.Inoltre le condizioni lavorative sono così disperate da permettere di definire questo fenomeno una vera e propria forma di schiavitù contemporanea, una piaga che colpisce, come sempre, i più deboli.
Per di più le strutture lavorative la maggior parte delle volte non sono a norma, bensì presentano delle situazioni di degrado³ tali che molto spesso si verificano numerosi incidenti e talvolta delle morti. Come nel caso del disastro del Rana Plaza avvenuto a Dhaka, capitale bengalese, il 24 aprile 2013 (quel giorno l’edificio collassò causando 1129 vittime e circa 2.515 feriti, diventando così il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile nella storia)⁴. Questo edificio di otto piani conteneva alcune fabbriche di abbigliamento, una banca, appartamenti e numerosi altri negozi. Le fabbriche realizzavano abbigliamento per noti marchi del fast fashion tra cui Primark, Walmart, Mango, NKD e molte altre tra cui anche Benetton.
Mezzi di informazione del Bangladesh hanno riferito che gli ispettori avevano scoperto crepe nell’edificio il giorno prima del crollo e ne avevano chiesto l’evacuazione e la chiusura. Mentre i negozi e la banca ai piani inferiori furono immediatamente chiusi, i lavoratori tessili furono obbligati a tornare il giorno dopo con la minaccia di trattenere loro un mese di stipendio se non l’avessero fatto.
Nei giorni seguenti si accesero numerose proteste e insurrezioni dei lavoratori tessili che chiedevano migliori condizioni di lavoro, manifestazioni che furono represse con il sangue da parte della polizia⁴. Ma non solo, pochi mesi prima del crollo del Rana Plaza ci fu un incendio in un’altra fabbrica tessile che causò 100 morti⁵. Anche a Phnom Penh (Cambogia) una manifestazione degli operai tessili che richiedevano un aumento di salario si concluse con l’azione violenta della polizia che causò 23 morti e più di 40 feriti.³L’India, come il Bangladesh, lo Sri Lanka, la Cambogia ed altri, è un’altro dei paesi martoriati da questo tipo di economia. Oltre alle mostruose condizioni lavorative anche le conseguenze che ha l’uso intensivo di pesticidi e di fertilizzanti usati per la coltivazione del cotone sono raccapriccianti: questi causano difetti congeniti, tumori, malattie mentali, disfunzioni fisiche che vanno a colpire molto spesso i bambini ed i genitori, non potendo supportare le loro cure, sono costretti ad accettare la morte dei loro figli.³
Inoltre le aziende di sementi che detengono il monopolio della pianta del cotone OGM usata in queste coltivazioni costringono i contadini ad abbandonare le proprie terre, a causa del loro indebitamento generato dall’acquisto di questi semi che sul mercato hanno dei prezzi molto alti. Negli ultimi 16 anni sono avvenuti più di 250000 suicidi di contadini in India (la maggior ondata di suicidi nella storia). Sempre in India, nella regione del Kanpur, nota per la sua alta concentrazione di concerie, ogni giorno milioni di litri di acque reflue tossiche defluiscono dalle concerie locali e vanno a immettersi nel Gange. I pesanti prodotti chimici usati per il trattamento del cuoio contaminano l’acqua, che viene utilizzata direttamente dagli abitanti del luogo, e le falde acquifere ormai ricche di cromo vanno ad inquinare i raccolti dei locali e diffondendo così malattie gravi³. Come se non bastasse spesso i lavoratori non vengono nemmeno pagati! Tanto che nel 2016 gli operai tessili di un produttore esterno di vestiti per Zara ed altri rivenditori, decisero di inserire dei biglietti nascosti nei vestiti consegnati, con una frase emblematica “Ho fatto questo capo che stai per comprare, ma non sono stato pagato”⁶, cercando di esortare così gli acquirenti a sostenere la loro campagna per far si che venissero retribuiti per il loro lavoro.
Quello del fast fashion è, come ho già sostenuto prima, il volto di una nuova forma di schiavitù contemporanea. Come consumatori stiamo contribuendo, e spesso non ce ne rendiamo conto, a questo disastro dalle dimensioni enormi e non possiamo più rimanere ignari di fronte a questa realtà che ci viene accuratamente nascosta. Non viviamo in un “mondo separato” e non possiamo adottare un metro di misurazione della giustizia tanto impari. È nostro dovere informarci e combattere queste ingiustizie, è nostro dovere non indossare più abiti sporchi del sangue di qualche povera donna sfruttata, è nostro dovere acquisire maggiore coscienza delle nostre azioni e scelte, cercare nel nostro piccolo di cambiare le cose. Ed è una responsabilità che abbiamo non solo nei confronti della natura, ormai sfinita, di questi lavoratori e delle loro famiglie, ma l’abbiamo anche verso noi stessi e la nostra vita. Il mondo che abitiamo tutti è uno e non ci possiamo permettere di pensare ancora che sia composto da “sotto-mondi” separati e indipendenti dal nostro. Le scienze ci hanno sempre insegnato che tutto è connesso, che ogni azione ha un suo effetto che si lega ad una serie di altri effetti derivanti, dovremmo allora compiere le nostre scelte ricordandoci come anche soltanto ai nostri vestiti siano connessi tanti cuori e mani.
La realtà non si divide fra Oriente e Occidente, fra ricco e povero, la realtà non dovrebbe avere muri.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/may/08/fast-fashion-death-for-planet
https://www.huffingtonpost.it/2016/09/09/vestiti-moda-spreco_n_11925956.html
documentario The true cost di Andrew Morgan (2015)
https://it.wikipedia.org/wiki/Crollo_del_Rana_Plaza_di_Savar
https://www.huffingtonpost.it/2012/11/28/incendio-bangladesh-disney_n_2204421.html