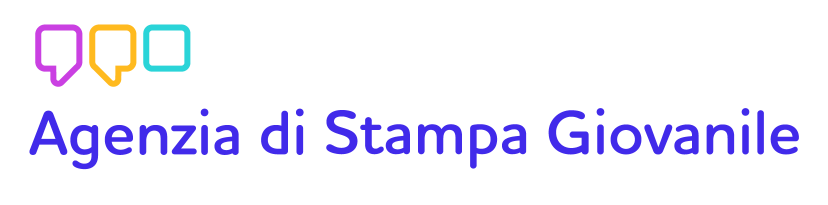Matthias Canapini: Raccontare il mondo camminando
di Roberta Pisani, articolista dell’Agenzia di Stampa Giovanile
Tiziano Terzani, tempo fa, affermava quanto ogni luogo fosse una miniera d’oro, e di quanto gli incontri e le conoscenze fatte durante il viaggio potessero trasformare anche il luogo più insipido, più insignificante, in un meraviglioso teatro di umanità.
Matthias Canapini, classe 1992, ha fatto tesoro di tali parole, viaggiando dal lontano oriente fino alle aride terre del sud Italia, messe alla prova dalla terra tremante; ha camminato per le violentate terre siriane e irachene, ridotte a colabrodo dai conflitti che da anni ormai le torturano, e riscoperto le storie ormai dimenticate che si celano per le strade di Sarajevo e nei piedi di coloro che intraprendono la rotta balcanica con il cuore gonfio di speranza, ma anche di dolore.
Con macchina fotografica e taccuino Matthias Canapini esplora i margini e le zone di confine, spesso disumanizzate e ridotte a fredde percentuali dai media ufficiali. Racconta storie di uomini e di donne che vivono la propria quotidianità in quei luoghi, da noi percepiti così lontani e così diversi, ma che in fondo non lo sono poi così tanto. “Può cambiare la fede, lo stile di vita, le abitudini. Ma la realtà dei fatti è che i luoghi di conflitto, i margini, sono abitati da studenti, fornai, lavoratori. Che sono proprio come noi”.
Il fotoreporter ha deciso di dare voce a quelle persone che difficilmente si sentono parlare, e di raccontare le storie di quei luoghi che, nonostante la fine della guerra, portano ancora le cicatrici delle sofferenze subite. Così, fa da testimone e narratore delle numerose storie che queste terre dimenticate ancora celano e custodiscono.
Nei suoi libri (il cui ricavato della vendita serve a finanziare progetti di ricostruzione del post-terremoto in centro Italia) “Eurasia express. Cronache dai margini” (2017) , “Il passo dell’acero rosso. Alberi, pecore e macerie”(2018), “Confini, scatti a passo d’uomo” (2019), “Terra e dissenso. Voci in movimento”, “Il volto dell’altro” (2016) e “Verso Est” (2016), Matthias racconta storie lontane, che vengono da oriente, così come storie che nonostante siano più vicine, sono state comunque dimenticate: le storie che vengono dalle terre colpite dai terremoti del centro Italia e le testimonianze della guerra della Bosnia Erzegovina.
Prossimamente verrà pubblicato da Aras Edizioni il nuovo libro di Matthias Canapini, “L’ovale storto. Ritratto poetico del rugby inclusivo”. Un’opera che contiene storie tutte italiane di cui dovremmo essere a conoscenza e andarne fieri. Un viaggio sui campi da rugby italiani, che ci fa conoscere migranti, detenuti e persone con disabilità che hanno trovato nel rugby un meraviglioso strumento di espressione e inclusione sociale.
La lezione che Matthias ci da nei suoi libri e nelle sue parole, è la necessità di parlare dei confini, non solo attraverso le storie di orrore e ingiustizie, che tendono essere le preferite dai media, ma anche e soprattutto attraverso le storie delle persone che i confini li abitano, e i numerosi esempi di progetti che questi muri stanno cercando di abbatterli.
La lezione che Matthias ci da nei suoi libri e nelle sue parole, è la necessità di parlare dei confini, non solo attraverso le storie di orrore e ingiustizie, che tendono essere le preferite dai media, ma anche e soprattutto attraverso le storie delle persone che i confini li abitano, e i numerosi esempi di progetti che questi muri stanno cercando di abbatterli.
Ho avuto occasione di conoscere Matthias a Bolzano, dove era ospite di un evento a cura del Centro per la Pace e di fare due chiacchiere con lui, per farmi raccontare della sua vita avventurosa, dei suoi progetti passati, presenti e futuri.
-Raccontami un po’ di te e di che cosa ti occupi esattamente.
Che cosa combino nella vita? Nella vita provo a raccontare storie, con taccuino e macchina fotografica. Ho iniziato a 19 anni dopo il diploma, quando sono partito per la Bosnia. Inizialmente avevo provato a studiare lingue orientali, ma dopo pochissimo tempo ho capito che non faceva per me. Sentivo una grande voglia di raccontare camminando, ho iniziato così la mia vita nomade.
Sono partito per la Bosnia, dove ho incominciato a raccogliere le prime storie, soprattutto nelle zone minate attorno a Sarajevo. Volevo vedere cosa fosse rimasto dopo la guerra che è scoppiata l’anno in cui sono nato io, nel 1992. Ne avevo spesso sentito parlare, anche in famiglia, così ho deciso di documentarmi e approfondire la questione. Quello che è seguito in quel viaggio è stato il frutto di circostanze e incontri, che mi hanno portato a viaggiare lungo i Balcani, Turchia, Siria.
Successivamente ho fatto un viaggio che mi ha portato dalla Cina all’Italia, utilizzando i mezzi pubblici, facendo una piccola eccezione per un aereo che ho preso per raggiungere in tempo una famiglia afgana e percorrere con loro a piedi un tratto della rotta balcanica, fino in Croazia. Sono stato all’estero fino ai 23 anni, quando ho sentito un forte richiamo verso casa, e la necessità di raccontare anche le nostre storie, quelle dei partigiani, del terremoto. Dopotutto tutto è un ciclo, e come vi è il momento di partire, vi è anche quello di tornare.
-Come organizzi i tuoi viaggi? E come decidi le mete?
Generalmente mi faccio guidare sia da un mio interesse personale, sia dalle occasioni e conoscenze che mi capitano durante i viaggi. Ad esempio nel caso dell’Ucraina e Vietnam me li sono studiati prima. Nel caso invece del viaggio in centro Italia è stato molto di più esplorazione, e vi è da dire che spesso i viaggi più belli sono stati proprio quelli che ho organizzato poco. Molto spesso poi cerco di creare delle reti, con conoscenti, ONG italiane e del posto. Nel caso dell’Iraq mi sono appoggiato ad Emergency e all’associazione Un ponte per. In Mongolia, invece, ho collaborato con una associazione locale, trovata durante il viaggio. Spesso quando si tratta di enti locali è difficile contattarli dall’Italia, perché non hanno siti internet o sono poco aggiornati.
Generalmente viaggio senza commissioni e non sono pagato per farlo. Questo mi permette di prendermi il tempo di cercare l’incontro con l’altro, senza forzare i tempi o forzare le persone a parlare perché ho una consegna da fare. É importante avere tempo, o meglio, prendersi tempo, perché ti permette di creare empatia. Ti permette di abolire l’idea che gli altri sono “solo gli altri” e cominci a pensare che gli altri in fondo sono come te. E in un contesto del genere come vorrei che l’altro si comportasse con me?
A proposito del rispetto dell’altro mi ricordo bene un padre siriano, che stava fuggendo dal paese dove aveva lasciato la famiglia, che alla mia richiesta di raccontarmi la sua storia mi aveva chiesto il perché. Perché lui, avrebbe dovuto raccontarmi la sua terrificante storia? Mi ha fatto riflettere molto.
-E la tua famiglia cosa ne pensa dei tuoi viaggi?
Fin da piccolo ho sempre viaggiato con la mia famiglia, infatti i miei primi ricordi legati al viaggio sono proprio legati a loro, ai miei genitori che mettevano in macchina me e i miei due fratelli e ci portavano verso nord, verso la Normandia, Irlanda, Scozia. Erano viaggi spartani, viaggi zingari, dove si viaggiava per campeggi e il contatto con la terra era molto forte. Quando viaggio, inoltre, mi piace pensare di non farlo mai solo, con me ci sono sempre la mia famiglia, i miei amici e tutta la rete di contatti che mano a mano si crea.
-Cosa pensi che sia cambiato ora nel mondo del fotogiornalismo e del viaggio, rispetto ad una volta?
Così d’istinto ti direi la fretta. E il tempo che dedichiamo ad informarci. Al giorno d’oggi i momenti che giornalmente dedichiamo all’informazione sono sempre meno e per questo dev’essere sintetica e immediata. Vedo sempre meno lentezza nel narrare le storie e nel mondo del giornalismo, che inoltre stato fortemente influenzato dal fatto che chiunque può generare informazione, semplicemente avendo a disposizione uno smartphone. Inoltre sono sempre meno gli inviati ufficiali. Vedendo ad esempio i reportage di Internazionale, sono sempre di più le fotografie scattate da reporter del posto. Inoltre, penso vi sia una grande necessità di fare informazione di qualità e soprattutto neutra, che lasci libertà di pensiero al lettore, aspetto apparentemente semplice ma spesso “dimenticato”.
-Qual è stata una delle esperienze che ti è rimasta più impressa durante i viaggi?
Una delle esperienze più drammatiche da me vissute durante i viaggi è stata sicuramente in Vietnam, dove ho appreso che nonostante la guerra fosse finita nel 1975, in un tempo che appare lontano anche ai miei genitori, gli effetti della tragedia sono tutt’ora visibili. Visitando alcuni ospedali del paese mi è stata mostrata l’eredità lasciata dall’agente arancio, una sostanza defoliante a base di diossina, sganciata durante la guerra. Secondo le stime, al giorno d’oggi, 5 milioni di persone sono ancora contaminate da queste sostanze, e i bambini nati con malformazioni dovute alla contaminazione sono innumerevoli. Soltanto nel 2075, ovvero 100 anni dopo la fine della guerra, si pensa termineranno gli effetti e le conseguenze, di un agente occupato per meno di 10 anni. Avere memoria e diffondere queste informazioni non è un modo per denigrare il paese, sottolineando gli orrori tuttora presenti, ma è una testimonianza che serve a ricordare e ricordarci di dire un grande NO alla guerra!
-Ai giovani che hanno voglia di viaggiare e conoscere il mondo, ma hanno un po’ di paura cosa diresti?
Fate quello che vi rende felice. Tutti abbiamo delle catene, che ci bloccano. Sono le paure, le insicurezze. Quando sono partito mi ricordo che mia madre mi ha detto: “Fregatene delle convenzioni! Rompi i confini, le convenzioni e buttati nel mondo per capire chi sei”. Se sogni di fare il contadino e finisci a fare l’impiegato, potrai essere il migliore impiegato del mondo, ma la terra ti mancherà sempre. Il viaggio per me è servito anche a questo. Attraverso i miei diari, i miei scritti, racconto sì gli altri, ma racconto anche me stesso, perché l’incontro con l’altro permette di capire moltissimo anche sul proprio conto. L’invito che faccio, è dunque questo. Di seguire ciò che si vuole fare. Perché nella vita siamo tutti appesi ad un filo, e se ti deve capitare qualcosa, capiterà, che tu sia qui o dall’altra parte del mondo.