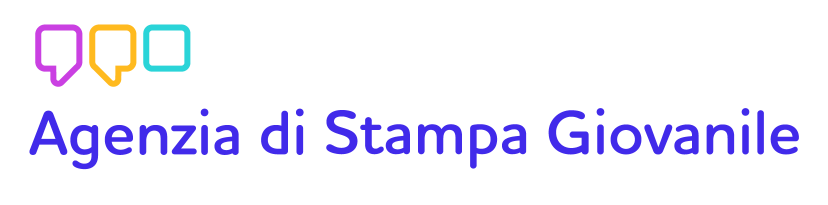Due storie, un obiettivo: i diritti umani
di Giulia De Nadai e Tommaso Orlandi
traduzione di Carlotta Zaccarelli, foto di Giulia De Paoli
Dopo aver festeggiato la giornata mondiale dei difensori dei diritti umani, il 9 dicembre, oggi, 10 dicembre, viene celebrato il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Alla Conferenza ONU sul Clima (COP24) abbiamo voluto approfondire la tematica e capirne il nesso con i cambiamenti climatici assieme a Joan Carling e Francesco Martone.
Joan appartiene all’etnia filippina Kankanaey e lotta per i diritti umani sin dalla gioventù: ad oggi, ha lavorato con i popoli indigeni di tredici Paesi asiatici. L’attivismo l’ha resa pericolosa per le autorità filippine, che l’hanno definita terrorista e l’hanno costretta a lasciare il Paese. Le Nazioni Unite hanno invece premiato la donna con il prestigioso Premio ambientalista per i Campioni della Terra attribuitole per l’impegno e la perseveranza. Francesco Martone è invece un difensore dei diritti umani in Italia. Ha lavorato con Greenpeace International tra il 1988 e il 1995, diventando poi presidente di Greenpeace Italia per tre anni. Inoltre, è stato senatore della Repubblica italiana dal 2001 al 2008. Chiacchierando con questi due straordinari personaggi, abbiamo toccato numerosi argomenti. È stato uno scambio arricchente e profondo, che ci ha aiutati ad approfondire nuove prospettive sui diritti umani.
–Oggi, 10 dicembre, è il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Pensando a questo, vorremmo chiedervi cosa vi ha spinto a dedicare la vostra vita alla difesa dei diritti umani.
Joan Carling: Ho cominciato la mia carriera di attivista quando ancora studiavo nelle Filippine, piena di entusiasmo per i diritti degli studenti. Mi sono dapprima interessata alla causa di molti villaggi indigeni minacciati da progetti di dighe. È stato il caso della diga di Chico, nel 1970, che mi ha incoraggiato ad approfondire la questione dei diritti dei popoli indigeni. Dopo l’università, sono tornata nella zona tribale affetta dal progetto ed era già militarizzata. Vedere il trattamento riservato agli indigeni, i loro villaggi bruciati e i loro bambine e le loro donne completamente trascurate ha avuto un impatto molto forte su di me. Ho cominciato a pensare alle ragioni per cui queste persone venivano trattate come bestie e ho capito che alcuni individui sono valutati meno di altri. Non sopportavo l’idea. Quell’esperienza ha solidificato in me la certezza che tutti hanno gli stessi diritti e che tutti meritano la stessa dignità, indipendentemente dalla loro origine, cultura, razza o stato sociale. Siccome le comunità indigene sono dimenticate, dobbiamo prestare loro la nostra voce. Se nessuno parla per i dimenticati, gli ignorati, i trascurati, siamo tutti complici di chi sostiene e perpetra la disuguaglianza e la violenza.
Quando sono diventata una vittima, a causa del mio arresto e successiva detenzione, la mia prospettiva è ulteriormente mutata. Visitavo già i prigionieri politici, fornendo loro supporto e consigli: ma essere dietro le sbarre in prima persona è un’esperienza assai diversa. Solitamente diamo per scontata la nostra libertà, ma non dovremmo. La mia prigionia è stata il momento in cui ho veramente cominciato a essere attivista per i diritti umani, una decisione che con gli anni si è solo fortificata.
Francesco Martone: Sono sempre stato un sostenitore dei diritti umani. La prima volta che ne ho sentito parlare è stato durante la dittatura di Pinochet in Cile. Ho cominciato a partecipare ai movimenti pacifisti e ambientalisti negli anni Ottanta, quando sono diventato membro di Amnesty International e Greenpeace. Attraverso quest’ultima organizzazione, ho lavorato a una campagna in difesa della foresta tropicale. Chico Mendes è stato ucciso in quegli anni: può essere considerato il primo ambientalista.
Ho sentito di dovermi spendere ancora di più per i diritti umani quando sono stato eletto nel Parlamento italiano. Ero Segretario della Commissione senatoriale per i Diritti umani. Lavoravamo duro, specialmente sulle questioni dell’immigrazione e della detenzione. La nostra idea era che i diritti umani non sono un concetto astratto, ma qualcosa che può impattare seriamente la nostra vita. È ormai risaputo che nel 2001, durante il G8 a Genova, la Polizia ha perpetrato azioni di repressione estremamente violente, che in alcuni casi si sono tradotte in pesanti pestaggi di attivisti. In quell’occasione, ho pensato: “Potrebbe succedere anche a me”.
–Attualmente, quali sono gli strumenti per proteggere i difensori dei diritti umani? Sono sufficienti allo scopo?
Joan: Stati e governi sono obbligati a rispettare e proteggere i diritti umani. È il principio base della Dichiarazione dei diritti umani e delle Nazioni Unite. Ci sono numerose Carte dei diritti umani che mettono a disposizione importanti strumenti: la Dichiarazione stessa, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Questi trattati stabiliscono i criteri secondo cui deve svilupparsi il rapporto tra Stato e cittadini. Quando uno Stato viola i diritti dei suoi cittadini, ci deve essere un meccanismo che lo renda imputabile: questo è ciò che manca.
I difensori dei diritti umani hanno ragione a lamentarsi. Tuttavia, la mancanza di una corte d’appello fa sì che l’unica risposta che ricevono dagli Stati sia la repressione: maggiori restrizioni, maggiori proibizioni, più omicidi extragiudiziari. Non c’è più giustizia, non c’è più rispetto per la giustizia. Sfortunatamente, questo è il modo in cui attualmente funzionano le cose: non possiamo imputare ai governi le loro colpe.
Quindi, quando si parla di strumenti in difesa degli attivisti per i diritti umani, è fondamentale sottolineare la necessità di un nuovo strumento. Altrimenti rimaniamo nel limbo attuale, in una situazione di crisi umanitaria in cui coloro che dovrebbero proteggere in realtà attaccano. Ci sono leggi antiterrorismo usate contro gli attivisti e non contro potenziali terroristi. Ci chiamano terroristi, così da poter usare strumenti giuridici validi per fermare la nostra attività. Io stessa mi trovo in questa condizione, perché nelle Filippine sono accusata di essere una terrorista. Mi sono rivolta a tutti gli organi delle Nazioni Unite, incluso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani, nato recentemente. L’ufficio è stato molto efficiente nel portare alla luce problematiche legate al rispetto e alla tutela dei diritti umani e nel sottoporle agli Stati.
Ad oggi, numerose organizzazioni internazionali come Global Witness e Front Line Defenders hanno pubblicato dati e analisi che dimostrano come molte persone siano state uccise a causa del loro attivismo o della violazione dei loro diritti umani. E il 60% di questi individui erano indigeni. Da un punto di vista geografico, l’America Latina ha il primato negativo di uccisioni. In Asia, il luogo più pericoloso per i difensori dei diritti umani sono proprio le Filippine. La situazione attuale è, ripeto, segnata dalla mancanza di un meccanismo di responsabilizzazione. Io, per esempio, non posso nemmeno muovermi in sicurezza a causa delle accuse che mi sono rivolte. L’unico strumento che per ora abbiamo sono le Nazioni Unite, che però sono deboli in questo ambito. L’unica soluzione che intravedo è reclamare i nostri diritti civili. Dobbiamo costruire una rete di solidarietà tra noi, dobbiamo pretendere che le autorità diventi imputabili dei loro crimini. I cittadini di tutto il mondo, le comunità locali, le donne, i giovani devono far fronte comune per sottrarre il potere a chi ne abusa piegandolo ai propri interessi. Siccome il meccanismo che dovrebbe occuparsi di ciò non funziona, le persone devono sfruttare l’influenza della comunità per assicurare a ciascuno la giustizia.
Francesco: Condivido il ragionamento di Joan. Quest’anno celebriamo anche il ventesimo anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori dei Diritti umani. Nell’ultimo ventennio, abbiamo assistito al moltiplicarsi degli eventi, delle conferenze e delle campagne sui e per i difensori dei diritti umani. Tuttavia, allo stesso tempo, il numero di difensori uccisi è aumentato. Per esempio, in Colombia più di duecento capi indigeni sono stati assassinati solo nel corso del 2018. Il motivo dietro tutte queste morti è sicuramente la lotta per controllo delle terre per estrarre le risorse naturali.
La mia analisi mi porta a dire che siamo testimoni della crisi del sistema internazionale multilaterale. È una crisi politica, economica e culturale fondata sull’urgenza avvertita da alcuni di riconquistare il controllo dello Stato-nazione e di proteggere il suo spazio pubblico. Ci sono legami molto stretti tra sviluppo e repressione. A questo proposito, ho incontrato un attivista per i diritti umani attaccato insieme al suo gruppo da fascisti mentre stava protestando estremisti di destra a Varsavia due settimane fa. In quella circostanza, come spesso accade, la polizia non è intervenuta.
Ci sono molti strumenti per difendere chi si batte per i diritti umani, ma penso che manchi la convergenza di movimenti sociali, cittadini e comunità che vogliono proteggere valori utili alle generazioni future. Sono personalmente molto attivo nel Tribunale permanente dei Popoli, specialmente nelle questioni sulle migrazioni. La corte interviene nei casi in cui si registra la violazione dei diritti umani e dei popoli e le vittime non trovano altri spazi in cui far valere la propria posizione. Il mio comitato ha aperto una sessione sulla violazione dei diritti dei migranti a Palermo. Si è chiusa con il riconoscimento che non esiste uno strumento legale internazionale che riconosca i migranti come esseri umani che hanno diritto di migrare e di auto-determinarsi.
Al Tribunale permanente dei Popoli, abbiamo anche discusso a lungo degli impatti che le compagnie europee transnazionali hanno sui diritti umani in America Latina. La questione ha generato una serie di iniziative condotte da movimento transnazionali europei e latinoamericani quali una campagna per smantellare il potere delle grandi aziende. Abbiamo anche iniziato un processo esterno per scrivere un tratto degli individui sulle compagnie multinazionali. Dentro le Nazioni Unite, alcuni Paesi come l’Ecuador stanno inoltre spingendo per varare un accordo vincolante sui diritti umani e le compagnie multinazionali. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di simile per i diritti umani e per gli ambientalisti, il prossimo anno.
Recentemente, abbiamo poi creato una rete dedicata ai difensori dei diritti umani di tutto il mondo: si chiama “In difesa di”. Come misura di protezione, stiamo lavorando alla creazione di un sistema per connettere le persone e le loro comunità. La città italiana di Trento è molto attiva in quest’ambito e lavora molto nei Balcani attraverso progetti promossi dall’Associazione Trentino con i Balcani.
Le associazioni trentine hanno progetti anche in altri Paesi, come la Colombia dove assistono comunità assicurandosi che i locali non siano obbligati a fuggire dalle loro terre. Si tratta di un impegno molto importante, perché gli indigeni muoiono due volte quando sono forzati a spostarsi dalle loro zone. Assistere le comunità non significa solo proteggere, ma anche imparare: dobbiamo difendere i popoli indigeni e lasciare che vivano nel loro territorio secondo le loro tradizioni.
–Quanto è utile il supporto delle Nazioni Unite alle vostre attività di advocacy? Quando e come, invece, non lo è?
Joan: Le Nazioni Unite sono in crisi, perché mancano meccanismi di responsabilizzazione. Tuttavia, continua a riconoscere che i diritti umani sono importanti. Nel mio caso, ciò che mi ha aiutato è stata l’attribuzione del premio “Campioni della Terra”, il più alto riconoscimento dell’ONU in ambito ambientale. Sanno che sono un’attivista, conoscono il mio lavoro nelle Filippine: dandomi il premio, le Nazioni Unite hanno voluto dichiarare che attivisti e difensori dell’ambiente non sono terroristi. È stata un’azione utile anche per altri attivisti, che condividono simbolicamente con me il premio e si sentono scagionati.
Il Consiglio dei Diritti umani continua a produrre strumenti, come il lavoro fatto per la creazione di strumenti legalmente vincolanti per le multinazionali. È un punto critico, perché molte violazioni dei diritti umani sono perpetrate nel settore industriale privato a favore degli interessi delle imprese. Ma gli attuali strumenti sono insufficienti. I cittadini devono riappropriarsi e difendere i propri interessi. Devono agire in prima persona, scattando foto e organizzando campagne mediatiche per dimostrare le violazioni. Oggi, l’utilizzo dei media per sviluppare una coscienza comune è fondamentale – anche perché gli Stati ricorrono ai media per giustificare i loro crimini. Le Nazioni Unite devono svegliarsi e assumersi i propri doveri e le proprie responsabilità.
–Cosa possono fare gli studenti universitari per sensibilizzare la società sui diritti umani?
Joan: Potete organizzare discussioni, gruppi e utilizzare i media. Sono piccoli gesti che rompono il silenzio sulla questione dei diritti umani perché accendono l’interesse degli studenti universitari stessi. La caratteristica migliore dei giovani è la loro creatività, unita alla loro apertura mentale. Devono solo utilizzare questo potenziale.
Anche io ho cominciato quando ero studentessa, e posso dire che è stato il momento in cui ho vissuto tantissime esperienze formative. È possibile iniziare a costruire legami con le comunità locali i cui diritti territoriali sono minacciati, per esempio. Le tecnologie odierne consentono di comunicare con chiunque dovunque, facilitando la nascita di reti di persone. Significa che c’è così tanto che si può fare. La prima cosa da fare è la sensibilizzazione, l’educazione delle persone sugli argomenti legati ai diritti umani. Le persone, e prima di tutto le nuove generazioni, devono capire che ciò che accade a uno di noi ha conseguenza nella vita di tutti. Dobbiamo costruire connessioni basate sulla solidarietà e azioni collettive.
–Secondo voi, il mondo di oggi è davvero più disilluso e crudele di quello che c’era quando voi eravate studenti?
Joan: Penso che ci sia stato un cambiamento determinato dall’aumento delle opzioni disponibili per i giovani. Quando ero giovane, la legge marziale e il clima politico nel mio Paese mi davano uno scopo nella vita. I giovani di oggi non sentono nessun senso di finalità, perché possono fare tutto senza restrizioni. In più, il loro mondo sta diventando sempre più digitale: non riescono più a vedere la quotidianità degli altri. Senza avvertire la limitatezza del proprio mondo, si perde la speranza. Al contrario, se si reagisce di fronte all’ingiustizia, si riguadagna la speranza: aiutare le persone significa distogliersi da sé stessi e questo genera speranza. Significa anche capire che ci sono altre persone che hanno bisogno d’aiuto, di una voce. Una volta che arrivi a questa consapevolezza, la tua vita si riempie di significato. Abbiamo bisogno di portare i giovani a questa consapevolezza: hanno bisogno di avere uno scopo, di cercare un significato.
Non ci sono oggi tanti attivisti quanti ce n’erano nella mia generazione. Oggi ci sono troppi privilegi e distrazioni. I giovani hanno più possibilità di scelta perché il loro ambiente è costruito esclusivamente attorno a loro. Se lo allargassero, se ampliassero il loro punto di vista, si accorgerebbero che davanti a loro ci sono spazi immensi dove conquistare uno scopo e un significato per la propria vita.
Francesco: Noi tutti dobbiamo riflettere sul concetto di speranza. Per esempio, ho letto un’intervista della femminista statunitense Wendy Brown. Quando le è stata chiesta un’opinione sull’attuale clima politico degli Stati Uniti e sulla crisi ambientale, ha risposto che faremmo meglio a parlare di responsabilità piuttosto che di speranza. Perché la speranza è un concetto troppo mistico. Io ho 57 anni e, ancora sento la responsabilità di dover fare qualcosa per consegnare alle generazioni future un mondo migliore. C’è una frase molto significativa di Wendy Brown: “Dobbiamo stare dove ci sono gli incendi. Dobbiamo spegnere il fuoco quando è distruttivo, ma dobbiamo mantenerlo in vita quando le fiamme sono troppo deboli”.
Riflettere sulla speranza non vuol dire riflettere sul pessimismo o sull’ottimismo, che sono concetti troppo relativi. Ricordo di essere stato ripreso da un blogger di Piazza Tahuman. Quando gli ho chiesto se fosse ottimista o pessimista, mi ha risposto: “Come pensi che mi possa permettere di essere un pessimista, se devo rischiare la vita per la difesa dei diritti umani?” La nostra responsabilità è immensa: stiamo lasciando dietro di noi un mondo pieno di guerra, odio, spreco, distruzione; stiamo distruggendo le fondamenta di uno stile di vita sano.
–Anche se il diritto a vivere in un ambiente salubre, menzionato per la prima volta nelle Dichiarazioni di Stoccolma e Rio de Janeiro, non è ancora stato inserito nelle principali carte internazionali, pensate che sia riconosciuto a livello internazionale?
Francesco: Possiamo dire che è riconosciuto in termine di strumenti. Per esempio, il principio di precauzione e del “chi inquina paga” sono utilizzati per assicurare agli individui un ambiente di vita sano. Si verificano problemi quando si considerano le azioni internazionali, come la creazione di un tribunale ambientale internazionale, istituzione di cui è stata enunciata la necessità nella Dichiarazione di Rio.
La discussione sui diritti umani intrecciati al cambiamento climatico è enorme. Le Convenzioni ONU si preoccupano dei diritti di partecipazione e informazione, così come della necessità di evitare che le attività di adattamento e di mitigazione non ledano i diritti umani. Il problema è non ci sono stati passi avanti nell’accesso alla giustizia: ci sono molte controversie sulla violazione del diritto a un ambiente sano. Dobbiamo creare una domanda politica, per far sì che le leggi siano applicate.
–Dal momento che gli effetti dei cambiamenti climatici sono considerati un problema internazionale, il riconoscimento del diritto a un ambiente di vita salubre potrebbe essere uno strumento efficace nella lotta contro il cambiamento climatico a livello locale?
Francesco: La discussione sulla punibilità dei crimini ambientali è andata diminuendo perché è abbastanza difficile stabilire il nesso causa-effetto. Non è facile considerare un emettitore di gas-serra colpevole di tutti gli effetti dei cambiamenti climatici. In altre parole, è difficile provare che un’azienda localizzata negli USA ha un impatto ambientale negativo su una comunità del Bangladesh. L’obiettivo è quindi di elaborare una responsabilità congiunta, indipendente dal nesso causa-effetto.
Un altro aspetto della questione è il tema “perdita e danno”, che consiste nel calcolare le perdite e immaginare processi di risarcimento, quali la ricostruzione degli ecosistemi o pagamenti finanziari. Sfortunatamente, il problema è abbastanza trascurato. Per esempio, la COP24 è stata sponsorizzata dall’industria carbonifera.
C’è anche meno spazio per la società civile, alla Conferenza: una direttiva del Governo polacco restringe le opportunità che ONG, movimenti sociali e difensori dei diritti umani hanno di essere attivi durante le negoziazioni. È qualcosa che si nota ogni giorno osservando la presenza massiccia delle forze dell’ordine negli spazi della COP – forze dell’ordine che potrebbero essere state piazzate non solo per motivi di sicurezza, ma anche a scopi intimidatori.