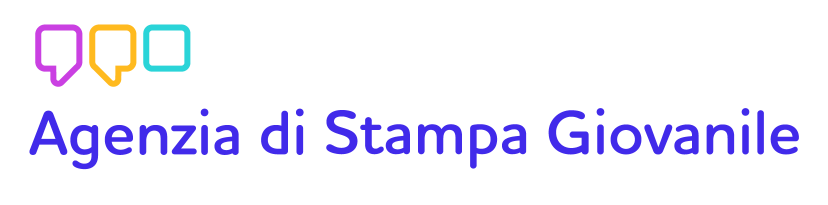La COP sei tu
Da 25 anni la storia delle conferenze ONU sul clima è quella di un nuovo e complesso rapporto tra scienza e politica. Non si tratta più di pochi scienziati che consigliano direttamente i governanti responsabili di decidere per il proprio paese. Il cambiamento climatico, ormai, è una sfida globale che richiede risposte globali (per quanto possano partire da movimenti locali), generando uno spazio decisionale definito da limiti scientifici rigidi (per quanto difficili da individuare) in cui la politica può muoversi sempre meno liberamente.
Come sottolineava Dominique Raynaud, un importante glaciologo francese, su Le Monde Diplomatique, nel novembre 2015: “L’IPCC (il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, ndr) , incaricato di nutrire la riflessione politica necessaria a far fronte a questa grande sfida che la nostra civiltà deve affrontare, è un’esperienza istituzionale unica”. Basti pensare che, alla stesura del quinto e ultimo rapporto del gruppo 1 dell’IPCC (che si occupa dell’aspetto strettamente climatico) hanno partecipato ben 259 ricercatori, che hanno dovuto rispondere a 50’000 commenti di altri esperti durante la stesura. Oggi l’IPCC conta sulla partecipazione di 195 paesi. Da parte della scienza, insomma, una risposta c’è stata.
È dal 1987 che possiamo correlare in modo inequivocabile la temperatura media della Terra alla quantità di CO2, e questa all’attività umana. Ed è nel 1988, un solo anno dopo, che l’IPCC prende vita e comincia ad operare. Nel 1992 il Vertice di Rio istituisce subito la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il cui organo decisionale è la Conferenza delle parti (COP). La COP1 si tiene nel 1995 a Berlino. Creato in tempi brevi lo spazio delle decisioni, al suo interno gli ingranaggi politici della risposta globale si inceppano subito. Nei successivi 20 anni il progresso è tutt’altro che lineare e, anzi, capita che si faccia qualche passo indietro, come con l’elezione di Donald Trump o, come nel 2012, quando Russia, Giappone e Canada si ritirano dal Protocollo di Kyoto (approvato dalla COP3 del 1997, firmato solo dai paesi industrializzati, ma mai ratificato dagli Stati Uniti).
Nel 2015, terminata la fondamentale COP21 di Parigi, Bill McKibben scrive sul New York Times che l’accordo firmato da 195 paesi nella capitale francese “avrebbe potuto funzionare se fosse stato approvato alla prima Conferenza del 1995”. La COP21 era chiamata ad una svolta dopo la fallimentare COP15 di Copenaghen, conclusasi senza accordi vincolanti, ma col riconoscimento della soglia di 2°C come il massimo aumento “accettabile” di temperatura nel 2100 rispetto al 1880; la COP di Parigi è stata sicuramente importante per quanto riguarda il metodo (i termini dell’accordo verranno ridiscussi ogni 5 anni a partire dal 2023), gli accordi di massima (“ben al di sotto dei 2°C” accettando come soglia ottimale 1,5°C) e il fatto di essere realmente globale. Tuttavia, rimane il fatto che gli impegni presi singolarmente e su base volontaria dai vari Stati erano e sono insufficienti (cioè produrrebbero un aumento di 3-3,5°C della temperatura media). La lentezza delle COP ci interroga sulla loro efficacia: è così necessario un unico luogo decisionale ben determinato, che sia lo snodo della politica globale sul cambiamento climatico? E se è necessario, qual è il meccanismo adatto a farlo funzionare?
Per quanto riguarda la prima domanda, è difficile immaginare una risposta sistemica e concordata tra tutti i paesi senza che vi sia un annuale appuntamento preposto a questo. Il problema, forse, è che le COP creano sì un giusto momento per decisioni importanti, ma l’occasione viene sistematicamente sprecata e le decisioni disattese. Pensiamo al caso del Green Climate Fund, un fondo di 100 miliardi di dollari all’anno finanziato dalle nazioni industrializzate per lo sviluppo sostenibile degli altri paesi: un’idea fondamentale per la giustizia climatica e per alleggerire il rischio di frizioni che si creano nei paesi emergenti tra sviluppo economico e sostenibilità. Questo, però, rimane ampiamente sotto-finanziato: a novembre 2017 ha raccolto 10,1 miliardi di dollari, con l’obiettivo di arrivare a 100 nel 2020 ancora molto lontano; inoltre, nel 2015 aveva fatto scandalo il fatto che gli organi che gestiscono il fondo non avessero approvato il divieto di investire nelle fonti fossili: almeno in teoria, il Green Climate Fund potrebbe finanziare una centrale a carbone. Questo senza considerare l’impietoso confronto con i sussidi alle fonti fossili nel mondo: 5’000 miliardi di dollari, 50 volte il fondo a pieno regime.
Le criticità delle COP chiamano in causa moltissimi fattori: uno dei problemi principali, forse, è il fatto di aver istituito luoghi dove non è possibile introdurre fattori di movimento o sviluppare critiche fuori da schemi prestabiliti. Occasioni che, per quanto necessarie, finiscono spesso per fossilizzarsi nel solo esercizio diplomatico senza risvolti propriamente politici. Da una parte, viene assegnato un posto preciso ai governi dei vari paesi, vengono selezionate le ONG che possono partecipare al meccanismo del Sussidiary Body of Implementation (SBI) e viene riservato un posto alle aziende che si occupano di sostenibilità ambientale (come nei Sustainable Innovation Forum, SIF). Dall’altra, si costringe la rete dei movimenti carbon-free dal basso a rimanere sempre all’infuori delle conferenze e, se non espressamente contro, sicuramente in contrapposizione a quello che avviene all’interno di quei luoghi decisionali.
E Bonn? Nella settimana della COP23 e nel weekend ad essa precedente, la città è animata da manifestazioni e workshop. La Marcia per il Clima del 4 Novembre ha visto la partecipazione di 25’000 persone appartenenti a realtà di tutto il mondo; dal 3 al 7 è stato organizzato il People’s Climate Summit, parallelo al Summit ufficiale; l’11 sarà la volta di una parata contro i combustibili fossili. Tra i principali animatori di queste iniziative c’è Ende Gelaende, il gruppo di attivisti tedeschi che a Maggio 2016 ha bloccato una miniera di carbone a cielo aperto, a 50 km dalla stessa Bonn: uno dei simboli della campagna globale per il disinvestimento dalle fonti fossili.
Questo fermento non si oppone agli accordi sul clima e, anzi, potrebbe rivitalizzarli se non venisse marginalizzato o addirittura silenziato, come successo alla COP di Parigi, quando la Marcia per il Clima fu vietata per questioni di sicurezza e gli attivisti risposero con marce sparse in tutto il mondo (con la partecipazione, comunque, di ben 600’000 persone). D’altra parte, quel pezzo di attivismo ambientalista è quanto di più lontano dalle dichiarazioni di Erik Solheim, direttore esecutivo di UN Environment, visibili sulla home del SIF della COP23: “Dobbiamo provare che proteggere l’ambiente sia redditizio (profitable) e nell’interesse di tutti […]”. Appena sotto, infatti, scorrono le inserzioni di tutte le aziende sponsor, alcune delle quali operano sì nell’innovazione, ma quella dei combustibili fossili. In contrapposizione a questo clima di pacificazione e di assoluzione, c’è un fiume di persone, impegnate costantemente a rendere l’economia più sostenibile, che appoggia la necessità di togliere ossigeno finanziario alle aziende che estraggono e distribuiscono combustibili fossili. Se le Parti delle COP pensano di non essere in grado di opporsi agli interessi di multinazionali spesso più ricche di interi paesi (e che regolarmente inquinano anche le trattative), dovrebbero considerare che possono trovare una riserva di energie politiche fuori da quelle conferenze.