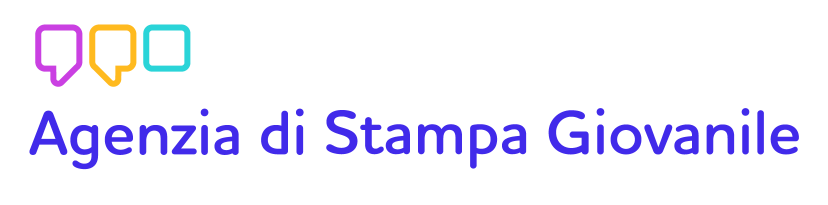Chiamatemi col mio nome (parte 3)
Per concludere la nostra rubrica abbiamo deciso di esporre le opinioni che ci siamo fatte sul tema del linguaggio di genere.
Confrontandoci ci siamo rese conto che anche solo tra noi tre le idee differiscono e questa è l’ulteriore conferma di quanto sia ampia e complessa la questione, ma proprio questa eterogeneità di pareri è un fattore importante. Condividendo con voi la nostra opinione vorremmo dimostrare che realtà di pensiero diverse possono coesistere e magari stimolare una riflessione che puó portare ad un accordo comune.
Valeria: Se l’obiettivo è quello di raggiungere la parità di genere, l’uguaglianza, o meglio, l’eguaglianza tra uomo e donna, perché differenziare i due sessi nel lessico? Non sarebbe più corretto riconoscere in uno stesso termine sia l’uomo sia la donna, proprio per sottolineare che non ci sono differenze?
Ebbene io ritengo che, soprattutto per i ruoli istituzionali, vi sia più parità nel chiamare con lo stesso nome la persona, uomo o donna che sia, che ricopre quella determinata carica.
La società è cambiata e le donne hanno raggiunto oggi livelli di parità mai raggiunti prima, ma il problema della parità rimane nel cambiamento della mentalità che fatica ad affermarsi. La società deve accettare e seguire i successi ottenuti dalle donne in questi decenni, e il problema si risolverà non tanto quando inizieremo a usare un termine al femminile per indicare ruoli prima prevalentemente maschili, ma quando uno stesso termine al maschile, o femminile che sia, rimanderá nella nostra mente l’idea di una donna che svolge quel mestiere tanto quanto ci rimanda l’idea di un uomo che lo svolge.
Rachele: Personalmente io credo che il sessismo nella lingua italiana sia una realtà esistente seppur malcelata. Oltre agli innumerevoli studi sul genere femminile nella lingua italiana sviluppati da Alba Sabatini prima e da Cecilia Robustelli poi, nel 1996 il noto linguista e filologo Luca Serianni, portavoce dell’Accademia della Crusca, sosteneva che “è inevitabile un processo linguistico in fieri come il riassestamento maschile-femminile nei nomi professionali” pur ammettendo che sul mancato successo delle forme femminili “incide anche il fatto che molte donne avvertano come limitativa la femminilizzazione coatta del nome professionale”. E’ curioso che dopo due decenni la questione ancora non sia mutata di molto. Io stessa posso appurare che viene ancora percepito all’interno della lingua un notevole imbarazzo e disagio, una terribile incertezza nel parlato, ed anche una sorta di ribrezzo nei confronti di parole (semplicissime) declinate al femminile che vengono percepite come “strane”. Non si spiegherebbero altrimenti questi vergognosi commenti ed insulti di matrice sessista che appaiono come l’indice di un Paese in cui la misoginia dilaga in maniera preoccupante. Secondo me questa “battaglia” linguistica potrebbe essere in grado di rivestire un peso simbolico notevole sul cambiamento della percezione delle donne nella società. Quello che alla visione retrograda di Sgarbi, Napolitano e altri sfugge è che la lingua non è stata scolpita in nessuna tavola della legge da nessuna divinità e se cominciano ad emergere esigenze sociali nuove la lingua può essere cambiata. Fin da piccola mi ricordo che non riuscivo a capire fino in fondo perchè in alcune parole maschili non esisteva il corrispondente femminile? Perchè si dice maestro-maestra e non capo-capa? Ora lo so. La lingua riflette, riproduce e rinforza ancora una cultura che riconosce una maggior valenza agli uomini rispetto alle donne. Una cosa che, però, ho imparato dai miei studi di linguistica è che la lingua, per fortuna, non fa parte di un meccanismo cristallizzato, statico, al contrario muta continuamente insieme a noi, è una manifestazione della realtà. Dove sta scritto che tradizione ed innovazione non possano convivere? E quanti neologismi ogni giorno accettiamo senza prendercela? Un uomo chiamato come una donna spesso può sentirsi inferiorizzato, disconosciuto nella propria identità mentre invece molti uomini e donne pensano che una donna chiamata come un uomo si senta più valorizzata, come se la propria identità fosse motivo di difetto. La lingua rende l’essere umano una creatura speciale e i suoi strumenti sono le parole. Strumenti che vanno usati in modo giusto ed avendone cura, specialmente se hanno un genere maschile e femminile. Perchè, come diceva il mio tanto amato Nanni Moretti: “Le parole sono importanti”.
Rosa: La mia visione del problema è molto tranquilla: come ragazza non sento la necessità di battermi con forza per uno o l’altro schieramento, non sono nè totalmente pro e nè totalmente contro. Ciò su cui ho sempre riflettuto è che, per me, la cosa più importante da sottolineare quando si parla di impiego o ruolo di una persona all’interno della società non è il suo sesso bensì la sua mansione, la sua professionalità. Per questo, non trovo necessaria un’azione di inserimento artificioso di termini non appartenenti al lessico italiano. Penso, invece, che per quanto riguarda quelle occupazioni per cui non esiste nel vocabolario italiano un termine al femminile basterebbe cambiare la definizione del termine maschile in “colui/colei esercita una tale professione”. Mettendo in risalto la figura professionale senza necessariamente specificarne il sesso, si vanno a conferire una serie di caratteristiche base all’individuo interessato che non sono minimamente condizionate dal suo genere. Questo, per me, è un risultato più vicino alla parità di genere rispetto a qualunque inserimento linguistico forzato e tanto dibattuto.
Speriamo che le nostre ricerche e opinioni in merito vi siano state utili e interressanti per prendere coscienza di uno dei più attuali dibattiti sul genere, nel nostro Paese ma non solo. E ora, voi, cosa ne pensate?